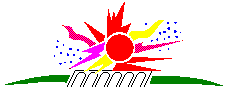
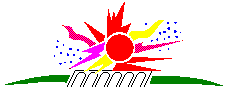
|
LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE: IL CASO DEI FONDI STRUTTURALI EUROPEI - R. Cecchi, D. Verdesca (Associazione Ambiente e Lavoro Toscana - ONLUS)Obiettivi e finalità - Procedure di valutazione - Il DOCUP FESR della Regione Toscana ed i criteri di selezione - Valutazione Ambientale Strategica ed integrazione risultati Obiettivi e finalità Il 24 e 25 marzo 1999, a Berlino, il Consiglio d’Europa ha approvato "Agenda 2000", accordo di previsioni e strategie finanziarie dell’Unione Europea, per il periodo 2000 – 2006. All’interno di questo accordo sono stati definiti i Regolamenti necessari alla gestione dei Fondi Strutturali, della Politica Agricola Comune, e degli strumenti per iniziare il processo di adesione alla UE dei nuovi paesi dell’Est. Il 21 giugno 1999, Il Consiglio d’Europa ha definitivamente approvato il Regolamento dei Fondi Strutturali, apportando due significative semplificazioni:
In questo quadro di programmazione, e sulla base delle esperienze sviluppate negli anni precedenti, il Consiglio d’Europa ha voluto dare particolare rilievo ed importanza alle procedure di valutazione e controllo. Questo perché la nuova cultura della programmazione deve affrontare scenari non più stabili, ma in continuo e rapido mutamento, in cui la complessità dei fattori da prendere in considerazione è andata aumentando in modo esponenziale. E’ stato perciò ritenuto necessario affrontare la programmazione con un nuovo approccio metodologico:
All’interno di questo sistema dinamico di programmazione–valutazione, il Consiglio d’Europa ha inserito la Valutazione Ambientale Strategica, denominata VAS. Obiettivo della VAS è quello di valutare ambientalmente Piani e Programmi, al fine di implementare e monitorare le sinergie positive realizzabili fra le priorità di sviluppo economico con quelle dell’ambiente. Finalità ultima della VAS è la verifica della rispondenza dei Piani di sviluppo e dei Programmi operativi con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, verificandone il complessivo impatto ambientale, ovvero la diretta incidenza sulla qualità dell’ambiente; il processo di valutazione mira quindi a rendere leggibili le pressioni più rilevanti per la qualità ambientale, derivanti dalle scelte di programmazione e pianificazione. Ulteriore obiettivo della VAS è quello di integrare i principi di sviluppo sostenibile all’interno dei processi di concertazione e programmazione. Lo scopo è quello di far si che economia ed ambiente vengano governati come un unico sistema, dove la valorizzazione e la protezione delle risorse locali porti significativi effetti nel campo dell’occupazione e dell’evoluzione qualitativa del sistema delle imprese. Integrazione che deve comunque soddisfare le condizioni di sostenibilità nell’uso delle risorse ambientali, sintetizzabili nei seguenti principi:
A conferma di questa impostazione, il Regolamento della UE definisce un unico processo di valutazione e monitoraggio, in cui, oltre agli obiettivi ed ai risultati occupazionali ed economici, sono presenti quelli ambientali. Procedure di valutazione Il Regolamento approvato dal Consiglio d’Europa il 21 giugno 1999, articola La Valutazione Ambientale Strategica (VAS), in tre specifiche fasi:
La valutazione ex ante serve a preparare e ad adottare i piani, dei quali è parte integrante. Essa valuta la situazione ambientale delle aree oggetto degli interventi, le disposizioni volte a garantire il rispetto della normativa comunitaria in materia di ambiente, i criteri e le modalità per l’integrazione delle tematiche ambientali nelle Misure e nelle Azioni dei Fondi Strutturali. La valutazione in itinere serve a ponderare i primi risultati degli interventi realizzati. Essa valuta la coerenza con la valutazione ex ante, la pertinenza degli obiettivi e il grado di conseguimento degli stessi; valuta altresì la correttezza della gestione finanziaria nonché la qualità della sorveglianza e della realizzazione. La valutazione ex post serve a verificare i risultati ottenuti dall’impiego delle risorse economiche comunitarie. Essa valuta l’efficacia e l’efficienza degli interventi, il loro impatto, la coerenza con la valutazione ex ante; essa valuta altresì i successi e gli insuccessi registrati nel corso dell’attuazione, nonché le realizzazioni ed i risultati, compresa la loro prevedibile durata. Tutte le procedure di valutazione sono comunque volte a determinare l’impatto rispetto agli obiettivi dei Fondi Strutturali e dei Piani Regionali di Sviluppo, e ad analizzare le incidenze su problemi strutturali specifici del territorio ammesso ai finanziamenti. Nell’ambito del processo di elaborazione, valutazione e monitoraggio dei Piani e Programmi, il soggetto preposto allo svolgimento di quanto previsto dal Regolamento UE è l’Autorità Ambientale Locale (AA), individuata – su decisione della Giunta Regionale della Toscana – nell’Area extradipartimentale "Sviluppo sostenibile e controllo ecologico". L’Autorità coopera nella redazione dei Documenti Unici di Programmazione (DOCUP), con l’obiettivo di attuare la sequenza procedurale prevista di Regolamenti del FESR:
Il DocUP FESR della Regione Toscana ed i criteri di selezione A fine aprile 1999 è stata sottoposta all’attenzione dell’Autorità Ambientale Regionale la bozza del Documento Unico di Programmazione (DOCUP) FESR, elaborato della Regione Toscana. Per gli altri due DocUP, quello FEOGA e quello FSE, si sono posti problemi in parte diversi, ma resi più semplici dall’esperienza sul DocUP FESR, che converrà affrontare in altra sede. A fronte del documento presentato, l’Autorità ha sviluppato le sue valutazioni, proponendo alla Regione le soluzioni che portassero ad un raccordo tra le politiche di sviluppo economico e la riduzione delle pressioni sul sistema ambientale. Le soluzioni proposte dall’Autorità prendono origine dal livello di definizione operativo degli Assi del DOCUP, e soprattutto delle Azioni previste; queste infatti non presentano un dettaglio tale da permettere di valutare con chiarezza quelli che potrebbero essere gli effetti sull’ambiente delle scelte di programmazione. Di conseguenza, in un ottica di:
L’Autorità Ambientale ha proposto alla Regione una serie di criteri premiali per la selezione dei progetti, al fine di privilegiare tutti quelli che presentino spiccate caratteristiche di riduzione delle emissioni inquinanti e del consumo di risorse ambientali locali. Definire i criteri per la valutazione e la selezione dei progetti presentati è, secondo il parere dell’Autorità Ambientale, uno degli strumenti più efficaci e chiari per esplicitare quali sono le strategie prescelte dalla programmazione regionale e, soprattutto, il modello di sviluppo locale che si è inteso adottare. Con questo approccio, all’interno del DOCUP, viene specificato sia quali sono i settori tematici di sostegno allo sviluppo in cui si vuole intervenire (Sostegno alle PMI, Riqualificazione del territorio, Ambiente), ma anche e soprattutto quali sono le caratteristiche sulla base delle quali verranno selezionati i progetti. Questo permette di garantire un orientamento dei processi di mercato rispetto agli obiettivi ed ai risultati attesi dal programmatore. I tre criteri delineati dall’Autorità, mirati a promuovere effetti positivi per il settore ambientale (in sinergia con quelli occupazionali ed economici), sono i seguenti:
Il primo criterio ha come obiettivo quello di privilegiare quei progetti che abbiano le caratteristiche di:
Questo criterio ha come finalità strutturale il superamento della frammentazione del tessuto produttivo locale, incidendo positivamente sui fattori di emergenza ambientale. Questo perché solo con un adeguata "massa critica di progetto" (tecnica, finanziaria, di soggetti) è possibile intervenire sugli elementi strutturali degli inquinamenti e dell’uso delle risorse (fare sistema); le PMI non hanno infatti la "scala dimensionale" tale da poter reggere investimenti ed interventi che vanno oltre la portata del loro raggio di azione economico e di ruolo. Inoltre, è pur vero che le maggiori emergenze ambientali regionali sono concentrate in specifici distretti e/o poli industriali, ma è anche vero che sono quelle con la migliore rete di monitoraggio e con un flusso di investimenti effettuato ben più ampio di quello riscontrabile presso i Sistemi Economici Locali (SEL) a predominanza di piccola e media impresa. Il secondo ed il terzo criterio sono strettamente interrelati, ed hanno come obiettivo quello di privilegiare quei progetti che abbiano le caratteristiche di riduzione degli inquinamenti e dell’uso delle risorse ambientali locali. Selezionare i progetti presentati sulla base delle loro performance ambientali (dalla riduzione degli inquinamenti alla certificazione ambientale) è l’approccio di metodo che maggiormente garantisce il supporto agli interventi di sviluppo con il minor livello di pressioni ambientali e le maggiori ricadute occupazionali. Va comunque segnalato che questo criterio delle performance non garantisce automaticamente la sostenibilità dello sviluppo; questo è frutto solo di un accordo generale dei diversi protagonisti delle trasformazioni e del territorio (concertazione tramite strumenti come l’Agenda 21) su quali sono gli obiettivi da raggiungere (economici, ambientali, occupazionali), indipendentemente dagli standard normativi o dal rendimento della "macchina produttiva e/o urbana". E’ proprio in questa esigenza di contestualizzazione che si inserisce il terzo criterio delle priorità ambientali locali; è di particolare rilevanza l’attribuzione di priorità a quei progetti che, oltre a garantire buone performance ambientali, vadano ad incidere su quella che è un’emergenza ambientale preponderante nel territorio in cui si inseriscono. Risulta inoltre corretto individuare l’emergenza in termini di "preponderanza"; non è infatti possibile stabilire in modo univoco il peso e l’importanza di ogni fattore ambientale per ogni diverso Sistema Economico Locale (SEL). Sarà quindi compito del programmatore, così come stabilito nel DOCUP, procedere ad una verifica dell’efficacia e della validità nel tempo della scelta effettuata; utilizzando gli strumenti della concertazione e della sussidiarietà. La proposta di questi tre criteri di selezione premiale dei progetti è uno degli elementi di maggior forza della procedura di VAS adottata dall'Autorità Ambientale. Questo in virtù di tre elementi:
Valutazione Ambientale Strategica ed integrazione risultati Sulla base di quanto descritto nei punti precedenti, ed in forza dell'approccio collaborativo tenuto dall'Autorità Ambientale nel processo di costruzione del DOCUP, la VAS non esprime un giudizio positivo per quel che riguarda l'integrazione dei fattori ambientali nelle scelte di programmazione. Questo per tre fattori:
Sebbene il giudizio della VAS sull'integrazione sia positivo, non altrettanto certi possono essere gli effetti ambientali che Assi ed Azioni potranno sviluppare. Infatti, a seguito dell'analisi sviluppata dall'Autorità Ambientale sulle possibili ricadute degli indirizzi presenti negli Assi e nelle Azioni, è risultato evidente come molti siano i temi ambientali che potrebbero essere influenzati dalla caratteristiche progettuali ammesse al finanziamento. A causa delle caratteristiche del DOCUP, non è però possibile sviluppare una VAS che formuli con certezza un giudizio positivo o negativo su queste possibili influenze*. * E' possibile definire un giudizio valutativo positivo esclusivamente per l'Asse 3, denominato "Ambiente". Questo perché gli obiettivi dei progetti ammessi al finanziamento sono mirati esclusivamente alla riduzione delle pressioni ambientali per i diversi settori in cui intervengono (depurazione, rifiuti, energie rinnovabili, aree da bonificare, rischio idraulico, etc.).Dalle considerazioni precedenti sulla certezza delle influenze dei progetti sui temi ambientali, ma sull'impossibilità operativa a formulare un giudizio VAS (positivo o negativo) sugli stessi, deriva la necessità strategica per cui il DOCUP individui un "filtro" che permetta di garantire preventivamente un adeguato livello di certezza nella linea di demarcazione tra effetti positivi ed effetti negativi. Un criterio aggiuntivo per orientare i proponenti sulle tipologie e sulle caratteristiche dei progetti da presentare, è sicuramente quello dell’ammissione al finanziamento. Ciò comporta, da parte del soggetto regionale un’azione di orientamento del mercato, con effetti positivi sui sistemi ambientali e di competitività. I progetti presentati potranno perciò avere accesso alle procedure di selezione e finanziamento se e solo se:
- il progetto porterà ad una riduzione dell'inquinamento ed alla riduzione del rischio lavorativo; - il progetto abbia considerato il contenimento delle pressioni ambientali; - il macchinario acquisito, sia con marchio CE e porti ad una riduzione del rischio lavorativo. Nel caso di nuovi progetti, di riattivazione di siti o riconversione di produzione, il proponente(i) dovrà autocertificare che "a regime" l'azienda o l'impianto avrà la certificazione di qualità ambientale (ISO 14000) o aderirà al regolamento EMAS (per quelle attività produttive ammesse). Nel caso di progetti relativi ad impianti e/o strutture già esistenti, il proponente(i) dovrà autocertificare che la differenza tra il bilancio ambientale dell’esercizio a "regime" con quello "precedente" presenta un valore negativo (si producono meno inquinanti, rifiuti, etc.). Nel caso di progetti che non abbiano impatti ambientali rilevanti o riguardino attività terziarie e/o terziarie avanzate, il proponente(i) dovrà autocertificare che:
Nel caso di solo acquisto di macchinari o riqualificazione di siti o manufatti per attività terziarie o turistiche, il proponente(i) dovrà autocertificare:
I vantaggi di questo approccio sono sintetizzabili in tre punti:
Se questo criterio di selezione dovesse essere integrato nei Complementi di Programmazione per la selezione dei progetti da ammettere ai finanziamenti, il giudizio finale della VAS non potrà che essere positivo. |