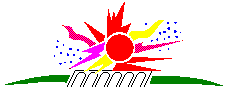
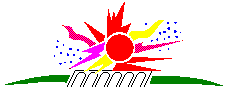
![]() Ambiente e Lavoro Toscana - CGIL Toscana
Ambiente e Lavoro Toscana - CGIL Toscana
Le risorse energetiche per lo sviluppo sostenibile della Toscana e l'occupazione
Paper "Energia 1998"
Qui di seguito viene riportato l'abstract della pubblicazione realizzata da ALT e CGIL Toscana; per chi fosse interessato ad un approfondimento, presso la sede di ALT sono ancora disponibili alcune copie integrali (cartacee).
Indice:
Abstract - Presentazione - Premessa. Energia per il futuro: le fonti energetiche rinnovabili - Uso corretto dell'energia, risparmio energetico e occupazione - La programmazione delle risorse locali - La dimensione energetica della pianificazione urbana: l'esperienza del piano del Comune di Livorno - Le fonti energetiche rinnovabili in provincia di Grosseto. Uno studio di caso - Consumi energetici e andamento occupazionale - La geotermia in Toscana come occasione di sviluppo sostenibile locale - Progetto di investimento di ristrutturazione edilizia ed energetica per ridurre l'inquinamento e creare nuovo lavoro.
Appendice:
Il sistema energetico toscano (ALT) - Stato dell'arte sulle tecnologie disponibili per il trattamento delle biomasse (ARRR) - Progetto geotermia (ARPAT) - Tabelle - Glossario essenziale.
ABSTRACT
Il soddisfacimento del fabbisogno energetico toscano è caratterizzato per la quasi totale dipendenza da fonti energetiche esterne alla regione e dalla insostenibilità del sistema energetico regionale.
Il fabbisogno energetico nel 1981 in Toscana è stato stimato a 9,3 milioni di tep (Irpet, 1993), soddisfatto al 90,7% con fonti primarie non rinnovabili e per il restante 9,3% con fonti rinnovabili (vegetali, energia idroelettrica, energia geotermoelettrica); parallelamente lo stesso fabbisogno è stato soddisfatto all'88% con fonti esterne alla regione e per il 12% con fonti interne. Dieci anni più tardi, nel 1991, il fabbisogno è salito a 10,7 milioni di tep, soddisfatto al 90,9% con fonti non rinnovabili e per il 9,1% con fonti rinnovabili; le fonti esterne alla regione hanno costituito l'89,1% del totale delle fonti utilizzate. Nel 1996, ultimo dato disponibile (fonte ENEA), il bilancio dei consumi delle fonti primarie (non rinnovabili) è salito a 7,9 milioni di tep rispetto ai 7,4 milioni di tep del 1990. Nello stesso periodo le fonti esterne alla regione hanno costituito oltre il 90% del totale delle fonti utilizzate: tutto ciò nonostante sia aumentata l'efficienza della produzione termoelettrica con l'introduzione della cogenerazione soprattutto tra gli autoproduttori. Tra il 1995 e il 1997 periodo in cui sono state attivate importanti centrali di cogenerazione (calore + energia elettrica), il consumo di metano è passato dai 3,5 milioni di m3 del 1995 ai 4 milioni di m3 del 1997. In queste tre centrali di autoproduzione l'efficienza energetica aziendale è passata da circa il 30% a quasi il 50% senza con questo contribuire ad aumentare la disponibilità energetica per lo sviluppo locale ne tantomeno l'occupazione di quegli stessi territori. Nonostante l'aumento dell'efficienza aziendale, anzi proprio in virtù di questa, è calata l'efficienza energetica regionale per l'aumento della dipendenza da fonti energetiche esterne (metano).
La struttura del sistema energetico e della sua evoluzione, da questi dati, risultano quindi fortemente orientate verso l'insostenibilità e allo stesso tempo verso una elevata dipendenza dall'esterno.
L'obiettivo esplicito, quindi, a cui si è indirizzato il modello di sviluppo industriale nel corso del tempo è stato quello di puntare ad aumenti di produttività, aumenti che realizzando extraprofitti avrebbero dovuto determinare investimenti e quindi nuova occupazione.
In realtà è lecito mettere in dubbio questo schema di riferimento sia perchè, a fronte di incontestabili aumenti nella produttività per addetto, non si è determinato un aumento di occupazione (ma anzi una netta riduzione), sia perchè l'aumento di produttività per addetto si è accompagnato ad un aumento del consumo di energia, e quindi con una sostituzione di lavoro con energia.
E' dimostrato, invece, che ai fini dello sviluppo sostenibile regionale e nazionale (economia ecologica e sviluppo locale) è necessario che le attività produttive (primarie e secondarie) e le attività di servizio (alle imprese, alle comunità locali e alle persone) siano orientate all'allargamento degli occupati.
L'orientamento dell'innovazione scientifica e tecnologica che discende tutt'ora da scelte tecniche, economiche e culturali del secolo scorso rende difficile questa opzione forte: la tecnologia serve ancora e soprattutto per risparmiare forza-lavoro per unità di prodotto. Il perdurare di tale situazione fa si che la tecnologia attuale (a partire da quella delle fonti e degli impieghi energetici) presenti rendimenti decrescenti in termini d'occupazione, producendo in altre parole una disoccupazione che non è più congiunturale. Per affrontare tale questione occorre affrontare il complesso delle innovazioni da portare ai prodotti, ai mercati e alle stesse scelte che stanno alla base della tecnologia e delle sue applicazioni. Occorre attivare iniziative per concepire tecnologie - molto avanzate - che comportino una più alta intensità di lavoro. Si tratta in pratica di agire sul versante delle tecnologie di produzione (ricerca, sviluppo e applicazione) e del rapporto che queste intrattengono con l'ambiente, il territorio, l'energia, l'agricoltura.
L'impiego di risorse energetiche rinnovabili (compreso risparmio e uso corretto dell'energia), per essere realistico, necessita di una valutazione sullo stato di sviluppo industriale e tecnologico di una nazione o di una regione o di un settore. L'industria italiana, negli anni ottanta e novanta, è stata caratterizzata dal consolidamento della specializzazione nei settori tradizionali (ciò vale in particolare per la Toscana) e da un indebolimento della struttura industriale. Senza riaprire l'inutile diatriba a favore a sfavore dei settori tipici o dell'high-tech, va registrato che lo sviluppo di un'industria senza tecnologia ha avuto effetti negativi sull'occupazione. Non si tratta ne' di comprimere la produzione di beni di consumo ne' di concentrare tutte le politiche di sviluppo nei settori ad alta tecnologia, ma di prendere atto che politiche nazionali o regionali o locali fortemente squilibrati in un senso in un altro si manifestano come deboli nelle nuova divisione internazionale del lavoro.
Un apparato industriale così fatto, alla ricerca della massima produttività attraverso la riduzione di occupati, senza ricerca e sviluppo orientati alla crescita dell'impiego del fattore umano, non può che rigidamente attardarsi su una struttura energetica scarsamente differenziata dove la ricerca del massimo rendimento è ottenuta soltanto all'interno delle tecnologie di termocombustione e di ciclo combinato, scartando tutte le altre opzioni che le singole realtà locali o regionali possono offrire a costi altrettanto vantaggiosi se usate in loco e appropriatamente. Si tratta allora di avviare una inversione di tendenza in cui, localmente, le risorse energetiche rinnovabili debbono trovare la giusta considerazione.
Più in generale, una tale politica non può che prevedere finanziamenti e sostegni (sgravi fiscali e quant'altro sia in grado di agire positivamente sul margine operativo delle imprese) la ricerca la sperimentazione, l'applicazione e la diffusione di tecnologie per la produzione di utilità attraverso tecniche avanzate (efficaci ed efficienti: a basso costo di esercizio per unità di manodopera impiegata) e l'impiego di maggiore occupazione.
Attualmente, a fronte del bassissimo costo del petrolio, un sistema di produzione energetico o di riscaldamento, ecc., basato sull'aumento dell'uso delle fonti energetiche rinnovabili rispetto ad uno tutto convenzionale (termoelettrico, cogenerazione, ecc.) costa di più e i tempi di recupero sono estremamente lunghi nonostante la considerevole riduzione dei costi operativi. Questo è uno dei motivi per cui gli investimenti, in questo campo, sono prevalentemente pubblici e non da parte di aziende private.
Per ridurre i costi di impianto delle fonti rinnovabili è necessario ridurre al minimo i tempi di realizzazione (ravvicinare il più possibile il flusso di cassa alla decisione di fare l'impianto). Più si allungano i tempi di decisione meno l'investimento diventa conveniente.
Nel raffronto fra i costi al kWh prodotto mediante i sistemi ad energia rinnovabile e quelli tradizionali alimentati a combustibile fossile, va tenuto conto dei costi medi di impianto, del costo di gestione e manutenzione, delle spese dovute alla progettazione, opere civili e manodopera.
Ma per raggiungere l'obiettivo che le fonti energetiche rinnovabili, compreso risparmio e uso corretto dell'energia, superino almeno la soglia del 20% del totale, non basta avanzare proposte di carattere tecnologico, occorre intervenire anche sui meccanismi finanziari, non solo per trovare i capitali necessari all'investimento, ma anche per evitare di penalizzare l'innovazione tecnologica, poiché le tecnologie più efficienti, pur essendo economicamente più convenienti (cogenerazione, pompe di calore, cicli combinati e a cascata, ecc.) sono state poste fuori mercato dal sostegno finanziario dato a quelle meno efficienti (solare ed eolico), come accade tutte le volte che all'incentivo della concorrenza si sostituisce l'incentivo drogato dei finanziamenti agevolati.
D'altro canto i bassi prezzi dell'energia scoraggiano gli investimenti di razionalizzazione e risparmio energetico, mentre a livello di massa le attrattive delle politiche di risparmio energetico sono state fortemente ridotte dall'idea (sbagliata) che il risparmio o la riduzione della potenza energetica prodotta significasse una riduzione dei consumi finali, cioè del benessere.
Con la conferenza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite su "Ambiente e Sviluppo" (UNCED) tenuta a Rio de Janeiro nel giugno 1992 con la partecipazione di 183 paesi e con la conferenza di Kyoto su "Clima" del dicembre 1997 con la partecipazione di 150 paesi si è rafforzata la strategia di integrare le questioni economiche e quelle ambientali in una visione intersettoriale e internazionale, definendo strategie ed azioni per lo sviluppo sostenibile.
I partecipanti alla UNCED hanno concordato fra l'altro, su un piano di azione per specifiche iniziative economiche, sociali ed ambientali in vista del XXI secolo (Agenda XXI).
L'Agenda XXI afferma che: " i governi... dovrebbero adottare una strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile. Tale strategia dovrebbe essere predisposta utilizzando ed armonizzando le politiche settoriali. L'obiettivo è quello di assicurare uno sviluppo economico responsabile verso la società, proteggendo nel contempo le risorse fondamentali e l'ambiente per il beneficio delle future generazioni. Le strategie nazionali per lo sviluppo sostenibile dovrebbero essere sviluppate attraverso la più ampia partecipazione possibile e la più compiuta valutazione della situazione e delle iniziative in corso".
L'Italia ha aderito a questa impostazione, prima, attraverso il "Piano nazionale per lo sviluppo sostenibile in attuazione dell'Agenda 21" che è stato approvato dal CIPE il 28/12/1993, successivamente, con il piano esaminato dal Cipe il 22 ottobre 1998.
E' evidente perciò che lo strumento fondamentale per la gestione degli obiettivi di sostenibilità e il coordinamento delle politiche settoriali ed energetiche definiti a Rio de Janeiro e a Kyoto è costituito dalla Agenda XXI nazionale e dalle Agende XXI locali.
Ma è altrettanto evidente che le questioni dello sviluppo sostenibile hanno stretta attinenza con le questioni del lavoro e dell'occupazione: perciò a questa logica vanno ricondotte le politiche energetiche e del lavoro attraverso momenti di raccordo tra Agende XXI locali e Patti territoriali per lo sviluppo e l'occupazione o altri strumenti per l'occupazione come i Contratti d'Area.
Le agende XXI locali
Se l'Agenda rappresenta lo strumento per attuare i contenuti dello sviluppo sostenibile, le Agende locali rappresentano la struttura attraverso la quale gli obiettivi globali sono tradotti in azioni locali. Inoltre l'Agenda locale, tramite la partecipazione delle comunità locali, è l'anello fondamentale nella catena del processo di cambiamento invocato dallo sviluppo sostenibile: le azioni intraprese a livello locale verso la sostenibilità hanno una forza ben maggiore di quella fornita sulla carta dai negoziati internazionali.
E' questo l'approccio "dal basso verso l'alto": le soluzioni sperimentate a livello locale da comunità diverse in diverse parti del mondo (con l'obiettivo della sostenibilità) integrano e arricchiscono la visione programmatica definita a livello internazionale.
Principi guida per la predisposizione di Agende XXI locali:
A fianco di questi elementi, rispetto al lavoro che devono svolgere le amministrazioni locali è utile riportare il seguente schema, basato su fasi successive:
SFERA TECNICA SFERA DEL DIALOGO
Azioni interne Azioni nella comunità
Progressivo aumento di difficoltà nel realizzare l'azione:
Questo schema è basato su passi successivi, che devono essere compiuti dall'ente locale nel processo di definizione dell'Agenda locale. Questi passi sono suddivisi in due fasi principali: quella tecnica che richiede azioni all'interno dell'ente locale stesso, e quella del dialogo che richiede invece azioni da attuarsi nel contesto della comunità locale.
La seconda fase è sicuramente più difficoltosa della prima, come indicato dal verso della freccia, ma è ritenuta anche la fase più importante. In essa si tratta appunto di stabilire un dialogo con la comunità (nella sua accezione più ampia possibile) con lo scopo di determinare forme di stretta collaborazione, concertazione e consenso. In questo ambito si aprono spazi per nuove forme di concertazione, che abbandonino gli usuali schemi verticali per abbracciare un'ottica orizzontale.
La partecipazione è infatti un requisito fondamentale per assicurare la buona riuscita dei cambiamenti ai modi di vita necessari per raggiungere lo sviluppo sostenibile.
D'altra parte è utile considerare anche gli ostacoli che si frappongono alla realizzazione di un simile processo.
Analogie tra agenda XXI locale e patto territoriale
Sia l'Agenda XXI locale che il Patto Territoriale ( così come i Contratti d'area) possono essere definiti come accordi promossi da enti locali, parti sociali o da altri soggetti, pubblici o privati, relativi all'attuazione di un programma di interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale. Garantire l'ecosostenibilità dello sviluppo locale costituisce il movente fondamentale per l'elaborazione di un'Agenda XXI, ma viene individuato anche come uno degli elementi che devono caratterizzare il Patto Territoriale.
Un'ulteriore elemento di forte analogia tra i due strumenti pianificatori è l'importanza attribuita alla concertazione tra le parti sociali nelle procedure di attivazione e di definizione degli obiettivi da perseguire. In entrambi gli strumenti stabilire un dialogo con la comunità (nella sua accezione più ampia possibile) con lo scopo di determinare forme di stretta collaborazione, concertazione e consenso è infatti ritenuto un requisito essenziale del processo di elaborazione.
Sulla base di tali considerazioni, risulta auspicabile l'integrazione tra il progetto di elaborazione di un'Agenda locale e i progetti di Patto Territoriale; la sperimentazione di un'Agenda XXI potrebbe costituire uno dei progetti finanziabili, all'interno del patto.
Oltretutto l'inserimento dell'Agenda XXI nel contesto più ampio del Patto Territoriale contribuirebbe a garantire uno degli elementi fondamentali per l'implementazione dell'Agenda stessa: la prospettiva globale. Al fine di non creare un programma di sostenibilità locale a spese dell'insostenibilità altrui è infatti fondamentale confrontarsi con un'ottica più vasta.