|
|
| home > lanterna magica |
| Architettura
per lo sport e lo spettacolo |
||||
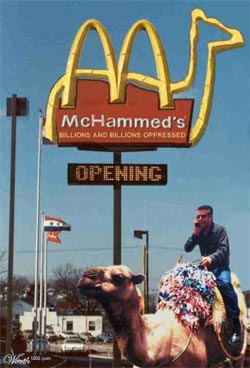 |
||||
| Del
pugilato si può dire quello che si vuole, ma resta il fatto che
il match si svolge in un'ambientazione ridicola. Quasi nulla differenzia
il ring da una gabbia per polli e, per di più, le movenze da
gallinaccio dell'arbitro non fanno che peggiorare la situazione. Ammettiamo che due uomini si battano. Ammettiamo perfino che lo facciano a cazzotti (per quanto, dovendosi battere, sarebbe più serio, più dignitoso e meno dispersivo farlo a colpi di sciabola o di pistola e, soprattutto, non indossando un paio di mutande fosforescenti) e tuttavia: che ragione c'è di farlo all'interno di un pollaio? Ecco, in linea di massima io, da architetto fuori corso quale sono, suggerirei che, dovendosi battere, non lo si faccia mai in ambiente chiuso. Il duello esige il plein air. Tant'è che le sole forme d'offesa "inter moenia" che abbiano conquistato dignità letteraria sono l'assassinio o la sberla (ma quest'ultima, per lo più, con risonanze comiche). In nessun caso una persona seria dovrebbe accettare di battersi dentro un recinto, e neppure di assistere ad un alterco che vi si svolga. Tutto questo va lasciato ai tacchini ed a chi, in un modo o nell'altro, specula sul loro allevamento. Lo Judo, in cui l'unico segno di circoscrizione è il tatami va già meglio... ma le cordicelle della boxe sono, ammettiamolo, propriamente spaventose. Per non parlare dell'aggiunta del gong che segna i round con, in più, la magnifica gallina, di solito abbondantemente popputa, che gira tutt'intorno brandendo un numero alla fine di ogni intervallo. Se poi dalle colluttazioni al minuto passiamo all'articolo all'ingrosso ci rendiamo conto che le cose non vanno tanto meglio. Guardiamo l'ambientazione di una delle ultime guerre che ci scaldano il cuore, danno il bel lavoro ai media e assicurano al barista il modo per intrattenere i clienti il tempo di un caffè, che vediamo? Polvere, calcinacci, ferraglia, un pezzettino di deserto, baracche. Ogni tanto si vede un cane che annusa una carogna di specie imprecisata e passa oltre schifato. Come si fa, con questo fondale, a prendere sul serio una guerra? Una volta era diverso: di qua c'era Londra, di là Berlino. Sotto i bombardamenti tedeschi la cupola della Cattedrale di San Paolo svettava, ferita ma invitta e sopra di lei sembrava di vedere aleggiare come un angelo vendicatore lo spirito di Sir Christopher Wren. Dall'altra parte, tra le macerie, la Porta di Brandeburgo si ergeva con fierezza teutonica nonostante la bandiera sovietica, come a dire "Io sono qui e qui rimango. Potrete fare quello che volete ma, ricordatelo, deutschland uber alles". Adesso tutto quello che riusciamo a percepire dietro l'annunciatrice (elegante ma senza strafare, in tenuta da guerra e ton sur ton: prima del collegamento s'è fatta avvoltolare con un raffinatissimo chador dal truccatore) è una mezza dozzina di poveri cristi con le giacche troppo corte e i pantaloni troppo larghi le cui facce sdentate ti mostrano senza possibilità di dubbio che il loro dentista non è lo stesso presso cui si serve l'elegante gazzettiera; e il loro sarto nemmeno. Ogni tanto, a prova del passato splendore di quei luoghi ci vengono mostrate cupole cadenti, muraglie decrepite e piastrelle scrostate sulle quali di certo hanno pisciato innumerevoli mendici affetti da malattie innominabili. Un cesso, lasciatemelo dire. Gli architetti però, a quanto pare, sono già al lavoro. Leggevo, per esempio, su una rivista un bel pezzo d'autore nel quale si parlava dei progetti di Wright per Baghdad. Qualche pensatore ha pensato (è il suo mestiere) che nulla osta a recuperarli e realizzarli. Devo dire che sempre si rimane sorpresi e ammirati dall'intelligenza, lungimiranza, senso estetico e fedeltà alla linea di quello che una volta si chiamava "Occidente" e che invece oggi non ci sono parole adeguate per definire (dal momento che oramai è un solo buco nero che ingoia tutto lo spazio e il tempo del pianeta). L'articolista (prosatore di prim'ordine, naturalmente) evocava con frasi liriche e lunghe il giusto la Baghdad di Harun Al-Rashid e delle "Mille e una notte" e, con esemplare finezza critica, mostrava a tutti come l'architettura dell'ultimo Wright si fosse ristorata a quella sorgiva dell'immaginario. Ne concludeva, il fine deduttore, che potesse anche passare all'ordine del giorno la possibilità di farsi mandare da Taliesin i progetti, prodotti del genio americano per lo Scià di Persia e, in un tempo ragionevole (diciamo i prossimi dieci anni) restituire la mitica città dei tappeti volanti ad uno splendore antico e nuovo nello stesso tempo. Uno splendore nutrito dalla linfa locale (filtrata, ma questo il gazzettiere non poteva sospettarlo, da Burton o Galland senza le cui occidentalissime penne le Mille e una notte che conosciamo noi non sarebbero quello che sono) e tuttavia proiettato direttamente nel futuro dei Jetsons di Hanna & Barbera. Una meraviglia, insomma. Effettivamente le idee non ci mancano e si può dire che ne pensiamo una più del diavolo: che simpatiche canaglie! Che senso dell'umorismo trascendentale! Poi dice che non ci meritiamo d'essere quello che siamo! Una Baghdad trasformata in una Disneyland d'autore, non è meraviglioso? Gli indigeni avrebbero lavoro in abbondanza: al talebano gli facciamo fare il maitre d'hotel, al muezzin il corista in un gruppo di world-music, la danzatrice del ventre ci avrebbe il suo posticino tra le cheerleaders mentre all'imam garantiamo il ruolo di battitore nella locale squadra di baseball "The Aladino's boys". Ci penso e già mi viene voglia di andarmi a fare un cheeseburger alla moschea di Omar. E a quelli che storcono il nasino (i soliti snob del piffero...) presentiamo il certificato di autenticità col timbro del Maestro FLW. Un domani, qualora ce ne fosse bisogno, avremmo l'ambientazione già pronta per una bella sfida sportiva tra l'occidente e quello che l'occidente s'immagina che sia l'oriente. Una sfida come si deve, nel corso della quale finalmente la nostra Lili Gruber col suo chador potrà spalmare il rossetto alla telecamera sullo sfondo di cupole da sogno, rose azzurre e cammelli smarmittati. Allora sì che sarà una bella guerra, i registi di Hollywood, lo so, già sbavano. C'è in quest'arroganza bonariamente agghindata da internazionalismo culturale, che scanna e amorevolmente incerotta col medesimo gesto, qualcosa che agghiaccia. Qualcosa di incomparabilmente peggiore del vecchio imperialismo, mortifero ma tutto sommato non del tutto privo di dignità. Movenze da bestia cui non servono gli occhi perché striscia nel buio, cui le orecchie non servono perché in quelle tenebre non esiste null'altro che il suo procedere occupando per intero il cunicolo. Non c'è spazio: l'altro non è rifiutato, per carità. È solo inconcepibile. Nessuno, in fondo, sarebbe più aperto dell'occidente alle ragioni di queste terroni d'oriente se solo essi la smettessero, una volta per tutte, di ostinarsi ad essere i terroni che sono. Inconcepibile un mondo in cui il mercato non imponga la sua legge del taglione, inconcepibile un'esistenza che non si dipani attraverso festival e telequiz, inconcepibile un dialogo che non verta sulle ultime notizie, inconcepibile un dio che non sia il nostro, inconcepibile qualcosa che non sia nuovo, splendente, originale, personalizzato, d'autore, ma nello stesso tempo assolutamente identico (fino nelle sue fibre più intime) a tutto il resto. In un circolo infernale che ricorda la figura dell'ouroboros che mangia se stesso. Inconcepibile una democrazia che non sia come la nostra. Ci muoviamo allegramente verso il nulla della stupidità con movenze futili e aggraziate. Si parla del più e del meno, si va al teatro, al cinema, si viaggia, si telefona, "dove vai in vacanza?" "Quest'estate vado a nord, voglio vedere l'aurora boreale che mi manca", si mangia macrobiotico, andiamo in palestra, lei si rifà le tette e il culo lui si allunga l'uccello di un pollice. Ogni tanto esplodono bombe. Eh, cari miei! Dopo l'undici settembre niente sarà più come prima! Dopo l'undici marzo pure. Le svolte epocali ce le sorbiamo la mattina col cappuccino. Ma tutto questo vorticare di mutazioni ha un mozzo immutabile: Sanremo, il Gabibbo e Marzullo sono rimasti tali e quali. Si procede. Lo speaker ormai reagisce stancamente, "l'oh" e "l'eh" il sospiro e la solidarietà non ingannano più nessuno. Galateo, scambi di cortesia, convenevoli, siamo tutti spagnoli, siamo tutti americani: il raffreddore del nostro cane ci causa molta più apprensione. E questo, in fondo, sarebbe anche giusto e umanissimo. Un uomo vive per chi gli cammina accanto, per quelli che tocca e che lo toccano, per loro piange davvero, per loro soffre davvero, il resto è notizia. Solo che si avesse il pudore di non trasformare sempre tutto in rappresentazione ipocrita del dolore e della compunzione. Il conduttore, del resto, se lo lascia sfuggire: "Ci colleghiamo adesso con il nostro inviato, che si trova sul palcoscenico degli eventi". Nessuna tragedia resiste alle esigenze della pubblicità e si muta, puntualmente, in farsa. La vittima non può più neppure reclamare la dignità del silenzio nel dolore, è perciò vittima due volte. Non passeranno dieci minuti dalla catastrofe che il cronista si recherà dai parenti a chiedere "cosa si prova in questi terribili momenti?" e i parenti, ahimè, anziché prenderlo a calci nel sedere sovente risponderanno adeguatamente "un dolore indicibile, sarei voluto morire io al suo posto". Cose che appena le pronunci davanti ad una telecamera, meriterebbero solo la frusta. Tutto questo ha bisogno del fondale giusto. L'architettura che una volta era lo scrigno nel quale noi, poveri esseri umani, custodivamo l'esistenza ricevuta in dono, che era la nostra dimora, il luogo in cui nascere, vivere e morire al fianco di chi conoscevamo, della nostra donna, dei nostri figli, nel seno della nostra comunità, il solido, l'antico telaio sul quale tessevamo l'esile garza, sempre rinnovata, dei nostri ricordi deve mutare e farsi scena (mutevolissima, a sua volta, ed effimera) di ridicole pantomime, di farse sanguinarie, di sceneggiate truffaldine. Muore l'architettura di tutti i giorni, quella che accompagnava il banale percorso della nostra esistenza, ma va nascendo, in compenso, un'architettura adeguata alla perenne domenica che ci illudiamo di vivere, un'architettura sempre nuova, personalizzata, originale, geniale, fluida, mobile nella sua immobilità, divertente, trasparente, virtuale, spaziale, subliminale, cablata, mutevole, con la feluca messa di sghimbescio come usano i nuovi accademici, anticonformista il giusto ma ottima per ritirare il premio e vincere il concorso. Perfetta per il nostro carnevale quotidiano. Un'architettura immaginata da architetti sportivi, competitivi, brillanti, canterini: un'architettura per lo sport e lo spettacolo. Ugo Rosa u.rosa@awn.it |
[26mar2004] | |||