Introduzione di Giorgio Cosmacini
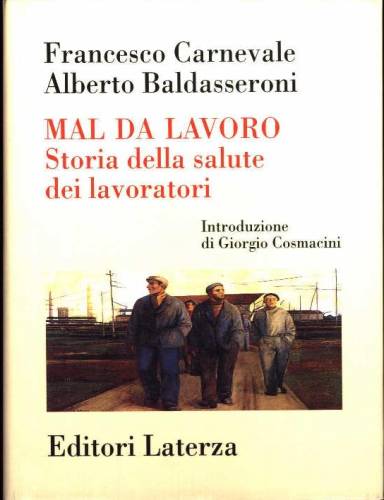
(Editori
Laterza, 1999)
Quest’opera
– che recensiremo opportunamente nell’apposita Rassegna Bibliografica
del nostro sito – è da considerarsi, per l’argomento trattato, non
soltanto una preziosa e ricca
fonte di analisi storica della medicina del lavoro, ma anche un importante
evento editoriale che vede ancora una volta protagonista la lungimiranza della
gloriosa casa editrice barese Laterza.
“Mal
da Lavoro” dedica particolare attenzione allo sviluppo delle conoscenze
scientifiche e alla loro applicazione o mancata applicazione, alle lotte per
rivendicare e ottenere migliori condizioni materiali di esistenza.
Per
i vari periodi storici e per i diversi rischi lavorativi nelle pagine del
libro si trovano fatti, testimonianze di protagonisti, dati ufficiali,
cronache scientifiche, ma anche storie di vita raccontate dalla parte delle
vittime. Al termine di ogni parte del libro, è possibile consultare una
preziosa e ricchissima bibliografia a testimonianza della capillarità della
ricerca storico - scientifica condotta dagli Autori.
Chi
sono gli Autori.
Francesco
Carnevale (Sersale, 1944), medico del lavoro presso l’Azienda Sanitaria di
Firenze, è professore a contratto presso le Università di Firenze e Urbino.
E’ coautore di un Manuale di medicina
del lavoro e di medicina legale (Verona,1986) e di un Trattato
di sanità pubblica (Roma, 1993). Ha curato la pubblicazione di opere di
Bernardino Ramazzini.
Alberto
Baldasseroni (Roma,1955), medico del lavoro ed epidemiologo presso l’Azienda
Sanitaria di Firenze, è professore a contratto presso l’Università di
Firenze. E’ coautore di Per una
storiografia italiana della prevenzione occupazionale e ambientale
(Milano,1997).
Ci
sembra interessante riportare una parte della Premessa
fatta dagli Autori nel libro da cui è possibile assimilare i concetti
fondamentali che hanno portato alla scrittura di “Mal
da lavoro”:
“
Chi si cimenterà nella lettura di quest’opera dopo poco tempo si accorgerà
delle diverse trame che sono presenti nel testo, alcune più marcate, altre più
sottili: La salute dei lavoratori sarà certamente l’epicentro, ma si
potranno trovare anche percorsi speciali sulla storia delle tecnologie, su
quella delle discipline mediche interessate all’argomento, sulla cultura
delle e sulle classi lavoratrici. Su alcuni avvenimenti storici coevi. Alcune
di queste trame trovano il loro sviluppo nelle note riportate alla fine di
quasi tutti i capitoli. Questo tipo di organizzazione giustifica l’ampiezza
e, talvolta, il dettaglio di tale apparato. E’ possibile che un lettore che
sia storico di professione ritenga di una qualche utilità la bibliografia così
come è stata raccolta e organizzata, come pure le fonti bibliografiche
individuate. Ai cultori di medicina del lavoro si spera di aver offerto
un’occasione di conoscenza e interpretazione, sia pur parziale e soggettiva,
sulle origini della disciplina, sui suoi percorsi e sulle prospettive che si
avvicinano. In generale si valuterà lo sforzo di rendere conto della
complessità e dell’infinito intrecciarsi di relazioni sociali e culturali
quando si affrontano temi come quelli del lavoro e dei lavoratori in tutti i
periodi storici, ma in particolare di quello preso in esame. I limiti
soggettivi nell’ampiezza di un lavoro di questo genere rendono conto
dell’incompletezza nello sviluppo di taluni aspetti del problema. E’ degli
autori la responsabilità delle scelte fatte nel sacrificare questa o quella
parte che avrebbe meritato più ampia trattazione.
Il
libro è dedicato ai lavoratori italiani che in patria, ma in gran numero
anche al di fuori dei suoi confini, hanno contribuito a creare la ricchezza
delle nazioni, ma è anche dedicato ai lavoratori stranieri che nel nostro
paese vivono e lavorano, contribuendo in eguale misura a tale ricchezza”.
Il
libro è stato presentato il 25 maggio in occasione del Seminario “Mal da
lavoro – la salute dei lavoratori: ieri, oggi, e domani? “, organizzato
dalla Fillea – CGIL Regionale Toscana in collaborazione con l’associazione
Ambiente e Lavoro Toscana Onlus al quale hanno partecipato, oltre agli Autori,
Nedo Baracani, Luigi Gasperini, Stefano Beccastrini, Diego Ahlique, Marco Lai,
Rodolfo Guarducci, Pietro Causarano, Andrea Valzania, Andrea Montagni e Siro
Romagnani. Hanno aperto e concluso i lavori rispettivamente Mauro Livi,
Segretario regionale della Fillea-CGIL e Franco Martini, Segretario generale
della CGIL Toscana.
Di
seguito, riportiamo il testo dell’intervento scritto per l’occasione da
Luigi Gasperini dell’Associazione Ambiente e Lavoro Toscana.
Luigi
Gasperini
La
tutela del “mal da lavoro” dall’età giolittiana all’avvento del
fascismo
Leggendo
“Mal da lavoro” , mi viene spontaneo inserire l’opera di Francesco
Carnevale e Alberto Baldasseroni in quel filone della storiografia medica del
lavoro che si riallaccia , con un ritmo di continuità e, naturalmente, di
aggiornata valutazione del quadro epidemiologico dovuto alle mutate condizioni
di rischio e di malattia dei lavoratori italiani, a quel fondamentale,
capillare lavoro sulle “Malattie dei lavoratori” scritto agli inizi del
1700 da quel grande patologo emiliano che fu Bernardino Ramazzini .
E’
da sottolineare che non è casuale se il lavoro del Ramazzini fu
elaborato proprio all’inizio del 1700, cioè in quel periodo che fece
da spartiacque tra il secolo della rifeudalizzazione socio-economica
seicentesca ed il secolo della settecentesca rivoluzione agricola, innescante
l’età dell’industrializzazione . E non è altrettanto casuale che il
lavoro scientifico del Ramazzini portasse il titolo, in latino, De morbis
artificum diatriba, ovvero le “ malattie dei lavoratori”, intendendo
specificare la frequente dipendenza “genetica” dei morbi insorgenti da
un’arte – come si diceva allora –o meglio – si direbbe oggi – da un
lavoro, sottolineando il fatto che il rapporto tra vita e lavoro è biunivoco:
si lavora per vivere, ma lavorare può anche voler dire contrarre, o disporsi
a contrarre una malattia che riduce la quantità e la qualità e la vita.
Nel
secolo in cui visse e operò il Ramazzini, il lavoro dell’uomo aveva già
superato alcuni percorsi, passando dal cosiddetto lavoro “obbligato”, cioè
dalla schiavitù, alla nascita del lavoro a tempo pieno che costituì una
svolta molto importante, proprio perché rappresentò la nascita del
“mestiere”. Infatti, prima di allora ogni persona s’industriava a fare
da sé ogni oggetto che le occorreva e solo in seguito imparò a coordinare il
proprio lavoro con quello degli altri.
Nacque
così la bottega artigiana, che con il tempo s’ingrandì, sviluppando al suo
interno attività lavorative complementari, dando luogo alla “fabbrica” in
senso storico. E' in questo ambiente, dove si ha un’estensione della
manovalanza, che nasce la consapevolezza, non solo scientifica,
epidemiologica, ma anche sociale, di studiare direttamente nei luoghi di
lavoro le malattie dei lavoratori per individuarne le cause del loro
manifestarsi ed i possibili rimedi, cosa che si svilupperà, ancor più
incisivamente allorché si compirà quel significativo passaggio concettuale
dalla medicina sociale alla cosiddetta medicina politica, intendendo dire con
ciò che la medicina dei lavoratori non poteva essere vista soltanto sotto il
profilo strettamente filantropico ma come problema di giustizia sociale,
anticipando quei concetti che saranno ulteriormente sviluppati alla fine del
secolo XIX, e particolarmente, agli inizi del secolo XX, legiferando le prime
normative sugli infortuni e, seppure successivamente sulle malattie
professionali.
Con
la moderna medicina del lavoro si è sempre più consolidato ciò che stava
alla base degli studi del Ramazzini, vale a dire la concezione della
preminenza della prevenzione su ogni altro intervento sanitario. Infatti, il
grande patologo emiliano non si stancava mai di raccomandare ai suoi allievi
di porre attenzione al mestiere esercitato dal paziente e alle relative
tecniche di lavorazione, per individuare appunto la possibile origine delle
malattie da lavoro per prevenirle.
In
sostanza, la moderna teorizzazione della prevenzione si basa sugli
insegnamenti di allora, cioè la distinzione tra prevenzione primaria, basata
sulla lotta alle cause del danno; la prevenzione secondaria, mettendo in atto
le misure che, attraverso una diagnosi precoce e un’opportuna terapia,
limitino al massimo il danno e, infine, la prevenzione terziaria tendente ad
impedire i decorsi più sfavorevoli, le complicanze ed i postumi permanenti.
Prevenire, dunque, significa prima di tutto valutare l’ambiente, allo scopo
di pesare le probabilità di danno per i soggetti esposti e per stabilire come
quel certo ambiente debba essere modificato per essere reso non nocivo (cioè
azzeramento del rischio) o almeno per la massima
parte degli esposti ( ovvero contenimento del rischio nei limiti
materialmente possibili).
Comunque,
per rendere operativi, anche se non del tutto compiutamente, tali concetti si
è dovuto percorrere un lungo cammino, durante il quale si sono verificati
avvenimenti di grande importanza storica come la rivoluzione industriale
inglese e la rivoluzione francese. Entrambe hanno decisamente dato l’avvio
allo sviluppo tecnologico nei sistemi di produzione nel primo caso e alla
profonda modificazione dei rapporti economici e sociali nel secondo caso.
Infatti,
con l’introduzione di macchine sempre più sofisticate nel processo
produttivo e quindi con lo sviluppo delle industrie manifatturiere, si assiste
ad un periodo di profonde trasformazioni che anche in Italia, nella seconda
metà del secolo XIX, creeranno le condizioni per avviare la nostra
rivoluzione industriale, nel cui contesto sociale le problematiche della
salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro cominciano a farsi strada, grazie
anche al diffondersi delle teorie politiche e sociali che saranno patrimonio
sia del socialismo sia del cattolicesimo popolare e che daranno origine alle
organizzazioni della classe operaia (prevalentemente a tendenza socialista)
sia della classe contadina (prevalentemente a tendenza cattolica).
In
proposito, è d’obbligo
ricordare che il 22 novembre del 1891 cominciò a funzionare a Milano la prima
Camera del lavoro e sempre nello stesso anno Papa Leone XIII scrisse
l’Enciclica “Rerum novarum” che, appunto, volle rappresentare
l’impegno del mondo cattolico nei riguardi dei problemi sociali.
Con
la crescente importanza che andava assumendo il cosiddetto “macchinismo
industriale”, collegato all’utilizzo dell’energia elettrica e quindi
all’introduzione del motore elettrico, sul finire del secolo XIX ebbe luogo
la riorganizzazione complessiva del lavoro e quindi la nascita della grande
produzione in serie e conseguentemente, di fronte all’aumentare degli
infortuni e delle malattie da lavoro, alla presa d’atto del potere politico
– anche di fronte al manifestarsi di una sempre più organizzata protesta
operaia – sulla necessità di dare inizio, seppure lentamente, ad un
processo legislativo che tenesse conto della tutela dei lavoratori e dei
rischi connessi alla loro attività, superando quindi il concetto di
beneficenza per dare forma ad un sistema previdenziale ed assistenziale
“normato” da leggi dello Stato.
Praticamente
il sistema previdenziale dell’epoca si reggeva sulle gloriose Società di
mutuo soccorso : secondo un censimento del Governo, era stimato che nel 1885
ne esistessero ben 1134, che svolgevano principalmente funzioni di assistenza
per il caso di malattia, a volte estesa anche alla famiglia del lavoratore
ammalato e, quasi sempre, per il
caso di morte venivano previsti sussidi per la vedova e per gli orfani.
Contemporaneamente
il mutualismo venne affiancato da altri fenomeni , come il cooperativismo e
alla trasformazione, in alcuni casi, di società di mutuo soccorso in
organizzazioni operaie a carattere rivendicativo, le cosiddette “società di
resistenza”, che aprirono la strada alle leghe operaie, con una diversa
connotazione ideologica.
Di
fronte alla crescente coscienza sociale, cominciò quindi a profilarsi la
necessità di una regolamentazione della materia previdenziale, sulla quale fu
inevitabile lo scontro fra correnti liberali, cattoliche e socialiste, specie
per la diversa concezione della libertà delle forme private di previdenza.
La
prima legge di regolamentazione delle società di mutuo soccorso ( si potrebbe
dire della previdenza sociale) si ebbe con l’emanazione della legge 15
aprile 1886, n. 3818, che rappresentò, appunto, il tentativo di coordinare lo
sviluppo e l’azione delle stesse società di mutuo soccorso con
l’ordinamento dello Stato unitario.
L’innovazione
introdotta con tale legge fu la possibilità del riconoscimento della
personalità giuridica per le società di mutuo soccorso che prevedessero
sussidi in caso di malattia, di “impotenza” al lavoro o di vecchiaia,
aiuti alle famiglie dei soci defunti, nonché l’educazione dei soci e delle
loro famiglie ed un aiuto economico per acquistare attrezzi o per altre
esigenze legate al lavoro.
Ma
per ciò che riguardava, più specificatamente, la tutela del “mal da
lavoro” dobbiamo rifarci alla Legge ordinaria del Parlamento del 30 marzo
1893 n. 184 relativa alla “Polizia delle miniere, cave e torbiere” che
dettava delle norme di controllo tendenti a tutelare la salute e la sicurezza
dei lavoratori di quel settore particolarmente “ a rischio”, si direbbe
oggi. Una legge sicuramente importante, se pensiamo che è stata abrogata e
sostituita soltanto nel 1959 con il Decreto del Presidente della Repubblica n.
128 del 9 aprile 1959.
Ma,
indubbiamente, un vero salto di qualità legislativo, si avrà con
l’emanazione della Legge ordinaria del Parlamento n. 80 del 17 marzo 1898
con la quale venne sancita l’obbligatorietà della assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e, dunque, la nascita del
sistema
previdenziale in Italia, costituendo la Cassa Nazionale di assicurazione
contro
gli infortuni e sancendo le modalità per la gestione delle società o imprese
private di assicurazione.
Dopo
l’emanazione di questa prima legge sull’assicurazione obbligatoria degli
infortuni sul lavoro, con l’inizio del XX secolo, coincidente in Italia con
la politica economica e sociale della cosiddetta “età giolittiana” che
porterà ad una fase di espansione industriale, i temi riguardanti la tutela
della salute e della sicurezza dei lavoratori si imporranno in modo sempre più
incisivo sia sul piano politico-sociale sia sul piano legislativo.
Riprenderanno
anche, dopo un oblio di lunga durata, gli studi di igiene e fisiopatologia
indirizzati ad approfondire i rapporti esistenti tra medicina e realtà
occupazionale e ambientale per meglio conoscere, come ebbe a scrivere allora
il patologo Paolo Mantegazza, “ i risvolti dannosi dell’industrialismo”.
Infatti,
nel 1906 a Milano, prima al mondo, venne inaugurata la Clinica per lo studio,
la cura e la prevenzione delle malattie professionali, diretta dal patologo
Luigi Devoto il quale, nella stessa città lombarda, fonderà anche la prima
associazione internazionale per lo studio dei problemi e delle malattie che
traggono origine dal lavoro, continuando quegli studi che, seppure in
situazioni ambientali ben diverse, furono iniziate dal Ramazzini.
Insieme
con Luigi Devoto non possiamo non ricordare il patologo fiorentino Gaetano
Pieraccini che rappresentò, come ha scritto qualcuno, l’incarnazione del
medico dei lavoratori, ovvero il realizzatore di una medicina politicizzata,
dove il binomio “ terapia sociale non etichetta un capitolo dedicato ad
elementi di medicina preventiva, ma sigla piuttosto l’istanza di una
medicina sociale attenta non solo ai modi di lavoro (mestieri, arti,
professioni) ma anche ai rapporti di lavoro ( cioè sfruttamento) ed ai
condizionamenti sociali ( miseria madre delle malattie).
Gaetano
Pieraccini è appartenuto, dunque, a quella categoria di medici sociali che
non si identificano più nelle figure dei medici apostoli, ispirati alla
filosofia filantropica del “miglioramento umano, illuminato e
progressivo”, ma –come ebbe a scrivere il grande medico milanese Giuseppe
Forlanini, “ uomini di scienza che con ogni mezzo di sforzano di applicare
quello che hanno riconosciuto utile e buono, ma che hanno anche sollecitato la
lenta società a dare risposte concrete ai diritti delle moltitudini
diseredate che reclamano maggiore giustizia sociale”.
La
legislazione sociale del primo decennio del XX secolo va letta e analizzata in
una chiave d’interpretazione che tese a significare un segnale preciso di un
nuovo atteggiarsi dello Stato nei confronti del sociale. E la configurazione
di questo nuovo Stato, dopo la “grande depressione” che si manifestò dal
1887 al 1896, dopo i tragici fatti del ’98 e le fallimentari avventure
colonialiste etiopiche, è rappresentata proprio con la nascita del Governo
Zanardelli-Giolitti nel 1901 e dal secondo Ministero Giolitti dal 1903 da cui
inizia, appunto, l’età giolittiana che durerà fino allo scoppio della
prima guerra mondiale del 1914.
Per meglio comprendere e valutare le ragioni che portarono la classe dirigente italiana di quel periodo - ed in particolare con Giovanni Giolitti al quale debbono storicamente essere riconosciuti, io credo, molti meriti, oltre ai demeriti attribuiti al suo “trasformismo” – ad un significativo cambiamento di rotta, economico e sociale e quindi alla introduzione di una politica previdenziale, si devono innanzitutto conoscere gli avvenimenti che caratterizzarono gli ultimi anni del XIX secolo che si trasferirono, in modo pesante e contraddittorio, nel nuovo secolo, come la degradazione del Mezzogiorno che si manifesterà anche nel costume civile col clientelismo e il consolidarsi di centri di potere come la mafia la quale estenderà il proprio potere, divenendo strumento armato per la lotta politica e macchina elettorale nel 1884; il controllo del mercato, intorno alla borghesia del Nord, attraverso il protezionismo industriale (1885); la costituzione e il rafforzamento nel centro nord di grandi complessi industriali, come le acciaierie di Terni, la nascita della Pirelli per la produzione della gomma; le industrie cantieristiche (Orlando), del ferro (ILVA), le industrie meccaniche (Breda), le industrie tessili di Biella e Valdagno e le industrie chimiche, come la Montecatini sulla quale, in “Mal da lavoro” sono state scritte interessanti pagine. Fra gli altri avvenimenti che vanno ricordati vi fu l’estensione del protezionismo doganale del 1887; sempre nel 1887 lo sviluppo della rete ferroviaria e la costituzione delle colonie di Eritrea e di Somalia; le celebrazioni del 1 maggio con scioperi e manifestazioni a Napoli e Milano nel 1890; il realizzarsi del Congresso per la costituzione del Partito dei Lavoratori Italiani nel 1892 a Genova con un chiaro programma socialista, secondo il modello della socialdemocrazia tedesca (parlamentarismo, gradualismo riformistico); la caduta del Ministero Crispi nel 1892, la formazione del Ministero di Rudinì e quindi la formazione del governo da parte del generale Pelloux il cui primo atto fu quello di presentare in Parlamento le “leggi eccezionali” contro lo sciopero e la libertà di stampa (1899) e che, specialmente di fronte ai tragici avvenimenti di Milano, provocarono l’ostruzionismo della sinistra socialista affiancata dalla sinistra liberale di Zanardelli e Giolitti.
Il
1900 si aprì con l’uccisione a Monza del Re Umberto I da parte
dell’anarchico pratese Gaetano Bresci. Nel 1901, dopo le dimissioni del
generale Pelloux cui succedette il Ministero Saracco, venne costituito il
Ministero Zanardelli, con Giovanni Giolitti agli interni che riconobbe il
diritto di sciopero e avviò una legislazione sociale
a favore del proletariato operaio nel momento in cui, con la formazione
nel 1903 del secondo governo Giolitti, avverrà nel nostro Paese un grande
processo di trasformazione tecnologica, economica ed anche sociale, dando
inizio quindi a quella che – come abbiamo già detto – sarà definita
l’età giolittiana.
La
politica giolittiana, pur cercando di interpretare le esigenze di una società
in trasformazione, sarà, però, caratterizzata da profonde contraddizioni.
Infatti, se da un lato prenderà consistenza una legislazione sociale a favore
del proletariato operaio ed il decollo industriale, favorito da dazi
protettivi, facilitazioni e sgravi fiscali, oltre a forti commesse dello
Stato, dall’altro avremo il non intervento governativo nel Mezzogiorno, dove
cosche mafiose e centri clientelari appoggeranno i deputati giolittiani e
quindi abbandonando il sottoproletariato allo sfruttamento degli agrari,
consolidando il blocco agrario-industriale.
E’,
comunque, in questo quadro politico ed economico che prenderà avvio il
principio della tutela del “mal da lavoro”, attraverso l’obbligatorietà
delle assicurazioni sociali e il nuovo ruolo di mediazione sociale assunto
dallo stato nei confronti degli interessi organizzati.
Non
va, poi sottovalutato, che la nascita e lo sviluppo del sistema previdenziale,
se vuole essere una evidente risposta istituzionale verso le classi
lavoratrici, è , al tempo stesso, uno dei più rilevanti strumenti di
sostegno alle esigenze dello sviluppo capitalistico italiano che, con la
diminuita importanza della proprietà terriera, andava affrontando
un’attività fortemente indirizzata verso la produzione industriale.
La
politica economica di Giolitti tese, quindi, a creare quelle infrastrutture
necessarie ad affrontare adeguatamente il processo di sviluppo, rivolto
all’industrializzazione del Paese. Fra gli obiettivi principali vi furono la
difesa delle finanze dello Stato contro gli interessi privati, favorendo gli
investimenti del risparmio in titoli di Stato e con l’estendere le
competenze bancarie e assicurative dello Stato stesso: in pratica iniziava la
costruzione di quello che nel secondo dopoguerra si sarebbe definito il “
capitalismo di Stato”.
Come
ha scritto Giampiero Carocci, “ la politica verso i problemi delle ferrovie,
della marina mercantile e del monopolio delle assicurazioni sulla vita volle
essere un argine contro i gruppi finanziari tradizionali, ottenuto facendo
intervenire lo Stato nella gestione dei loro servizi o tentando di rompere lo
stato di monopolio di cui godevano. A motivi analoghi era dovuto il favore con
cui Giolitti considerava la municipalizzazione dei servizi pubblici
cittadini”.
Intanto,
nel processo in atto dell’espansione produttiva che, conseguentemente
comportava un continuo aumento dei rischi lavorativi, i limiti del campo di
applicazione della “storica” legge n.80 del 1898 sull’assicurazione
degli infortuni, ed in particolare alcuni di essi apparvero eccessivi, come la
corresponsione di sole prestazioni economiche, la subordinazione della tutela
previdenziale al carattere contrattuale del rapporto di assicurazione; la
possibilità di effettuare la revisione della inabilità permanente soltanto
una volta; la devoluzione delle controversie alla competenza dei probiviri o
del pretore se riguardanti l’indennità temporanea.
E’
quindi significativo che sin dalla elaborazione del primo provvedimento di
attuazione si parlasse di una “riforma” della legge, attraverso proposte
parlamentari, studi di commissioni o di privati studiosi. Una prima, modesta
estensione della tutela antinfortunistica si ebbe con la legge 29 giugno 1903,
n.243, cioè la prima estensione, alla quale ne sarebbero seguite altre,
costituendo così la tendenza ad un’evoluzione legislativa della materia.
Nel
frattempo si era andata sviluppando nell’ordinamento giuridico del paese una
maggiore attenzione ai problemi della salute del cittadino in generale, come
ad esempio l’emanazione del Regio decreto 3 febbraio 1901, n. 45 relativo al
“Regolamento sanitario nazionale” con il quale, oltre ad indicare principi
innovativi circa “la tutela dell’igiene e della sanità pubblica”,
veniva dato avvio ad una più appropriata organizzazione degli uffici
sanitari, alla costituzione del Consiglio superiore di sanità, alla creazione
dei Consigli provinciali di sanità, alla nomina dei medici provinciali e
circondariali e dell’ufficiale sanitario comunale, e cosi via. Da notare che
nell’ambito di tale Regolamento generale sanitario venne anche legiferato,
come indicazione dell’affacciarsi di un nuovo problema sanitario connesso
tra attività produttiva e ambiente di vita, il modo di affrontare la salute
del cittadino in presenza di insediamenti manufatturieri in prossimità dei
centri abitati. Inoltre, si sviluppò anche una importante legislazione in
materia di prevenzione contro le malattie infettive, come la legge 2 novembre
1901, n. 460 portante, appunto, “disposizioni per diminuire le cause della
malaria”, cui seguì la legge 21 luglio 1902, n. 427 “sulla prevenzione e
cura della pellagra” e, quindi, il Regolamento per la profilassi delle
cosiddette malattie celtiche, mediante l’emanazione del Regio decreto 27
luglio 1905, n.487 che “approva il regolamento per la profilassi delle
malattie celtiche che comprendevano la blenorragia, l’ulcera semplice
contagiosa e l’infezione sifilitica.
Di
particolare interesse, è poi da ritenersi la promulgazione della Legge 29
giugno 1902, n. 246 con la quale fu istituito presso il Ministero di
Agricoltura, Industria e Commercio, l’Ufficio del Lavoro e il Consiglio
superiore del lavoro, organismi che avevano fra l’altro compiti riguardanti
l’ordinamento e la remunerazione del lavoro, il numero, le cause, le
conseguenze degli infortuni degli operai, gli effetti delle leggi che più
specialmente interessano il lavoro o, nel caso del Consiglio superiore del
lavoro, che era chiamato ad esaminare le questioni concernenti i rapporti fra
padroni ed operai, a suggerire i provvedimenti da adottarsi per il
miglioramento delle condizioni degli operai e ad esprimersi in merito ai
disegni di legge attinenti alla legislazione del lavoro.
Anche
dalla emanazione di questa legge è facile intuire che anche per quanto
riguardava la legislazione sul lavoro qualcosa stava cambiando, riconoscendo
che le lotte per migliorare le condizioni di vita della classe lavoratrice,
organizzata dalle nascenti camere del lavoro, determinarono nei governanti di
inizio secolo una maggiore sensibilità verso le problematiche sociali.
Con
lo svilupparsi della rete ferroviaria italiana si creò contemporaneamente un
fronte sindacale, quello dei ferrovieri, appunto, molto agguerrito e
determinato non solo a portare avanti una politica di rivendicazioni
salariali, ma anche a lottare per una maggiore tutela antinfortunistica ,
tanto che con il Regio Decreto 7 maggio 1903, n.209 fu emanato un importante
“Regolamento per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nell’esercizio
ferroviario” cui fece seguito, dopo l’avvenuta nazionalizzazione delle
ferrovie del 1905, la legge 30 giugno 1906, n. 272 riguardante le
“Disposizioni speciali sulla costruzione e sull’esercizio delle strade
ferrate” con la quale, fra l’altro, furono affrontati alcuni specifici
temi della sicurezza sia per quanto riguardava il lavoro nei cantieri, sia le
condizioni tecniche delle linee, del materiale rotabile e del personale.
Da
un punto di vista politico, rimaneva però sempre precario il problema di far
convivere il sistema pubblico con quello privato delle assicurazioni, ovvero
come stabilire la convivenza delle due tipologie dell’assicurazione privata
e dell’assicurazione sociale. Questo rapporto e questa convivenza furono
riflessi nella legge 29 giugno 1903, n. 243 che affermò un dato restrittivo
per la concorrenza degli enti assicurativi privati: mentre infatti si
prescrisse che per i lavori condotti direttamente dallo Stato o dagli altri
Enti territoriali fosse obbligatoria l’assicurazione presso la Cassa
Nazionale – eccetto quando le imprese esercenti detti lavori avessero
costituite casse private di assicurazione o si fossero consociate ai sindacati
mutui –s’impose, per converso, alla Cassa nazionale l’obbligo di
accettare qualsiasi proposta di assicurazione e quindi anche per rischi gravi,
di sicura perdita e perciò scartati dalle compagnie private e dagli altri
enti assicurativi.
La
legge n.243 del 1903, modificando la legge n. 80 del 1898 per gli infortuni
degli operai sul lavoro, introducendo l’obbligo dell’assicurazione degli
operai a più ampie categorie da sottoporre alla tutela degli infortuni, fu
fondamentale, non solo perché confermava il carattere peculiare
della Cassa Nazionale come organo statale dell’assicurazione
infortuni, ma anche perché con l’emanazione della stessa aveva inizio
quella sostanziale fase di revisione che in poco tempo avrebbe portato alla
emanazione di un Testo unico in materia.
Il
31 gennaio 1904, su proposta dell’allora ministro Rava del Governo Giolitti
venne approvato il regio decreto n. 51 riguardante il “Testo unico di legge
per gli infortuni degli operai sul lavoro” con l’estensione dell’obbligo
dell’assicurazione ad un più vasto campo d’industrie e d’ imprese.
Infatti, il Testo unico del 1904, oltre che riordinare e raccogliere in un
solo provvedimento le disposizioni concernenti l’assicurazione infortuni,
apportò alcune modifiche sia per quanto riguardava le lavorazioni tutelate
che le prestazioni. Ad esempio, nell’esercizio delle miniere, cave e
torbiere fu compresa, oltre a lo scavo e l’estrazione del minerale, “
anche la sua lavorazione sul luogo e il trasporto al primo punto di
caricamento fuori della miniera “, mentre per le imprese di costruzioni e
demolizioni edilizie furono incluse anche quelle che “compiono –si legge
– lavori di costruzione, restauro, rifinitura, modificazione e demolizione
di edifici, sia in città che in campagna”. Con il
Regio Decreto del 13 marzo 1904, n. 141 che approvava il regolamento
per l’esecuzione del Testo unico consentiva con i suoi 154 articoli di
interpretare più correttamente il carattere innovativo della nuova normativa
sugli infortuni degli operai sul lavoro.
Naturalmente,
il miglioramento della legislazione sugli infortuni degli operai sul lavoro si
deve in particolare modo a quelle lotte rivendicative del movimento operaio
che, con il ricorso allo sciopero, caratterizzarono il periodo
1902-1904, contribuendo a dare alle Camere del lavoro una fisionomia classista
e che porterà i propri iscritti a superare numericamente gli aderenti alle
Federazioni dei mestieri. Fra l’altro, alle Camere del Lavoro aderiranno
anche le Leghe dei contadini che, specialmente nell’Italia centrale e
meridionale, erano assai forti. Nel complesso gli iscritti in quell’epoca
alle Camere del lavoro e quelli iscritti alle Federazioni dei mestieri
risultavano rispettivamente di 485.563 e di 219.408. Nella storia del
movimento operaio, la data del 16 settembre 1904 fu considerata come quella in
cui fu proclamato il primo, grandioso sciopero generale dei lavoratori
italiani. E’ comunque certo che quello sciopero costituì una tappa decisiva
per il giovane movimento operaio che, acquisendo la consapevolezza che la
soluzione dei suoi molti problemi e il superamento delle divisioni interne ai
riformisti, avrebbe portato ad una linea di lotta strategicamente più
realistica, anche perché più unitaria. Infatti il 29 settembre 1906 fu
fondata la Confederazione generale italiana del lavoro alla quale nel 1910 si
contrappose la Confederazione Italiana dell’Industria per fronteggiare –
come si leggeva nel proprio atto costitutivo – “ l’organizzazione
sindacale dei lavoratori e realizzando così una maggiore aggressività sul
piano dei conflitti di lavoro”.
Nel
secondo periodo dell’età giolittiana, che precedette la prima guerra
mondiale, la contrapposizione di interessi fra padronato e lavoratori si fece
sempre più dura. Ne furono esempio, anche se con esiti molte volte
fallimentari, la proclamazione di durissimi scioperi, come quello dell’Elba
e di Piombino nel 1911, dell’auto a Torino nel 1912 e del materiale
ferroviario a Milano nel 1913.
Di
fronte, ormai, al declinante giolittismo, la classe imprenditoriale seppe
resistere a queste dure lotte sociali, riuscendo ad esprimere con il Ministero
Saracco, succeduto a Giolitti nel 1913, una impronta sempre più conservatrice
e prestandosi alle velleità del nascente nazionalismo di coloro che poi
saranno tra i fautori dell’interventismo nella guerra mondiale prima e
dell’avvento della dittatura fascista dopo.
Va
comunque sottolineato che anche nel secondo periodo dell’età giolittiana
non mancarono importanti interventi legislativi nel campo dei diritti civili e
sociali, come la concessione del suffragio universale anche agli analfabeti
che avessero compiuto trent’anni e assolto gli obblighi militari, la legge
489 regolante il riposo settimanale e festivo, il testo unico del 1 novembre
1907 sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli, la istituzione della
Cassa nazionale di previdenza per l’invalidità e la vecchiaia degli operai
del 1907, la legge 17 luglio 1910, n. 520 istitutiva della Cassa di maternità,
la legge 1306 del 23 novembre 1911 sulla prevenzione degli infortuni sul
lavoro nell’esercizio delle tranvie, la istituzione del Corpo ispettori
dell’industria e del lavoro avvenuta con legge 22 dicembre 1912, n. 1361.
Con quest’ultima legge si entrava in quell’ottica legislativa diretta a
tutelare sempre più il lavoratore, come contraente più debole nel rapporto
di lavoro, anche in deroga alle disposizioni del Codice Civile. Non dobbiamo
dimenticare che la disattenzione del legislatore verso il lavoro subordinato
trovava giustificazione con l’ideologia allora dominante , ma lasciatemelo
dire oggi resuscitante, secondo cui il mercato doveva essere lasciato libero
di fissare le condizioni di lavoro.
Nel
1913, con l’approvazione delle “Norme per assicurare il buon governo
igienico nei cantieri delle grandi opere pubbliche” di cui al Regio Decreto
25 luglio 1913, n.998 rispecchiava, come per la precedente legge , la volontà
della classe politica al Governo, particolarmente dove la presenza dello Stato
era fortemente presente, di proseguire sulla strada della tutela del
lavoratore, in questo caso affrontando il tema della salute del lavoratore nei
luoghi di lavoro.
E,
intanto, colui che era stato considerato il grande manovratore della politica
italiana durante il primo decennio del secolo, era ormai giunto al traguardo.
L’ età giolittiana era da considerarsi, ormai definitivamente tramontata il
30 marzo 1914, allorché Giovanni Giolitti dette le dimissioni da capo del
governo lasciando le redini ad Antonio Salandra , cioè a colui che si renderà
responsabile di una forte repressione operaia, dopo gli avvenimenti della
cosiddetta “Settimana rossa”. Certo è che con la caduta di Giolitti si
aprirono per il Paese oscuri e tragici orizzonti come l’entrata in guerra
del maggio 1915.
Durante
il conflitto, il Parlamento svolse un’attività molto ridotta, anche perché
ad esso fu sottratto qualsiasi potere di controllo. Lo Stato ,infatti, divenne
sempre più autoritario, in cui le ragioni dell’esecutivo prevalevano
sistematicamente su quelle del potere legislativo.
Nonostante
ciò dobbiamo registrare che in una circostanza il governo di coalizione e di
unione nazionale presieduto dall’onorevole Boselli – il quale, dopo la
disfatta di Caporetto , succedette al governo Salandra –ebbe modo di varare
un provvedimento legislativo importante, che ebbe una sua valenza politico –
sociale in quanto tendente a tacitare i malumori di coloro che maggiormente
stavano subendo le conseguenze della guerra, cioè il mondo contadino.
Infatti
il 23 agosto 1917 fu emanato il Decreto Luogotenenziale n. 1450, concernente
provvedimenti per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro in agricoltura, provvedimento con il quale venivano assicurati
dall’età di nove anni ai settantacinque compiuti i lavoratori fissi e
avventizi, maschi e femmine, addetti ad aziende agricole e forestali, oltre ai
proprietari, mezzadri, affittuari, loro mogli e figli, anche naturali che
“prestano –diceva il decreto –opera manuale abituale nelle rispettive
aziende”. Da sottolineare che tale decreto entrò in vigore soltanto in data
1 gennaio 1919 e che con regio decreto 2 ottobre 1921, n. 1367 fu modificato
in senso peggiorativo per i beneficiari.
A
conclusione di questa breve panoramica legislativa, prima dell’avvento della
dittatura fascista sono da ricordare l’emanazione del R.D.L. 3 giugno 1920,
n. 700 che istituì il Ministero del lavoro e della previdenza sociale che però
ebbe vita breve in quanto il regime fascista nel 1923 lo soppresse, passando
le sue competenze al Ministero dell’Economia Nazionale e, nel 1926, al
Ministero delle corporazioni.
Voglio
ricordare, infine, che nel 1920 fu introdotto nell’ordinamento legislativo
italiano il primo concetto di rischio chimico, anche se emanato in esecuzione
della Convenzione internazionale di Berna del 26 settembre 1906, ovvero
l’emanazione del Regio Decreto luogotenenziale 23 dicembre 1920, n. 1881 sul
“divieto di impiegare il fosforo bianco ( o giallo) nella fabbricazione dei
fiammiferi, ma anche di importare i fiammiferi di ogni specie nella
fabbricazione dei quali sia stato impiegato, in qualsiasi proporzione il
fosforo bianco (giallo). Infatti, tale sostanza risultava, sin dai primi anni
del 1800, estremamente velenosa.
Pochi
mesi prima che il fascismo prendesse il potere iniziando la fascistizzazione
dello Stato con le tragiche conseguenze che la storia si è assunta il compito
di registrare per la memoria dei posteri, il vecchio Parlamento fece in tempo
ad istituire il Casellario centrale infortuni, emanando il R.D 22 marzo 1922,
n. 387.
Anche
se non compiutamente, ho cercato di ricordarvi una piccola parte di un piccolo
aspetto di ciò che fa parte della storia di ieri delle malattie dei
lavoratori: ai compagni ed amici che mi seguiranno il compito di parlarvi del
“mal da lavoro” dell’oggi e del domani. Grazie.