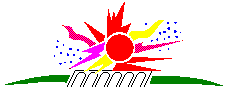
Ambiente e Lavoro Toscana ONLUS
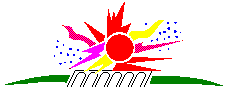
Ma i sostituti dell'amianto sono poi sicuri?
A distanza di sette anni dalla emanazione delle "norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto" (Legge 27 marzo 1992, n. 257), il dibattito tecnico-scientifico e prevenzionistico si stà ripresentando, non solamente per i problemi che l'uso massiccio di cui si è fatto uso negli anni passati dello stesso amianto e dei prodotti contenenti amianto, in particolare per gli aspetti sanitari degli esposti e degli ex esposti (a questo ultimo gruppo appartengono circa 10mila lavoratori), ma anche per gli aspetti non risolutivi, dal punto di vista epidemiologico, connessi con i prodotti sostitutivi di tale materiale. Con riferimento alla Legge citata, ed in particolare all'art.6, comma 2 della stessa che prevede l'omologazione dei materiali sostitutivi dell'amianto, prendendo atto "del parere espresso in data 3 marzo 1995 dalla Commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto...... e considerando che per rispondere ad urgenti esigenze di ordine sanitario e ambientale è opportuno adottare un decreto che fissi i criteri per l'omologazione dei materiali sostitutivi dell'amianto, con riferimento ai rischi sanitari ed ambientali degli stessi", è stato emanato dal Ministro dell'industria di concerto con il Ministro dell'ambiente il Decreto interministeriale 12 febbraio 1997. Secondo l'Allegato 2 di tale decreto, i requisiti richiesti per i materiali sostitutivi dell'amianto, ai fini della loro omologazione, devono soddisfare integralmente tutti i requisiti di seguito indicati:
"1) devono essere esenti da amianto (ove per esenti si intende che il loro esame con tecniche di microscopia elettronica analitica non deve evidenziare la presenza di fibre di amianto);
2) non devono contenere in concentrazione totale maggiore o uguale allo 0,1% di sostanze elencate nell'allegato I al D.M. 16 febbraio 1993 e successive modificazioni che siano classificate "cancerogene di categoria 1a o 2a e siano etichettate almeno come Tossica T+ con la frase di rischio R45 "Può provocare il cancro" o con la frase di rischio R49 "Può provocare il cancro in seguito ad inalazione", ovvero classificate dalla Commissione consultiva tossicologica nazionale (CCTN) nella categoria 1a o nella categoria 2a dall'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) nel gruppo 1 o nel gruppo 2;
3) i materiali con abito fibroso (lunghezza/diametro maggiore/uguale a 3, devono possedere le seguenti caratteristiche:
4) i materiali sostitutivi dell'amianto non devono dar luogo non devono dar luogo a rifiuti classificabili come tossici e nocivi a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 e successive modifiche".
Ma dal momento in cui venne emanata la Legge n. 257 del 1992 sulla cessazione dell'impiego dell'amianto fino al provvedimento chiarificatore sulla identità tossicologica che un prodotto sostitutivo dell'amianto deve avere, le industrie del settore, sollecitate dalle cosiddette "esigenze del mercato", hanno incrementato una produzione di materiali alternativi che dovevano soddisfare settori di utilizzazione molto vasti, forse senza tenere sufficientemente conto della tossicità o nocività di questi materiali alternativi. Per comprendere meglio il problema, anche sotto il profilo economico oltreché tecnico, è necessario conoscere i settori di utilizzo dell'amianto prima e dei sostituti dopo per rendersi meglio conto non solo dei vasti interessi verso tale produzione, ma conseguentemente anche sulle cause che hanno e continuano a determinare la diffusione di particolari malattie professionali, come ad esempio il mesotelioma maligno. Come noto, la scelta delle fibre di amianto fu determinato, per decenni, non solo da un costo relativamente basso, ma anche dalle qualità tecnologiche del prodotto, rappresentate da: resistenza a trazione e flessione; termoisolamento e stabilità termica; resistenza all'invecchiamento; capacità filtranti dei liquidi; proprietà dielettrica; fonoassorbenza; filabilità e tessilità. Occorre ricordare che nel corso del tempo, l'amianto avrebbe trovato circa 3000 diversi tipi di applicazioni in moltissimi settori industriali. Fra i comparti utilizzatori più rilevanti sono da citare, ad esempio: lavori di coibentazione (isolamenti termici ed acustici); nella costruzione di centrali termoelettriche; nella costruzione e manutenzione di raffinerie e impianti petrolchimici; nelle industrie chimiche; nelle industrie ceramiche; nelle vetrerie; nelle industrie siderurgiche; nella cantieristica navale; nei rotabili ferroviari; nelle industrie meccaniche e dei trasporti; nei cementifici; nell'industria orafa e dei metalli preziosi; nella produzione di filtri bituminosi; in enologia dove come filtratori del vino venivano impiegati filtri in amianto; e poi nelle coperture e nella produzione di manufatti in cemento-amianto e, ironia del caso, nella fabbricazione dei DPI (dispositivi di protezione individuale) come guanti, tute e grembiali. Il quadro di sintesi che abbiamo riportato, ci porta a considerare che l'eliminazione della produzione e dell'uso dell'amianto abbia determinato una vera rincorsa, in questi ultimi anni, alla ricerca di prodotti sostitutivi ed in particolare verso le fibre minerali e organiche artificiali con proprietà molto diverse tra loro e tenendo in scarsa considerazione il fatto che un materiale sostitutivo non può considerarsi innocuo solo per il fatto che non contiene amianto e quindi usato senza alcuna precauzione. Così si è verificata una larga diffusione di fibre minerali artificiali e di fibre ceramiche: le prime impiegate principalmente in edilizia (isolamento termoacustico), nell'industria per l'isolamento di impianti di processo, nei trasporti (isolamento termoacustico) e in applicazioni speciali (barriere acustiche), mentre le fibre ceramiche hanno trovato impiego in tutte quelle applicazioni in cui è necessario isolare processi ad alte temperature (fino a 1600°C). Da un punto di vista merceologico le lane minerali si differenziano dalle fibre ceramiche per la composizione chimica e per la dimensione da cui ne consegue oltre alla diversa classificazione, un diverso utilizzo in funzione di una diversa risposta al calore. Nell'ambito delle fibre sintetiche vi è poi una ulteriore differenziazione, essendo distinte, attraverso l'adozione semplificata di sigle, in MMMF e MMVF, acronimi che stanno a definire rispettivamente: man-made mineral fibers e man-made vitreous fibers, termini coniati nel 1985 ed introdotti ormai nel codice tecnico. Esistono anche le MMIF, ovvero man-made inorganic fibers (fibre di carbone e di grafite). In commercio sono state introdotte oltre alle fibre artificiali vetrose (silicati) che presentano un'orientazione casuale ed un tenore di ossidi alcalini e alcalino terrosi in quantità superiore al 18%, anche fibre amorfe di allumina, combinazione di silicati e non silicati come il carbonio. Sperimentalmente sono state prodotte migliaia di fibre a composizione diversa, per un totale di quasi trecento materiali fibrosi di diversa composizione chimica. Di fronte a questa moltitudine di prodotti sostitutivi dell'amianto, nascono anche degli interrogativi sulla innocuità del loro impiego indiscriminato. Infatti, stanno avanzando nell'ambito di coloro che, sul terreno tecnico ed epidemiologico, si occupano di tutelare la salute degli esposti a queste fibre, dei grossi dubbi. Leggendo gli Atti di un Seminario di studi INAIL sul tema "Analisi del rischio assicurato", svoltosi nel 1997, le Dr.sse A. Macioce e L. Quaranta della CONTARP (Consulenza Tecnica Accertamento Rischi Professionali della Direzione Regionale Toscana INAIL) hanno scritto, a proposito degli effetti sulla salute dei materiali fibrosi inorganici, quanto segue: "Fin dagli inizi del secolo si sono studiati rischi per la salute connessi all'esposizione a materiali fibrosi. L'amianto è stato usato fin dall'antichità ed addirittura venerato per le sue "magiche" qualità, è ora stato messo al bando e sostituito da numerosi prodotti, soprattutto fibre sintetiche organiche. I cavi in fibra di vetro hanno sostituito i cavi in rame per le comunicazioni. La lana di vetro o di roccia ha sostituito l'amianto come isolante. Le fibre di vetro o grafite sono usate per fabbricare ad esempio articoli sportivi. Questi sono solo alcuni esempi delle numerosissime applicazioni. Si è visto che con la diffusione delle fibre inorganiche si hanno indizi per ritenerle rischiose per la salute umana. Sono stati necessari oltre 25 anni per stabilire una connessione tra mesotelioma ed esposizione a fibre d'asbesto e comunque l'eziologia e gli specifici meccanismi che causano il cancro non sono stati ancora del tutto chiariti. Questi consisterebbero, stando a ricerche condotte dallo IARC:
Da evidenze risultanti da studi condotti sperimentalmente si è visto che l'erionite risulterebbe tra i cancerogeni accertati ed inseriti nella classificazione IARC nel gruppo 1 al pari dell'asbesto. Anche le fibre ceramiche sembra che svolgano un ruolo attivo nell'insorgenza di mesoteliomi. Le fibre aramidiche hanno indotto carcenogenesi su animali (ratti). Per molti altri materiali fibrosi non sono ancora univoci i pareri riguardo la pericolosità. Nella classificazione dello IARC (1994) al gruppo 1 sono ascritti Asbesto ed Erionite, al gruppo 2b lana di vetro, lana di roccia, lana di scoria, fibre ceramiche, al gruppo 3 filamenti di vetro continui, Sepiolite, Wollastonite e Attapulgite". E' opportuno ricordare che il gruppo 1 identifica i cancerogeni per l'uomo, il gruppo 2a i probabilmente cancerogeni per l'uomo, il gruppo 2b i possibilmente cancerogeni per l'uomo, il gruppo 3 non classificabile come cancerogeno per l'uomo. Orbene, il Decreto 1 settembre 1998 del Ministero della sanità riguardante le "Disposizioni relative alla classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose in recepimento della direttiva 97/69/CEE" recita chiaramente che "studi di laboratorio indicano che alcune fibre artificiali vetrose (silicati) presentano effetti cancerogeni e che le indagini epidemiologiche hanno suscitato preoccupazioni circa gli effetti sulla salute delle fibre artificiali vetrose (silicati); pertanto, l'elenco delle sostanze pericolose figurante nell'allegato I del decreto ministeriale 28 aprile 1997 deve essere adattato e completato….". Infatti, le lane minerali (fibre artificiali vetrose - silicati) che presentano un'orientazione casuale ed un tenore di ossidi alcalini terrosi, Na2O, K2O, CaO, MgO, BaO, in quantità superiore al 18% vengono introdotte nella classe di rischio 3 CE e di conseguenza etichettate con frase di rischio R40 (possibilità di effetti irreversibili dovuti agli effetti cancerogeni) Xi R38 (irritante per la pelle con nota Q e nota R; le fibre ceramiche refrattarie, fibre per scopi speciali (fibre artificiali vetrose - silicati) che presentano un'orientazione casuale ed un tenore di ossidi alcalini e alcalini terrosi Na2O, K2O, CaO, MgO, BaO in quantità inferiore al 18% vengono introdotte nella classe di rischio 2 CE di conseguenza etichettate con la frase di rischio R49 (cancerogeno per inalazione) Xi R38 (irritante per la pelle) nota R. La classificazione tossicologica delle fibre è ottenuta tramite la valutazione di alcuni parametri che definiscono la biosolubilità o biopersistenza nell'apparato respiratorio (criterio di durabilità) e la inalabilità delle fibre (criterio dimensionale). I criteri delle note Q ed R sono riportati al comma c) dell'art.1 del decreto ministeriale, dove si precisa che:
" Nota Q: La classificazione "cancerogeno" non si applica se è possibile dimostrare che la sostanza in questione rispetta una delle seguenti condizioni:
una prova di persistenza biologica a breve termine mediante inalazione ha mostrato che le fibre di lunghezza superiore a 20 micron presentano un tempo di dimezzamento ponderato inferiore a 40 giorni;
oppure:
una prova di persistenza biologica a breve termine mediante instillazione intratracheale ha mostrato che le fibre di lunghezza superiore a 20 micron presentano un tempo di dimezzamento ponderato inferiore a 40 giorni;
oppure:
un'adeguata prova intraperitoneale non ha rivelato un'eccessiva cancerogenicità;
oppure:
una prova di inalazione appropriata a lungo termine ha portato alla conclusione che non ci sono effetti patogeni significativi o alterazioni neoplastiche.
Nota R: La classificazione "cancerogeno" non si applica alle fibre il cui diametro geometrico medio ponderato rispetto alla lunghezza meno due errori standard risulti maggiori di 6 micron".
Secondo quanto affermato in un documento, presentato nello scorso mese di ottobre in occasione di un seminario di studio dal Gruppo di lavoro cancerogeni (amianto) del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria di Firenze, gruppo coordinato dal dottor Francesco Carnevale e di cui fanno parte esperti come S. Silvestri, F. Luongo, L. Miligi, S. Perissi, G. Fornaciari ed altri, "la novità di questa classificazione riguarda soprattutto le fibre ceramiche che come le lane minerali vetrose erano già classificate come "Possibilmente cancerogene" nel gruppo 2b IARC, mentre la nuova classificazione europea le colloca in modo più restrittivo fra i cancerogeni certi. Per quanto riguarda la nota Q sarebbe opportuno procedere ad una valutazione accurata sull'equivalenza delle varie metodiche rispetto alla valutazione finale. Alcuni dati recenti di letteratura riportano uno studio sperimentale condotto su ratti che dimostra come le fibre vetrose di nuova generazione con lunghezza superiore a 20 micron hanno mostrato un valore ponderato di emivita inferiore a 10 gg. E' da rilevare che ad oggi non si ha conoscenza in Italia di un laboratorio pubblico attrezzato per effettuare tali controlli e che di conseguenza attualmente devono essere prese per valide le informazioni riportate sulle schede di sicurezza. Il test per instillazione intraperitoneale risulta a tutt'oggi quello a più alta sensibilità e specificità, si rileva comunque la genericità dell'indicazione sul risultato da ottenere un'adeguata prova intraperitoneale non ha rilevato una eccessiva cancerogenicità. Per quanto riguarda la nota R è da rilevare che anche in questo caso non esiste una metodica ufficiale standardizzata per l'effettuazione della classificazione dimensionale ponderata delle fibre. Si rileva inoltre una non accurata traduzione dal testo inglese del periodo riguardante la media (geometrica) dei diametri ponderata per la lunghezza. La corretta traduzione dal testo inglese è: la media geometrica dei diametri ponderata per la lunghezza. Riteniamo fondamentale promuovere nelle sedi opportune iniziative rivolte all'individuazione di laboratori pubblici attrezzati per mettere a punto metodiche analitiche adatte al controllo della conformità al decreto dei prodotti presenti sul mercato". Ci sembra che questo segnale di allarme sia più che opportuno, in quanto, come abbiamo scritto all'inizio, la diffusione di questi materiali "sostitutivi" dell'amianto stà aumentando enormemente, in particolare per quanto riguarda le fibre ceramiche refrattarie. Agli utilizzatori di questi materiali è consigliabile che tengano conto degli obblighi normativi in atto i quali prevedono, ove è possibile fino a quando le temperature di esercizio e le caratteristiche tecnologiche lo consentono, che i materiali classificati come cancerogeni devono essere sempre sostituiti con materiali non cancerogeni. L'uso delle fibre ceramiche può comportare l'applicazione del Titolo VII "Protezione da agenti cancerogeni" del D.Lgs. 626/94 (artt. 61 e 62). Il Titolo VII prevede inoltre che in tutte le attività in cui vi sia utilizzazione di materiali cancerogeni che siano classificati con la frase di rischio R49, come nel caso delle fibre ceramiche, debba essere effettuata una valutazione del rischio preliminare anche attraverso una valutazione strumentale del livello di contaminazione ambientale di fibre aerodisperse, in base al quale si adotteranno le misure preventive e protettive per i lavoratori adattandole alla particolarità delle situazioni lavorative come previsto dall'art. 63.