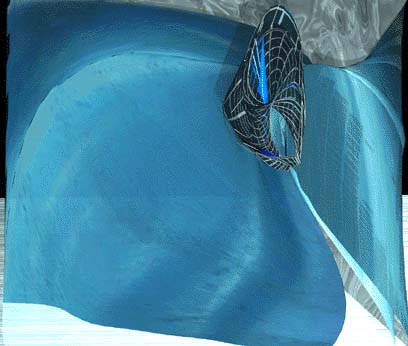Teoria
dell'Ipersuperficie:
Architettura><Cultura*
PARTE(4)
Stephen Perrella and Rebecca Carpenter, Mobius House Study, 1998
Transversal nurb animations
Email di Gary Genosko, febbraio 1998
Caro Stephen, la tua critica di un pensiero dicotomaniacale attraverso una collisione dei dualismi prevalenti capace di rivelare le loro connessioni trasversali su di un piano di immanenza, indica decisamente che la forza generativa dominante è la società dei consumi. Questo lega i fenomeni di ipersuperficie al capitalismo, reintegrando una semiologia dominante sul piano dell'immanenza, più o meno eliminando lo scopo della tua critica. L'idea che l'ipersuperficie produca effetti profondi deve significare che singoli tratti di tali effetti sono conservati in opposizione alle loro traduzioni capitalistiche. Questo significa che sulle ipersuperfici deve avvenire un certa dose di semiosi senza significazione: la relazione tra flussi di materia e flussi di forma deve in qualche maniera eludere la loro rappresentazione capitalista (se non succedesse così, si eliminerebbero vicendevolmente). Naturalmente, le manifestazioni delle ipersuperfici devono prendere a prestito qualcosa dalle semiologie capitaliste, ma hanno anche bisogno di conservare, rispetto a queste, una certa autonomia. Io credo si possa affermare che una semiotica dell'ipersuperficie elude i formalismi dominanti che portano all'assegnazione di un significato, in un regime di significazione basato su dicotomie che non possono essere intese come un linguaggio (l'architettura non è un linguaggio!). Cos'è l'architettura dell'ipersuperficie? Bene, non è una pura semiotica della significazione, per una ragione precisa: essa coinvolge sostanze semiotiche non linguistiche, specialmente tattili, praticamente intraducibili in termini di linguaggio, cosa che dona loro virtù; la tattilità non è riconducibile a codificazione visiva.
Risposta
Caro Gary, secondo me le ipersuperfici sono costituite da un'incommensurabile complessità, associata ad un certo numero di impulsi simultanei che emergono dalla schizo-cultura. Uno di questi proviene dal filone Heidegger/Derrida, secondo cui il capitalismo provoca, attraverso i suoi modi di produzione, una decostruzione ed una deterritorializzazione della soggettività. Questa era più o meno la tesi di Walter Benjamin, ma c'è bisogno della post-fenomenologia per parlare di "iper" per descrivere significati ondeggianti su superfici fisiche. Questo percorso rappresenta l'aspetto volgare della cultura, mentre la parte materiale si trova nel contesto architettonico che ha portato alla distribuzione topologica della forma sulle superfici. Credo che quando iper e superficie si congiungono, non essendo allineati, portano ad esiti molto forti e non riducibili a linguaggio. In realtà tali esiti resistono ad una tale consuntiva riduzione, manifestandosi invece come generativi o autogenerativi.
Come in un quadro di Jackson Pollock, non c'è possibilità di riduzione. C'è solo un campo aperto ad una maggiore complessità; una complessità fatta di intrecci. Le ipersuperfici risultano dal disordine delle singolari linee di comunicazione che si incrociano l'una sull'altra portando ad una deformazione; gli architetti cercano difornire una membrana con la quale tenere insieme quest'intreccio. Ma non ci riescono mai, perché l'invadenza dei media è troppo forte, e così contribuiscono essi stessi alla fluttuazione dell'insieme. Tutta la scena è fortemente autogenerativa. Come se rumori generati casualmente conoscessero un momento di limpidezza: questa è una schizofrenia produttiva. Alcuni effetti non sono riconducibili a linguaggio perché vanno semplicemente avanti e indietro tra materiale e immateriale; generati dal consumo, non forniscono ancora una base comune sulla quale costruire delle associazioni. Gary, questo è il punto centrale riguardo alle ipersuperfici: un flusso materiale/immateriale della comunicazione attuale (costituito in parte dal commercio) che non può risultare in una collettività politica. Nessuna coscienza di un controllo, nessuna istituzione materiale: tutto a partire dal mezzo. Verso il fuori
Schizofrenia produttiva: ipersuperfici dalle condizioni di mezzo
La teoria dell'ipersuperficie coniuga l'eredità di Heidegger con quella di Deleuze. Entrambe le condizioni sono diventate rilevanti per il modo in cui la cultura ha scoperto ed accolto la tecnologia. Ma le due traiettorie sono, in qualche modo, incommensurabili: l'una è fenomenologica, l'altra propriocettiva. Ecco perché la teoria dell'ipersuperficie non può scaturire da una fusione tra le due, ma solo valere contemporaneamente per entrambe. Questa è la base per una schizofrenia produttiva. Per tale ragione, ancora, nel rapporto tra architettura e cultura risultano effetti incommensurabili. Ma come può essere produttiva questa schizo-doppiezza? La strategia di un termine come "ipersuperficie" è quella di suggerire che l'architettura è un inviluppo abitabile tra soggetti ed oggetti deterritorializzati. Deleuze sostiene che ogni cosa è connessa prima di essere divisa, e che sia soggetto che materia sono fondamentalmente legati. Quello che si descrive qui è il complesso di forze che stanno svuotando il dualismo che ha tenuto categoricamente separati soggettività e materialità. Esistono delle forze che minano il principio di separazione e che provengono dai macchinismi della vita quotidiana, ormai interconnessa attraverso teletecnologie digitali.
La teoria dell'ipersuperficie riconosce, piuttosto, che nei rapporti con l'ambiente costruito contemporaneo, siamo sempre influenzati dal complesso dei media. Questa condizione tecno-esistenziale ci colloca all'interno di una inestricabile relazione con i media (qui intesi come genericamente inclusivi di tutti i modi di rappresentazione in possesso delle culture agevolate dalle tecnologie). Punto di partenza e molla per attività capaci di entrare in rapporto con un soggetto solo in parte costruito. La co-presenza di esperienze fisiche sovrapposte a soggettività mediate è un'ipersuperficie, e la manifestazione di questo costrutto nell'ambiente costruito è una sua espressione. Se siamo, in parte, espressione dei media, allora questo fatto dovrebbe essere manifesto nell'ambiente costruito, come in uno spazio curvo nel quale incontriamo noi stessi, ma sotto forma di tecnologia. Le ipersuperfici appaiono in architettura quando la co-presenza dell'aspetto materiale e dell'immagine, su di una superficie/membrana/substrato, è tale che non ci sia prevalenza né della materialità né dell'immagine. Una tale costruzione risuona e destabilizza significato e comprensione, deviando trasversalmente la percezione all'interno di flussi e canali.
Scopo della teoria dell'ipersuperficie è descrivere l'emergente fenomeno architettonico e culturale come un mezzo che permette di andare oltre le interpretazioni schizofreniche o nichiliste che contribuiscono alle dinamiche del complesso mondo contemporaneo. Piuttosto che una divisione, tra le cose esiste una molto più pervasiva connessione. Ci sono molti modi di avvicinare questa impossibilmente complessa configurazione, ma pochi sono i temi che si possono svolgere per rivelare le soggiacenti dinamiche di connessione, piuttosto che quelle di divisione. La teoria dell'ipersuperficie propone una architettura/cultura che emerge da condizioni medie. Cosa è un'architettura delle condizioni medie, e come si colloca in opposizione ad altre teorie dell'architettura? Cosa può voler dire pensare l'architettura da una condizione media? E a che scopo?
Anzitutto, non c'è uno scopo. La condizione media funziona in alternativa alla nostra più forte tendenza a pensare in termini di opposizioni ed a privilegiare l'una o l'altra entità. Questo è quello che abbiamo imparato dalla decostruzione: che le opposizioni binarie servono a creare strutture per tutto ciò che abbia un significato. Questo vuol dire che qui siamo interessati ad una architettura senza significati? Con quale situazione ci stiamo confrontando all'inizio di un nuovo millennio?
L'architettura delle ipersuperfici corrisponde alla simultanea ed incommensurabile azione umana nei confronti di una topologia materiale. Un'ipersuperficie riassume la co-presenza dello svolgersi delle attività umane, così come essa ha luogo in una forma-sostanza di forza, oppure è manifestata attraverso significanti di un linguaggio così come essi occorrono in un piano di immanenza relativo ad un altro piano di immanenza la cui forma-sostanza è quella della materia. Le intensità hanno luogo dove questi due piani di immanenza determinano altri piani di immanenza - nessuno dei quali ha a che fare con logiche assolute o trascendentali. L'ipersuperficie è quella condizione resa possibile dal prodotto delle forze risultanti, tanto umane quanto materiali, tali che le due polarità non restino a lungo opposte e isolate. Al contrario, ciascuna si mescola e prolifica, stabilendo le prime basi di quello che può presto diventare un piano intersoggettivo di immanenza. Mente e corpo si incontrano sulla ipersuperficie nel punto di congiunzione con il mondo della forma-sostanza, e scorrono come piani di immanenza in una architettura dell'ipersuperficie. I nostri corpi sono ipersuperfici, superfici convesse e concave sopra e attraverso cui il senso scorre. Questa è una condizione irriducibile che non ha né interni né esterni assoluti.
L'interno deve riconnettersi all'esterno attraverso l'immaginazione, ma un'immaginazione che sia configurata per via di un'intersoggettività altamente problematica. Un'ipersuperficie è l'attivazione di queste potenzialità latenti all'interno di substrati, membrane, superfici che costituiscono le relazioni interstiziali tra i corpi (distribuiti come un linguaggio) e la sostanza-materia. Questo non accade in guisa di intervento all'interno di un contesto esistente, ma si rende esplicito a causa delle complesse interrelazioni tra le manifestazioni tecnologiche, la nostra tradizione ed il passato latente: interrelazioni che sono state saturate con i media. L'inconscio esiste sempre, sullo sfondo, alla base delle attività umane, operando appena al di sotto della comprensione. I filosofi psicoanalitici propongono un'interpretazione di queste operazioni sulla superficie, ma non vanno verso una soddisfacente struttura di comprensione. Gli effetti dell'ipersuperficie sono sia al di là della forma che dell'immagine. Generalmente, un'ipersuperficie ha un ambito di influenza, che include significativamente una dimensione di surrealtà e di iperrealtà; una forma di realismo che è simultaneamente fantastico, incomprensibile e quindi un elemento catalizzatore o provocatore, ma non necessariamente in maniera evidente. Non essendo né in un contesto di piena consapevolezza né in uno di incoscienza, l'ipersuperficie scivola prontamente tra queste realtà, sulla giuntura tra le due. Un'ipersuperficie è la topologia informativa nel terreno interstiziale tra reale ed irreale (o qualsiasi altra opposizione binaria) capace poi di scorrere trasversalmente all'interno di un canale di associazioni. La nostra attuale condizione di stasi in un mondo audio-visivo è quella che Virilio chiama "l'ultimo veicolo". Ma si tratta di una condizione che sarà sopraffatta, nel momento in cui la nostra sensibilità mediatizzata comincerà ad inondare la nuova proliferazione di forme architettoniche trasformate in ipersuperfici topologiche.
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:
J. Abbott Miller, Dimensional Typography, Princeton: Kiosk Report, 1996;
John Brockman, The Third Culture, New York: Simon & Schuster, 1995;
Bernard Cache, Earth Moves: The Furnishing of Territories, ed. Michael Speaks, trans. Anne Boyman, Cambridge: The MIT Press, 1995;
Gilles Deleuze, The Logic of Sense, ed. Constantin V. Boundas, trans. Mark Lester with Charles Stivale, New York: The Columbia University Press, 1990; trad. it., Gilles Deleuze, Logica del senso, Milano: Feltrinelli, 1975;
Gilles Deleuze, The Fold: Leibniz and the Baroque, trans. Tom Conley, Minneapolis: The University of Minnesota Press, 1993; trad. it., Gilles Deleuze, La piega: Leibniz e il Barocco, Torino: Einaudi, 1990;
Gilles Deleuze, Cinema 2: The Time-Image, trans. Hugh Tomlinson and Rober Galeta, Minneapolis: The University of Minnesota Press, 1994; trad. it., Gilles Deleuze, Cinema 2: L'immagine-movimento, Milano: Ubulibri, 1984;
Gilles Deleuze and Félix Guattari, A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia, trans. Brian Massumi, Minneapolis, The University of Minnesota Press, 1987; trad. it., Gilles Deleuze, Millepiani: Capitalismo e Schizofrenia, Roma: Castelvecchi;
Hal Foster, The Return of the Real, Cambridge, The MIT Press, 1996;
Anne Friedberg, Window Shopping: Cinema and the Postmodern, Berkeley: The University of California Press, 1993;
Félix Guattari, Chaosmosis: An Ethico-Aesthetic Paradigm, trans. Paul Bains and Julian Pefanis, Bloomington: The University of Indiana Press, 1995;
Denis Hollier, Against Architecture: The Writings of Georges Bataille, trans. Betsy Wing, Cambridge: The MIT Press, 1989;
Ada Louise Huxtable, The Unreal America: Architecture and Illusion, New York: The New Press, 1997;
Dietmar Kamper, Christoph Wulf, eds., Looking Back on the End of the World, trans. David Antal, New York: Semiotext(e), 1989;
Brian Massumi, A User's Guide to Capitalism and Schizophrenia: Deviations from Deleuze and Guattari, Cambridge: The MIT Press, 1992;
Todd May, Reconstructing Difference: Nancy, Derrida, Levinas, and Deleuze, University Park, The Pennsylvania State University Press, 1997;
Mary Anne Moser with Douglas MacLeod, ed., Immersed in Technology: Art and Virtual Environments, Cambridge: The MIT Press, 1996;
Avital Ronell, The Telephone Book: Technology, Schizophrenia, Electric Speech, Lincoln: The University of Nebraska Press, 1991;
RUA/TV: Heidegger and the Televisual, ed. Tony Fry, Sydney: The Southwood Press, 1993;
Maggie Toy, ed., Architectural Design: Architecture After Geometry, London: Academy Group Ltd., 1997;
Gianni Vattimo, The End of Modernity, trans. Jon R. Snyder, Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1988; ediz. or., Gianni Vattimo, La fine della modernità, Milano: Garzanti, 1987;
Gianni Vattimo, The Transparent Society, trans. David Webb, Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1992; ediz. or., Gianni Vattimo, La società trasparente, Milano: Garzanti, 1989;
Robert Venturi, Iconography and Electronics Upon a Generic Architecture: A View from the Drafting Room, Cambridge: The MIT Press, 1996;
Paul Virilio, The Vision Machine, trans. Julie Rose, Bloomington: The Indiana University Press, 1994; trad. it, Paul Virilio, La macchina che vede: l'automazione della percezione, Milano: SugarCo, 1989;
Mark Wigley, The Architecture of Deconstruction: Derrida's Haunt, Cambridge, The MIT Press, 1993;
Mark Wigley, White Walls, Designer Dresses: The Fashioning of Modern Architecture, Cambridge, The MIT Press, 1995.
HOME > PARTE(1) > PARTE(2) > PARTE(3) > PARTE(4)
["Hypersurface Architecture" è pubblicato originariamente da Academy Editions, una divisione di John Wiley & Sons. Disponibile nelle librerie, presso Barnes & Noble, e Amazon.com. La traduzione italiana è di Marco Brizzi]
Torna a: EXTENDED PLAY