|
|
| home |
| Tre parole per il prossimo futuro di Luigi Prestinenza Puglisi |
||||
| [in english] |
Mi sembra che stiamo vivendo un momento un po’ particolare. Di transizione. E come in tutti i periodi di transizione ci sentiamo in mezzo al guado. Abbiamo finalmente seppellito la nostalgia e lo storicismo. E una concezione meccanica e accademica della vita. |
[03feb2002] | ||
| >
MAILTO PUGLISI > LEZIONI > FORUM > PRINTABLE VERSION |
Abbiamo capito che la nostra epoca non è quella dei muri piacevolmente composti o delle finestre ritmicamente ripartite sulla facciata o del bel disegno urbano. Sappiamo che nelle piazze italiane, con edificio municipale e orologio al centro della facciata, non ci va più nessuno perché oramai le pratiche si sbrigano via posta elettronica e l’orario ce lo dice qualsiasi cellulare che portiamo con noi. Siamo convinti che non ha più senso progettare case tradizionali a schiera o in linea dai prospetti immacolati perché la famiglia tradizionale è latitante e, poi, nessuno vive più la mattina nella zona giorno e la sera nella zona notte. Sappiamo che i confini nazionali e municipali non hanno più senso e che presto saranno spazzati via i localismi architettonici. In Europa consumiamo gli stessi beni pagandoli con la stessa moneta, abbiamo gli stessi uffici, le stesse banche, gli stessi negozi e presto parleremo tutti la stessa lingua. Quando io ho fatto il mio primo viaggio a Londra fu per me un avvenimento. Per voi è già una semplice routine. Per i vostri figli sarà la cosa più naturale del mondo, anzi una necessità tanto quanto oggi fare la spesa al supermercato.  Sappiamo che in questa nuova società cambierà il nostro rapporto con lo spazio, con il tempo, con le tradizioni. Abbiamo preso consapevolezza del nostro futuro. Eppure, sebbene abbiamo capito ciò che bisognava lasciare, ancora non sappiamo quale direzione intraprendere. Andiamo avanti, ma ogni tanto vogliamo tornare indietro o perché capiamo che alcune strade non portano a nulla o perché vediamo che altre ci conducono verso qualche precipizio. Uno o due anni fa, paradossalmente, avevamo più certezze. Ricordo l’entusiasmo degli architetti a cavallo tra il 1999 e il 2000. Tutte le principali riviste –Domus,L’architecture d’aujourd’hui, Architecture, Architectural Review, solo per citarne quattro: una italiana, una francese, una americana, una inglese– hanno celebrato il nuovo millennio con ottimismo. Da poco erano stati inaugurati il museo Guggenheim di Bilbao di Gehry e il museo ebraico di Berlino di Libeskind. E alla Columbia University alcuni giovani architetti cominciavano a sperimentare con l’elettronica: Greg Lynn e Asymptote tra tutti. Gli stessi due che vennero selezionati per il padiglione americano della biennale di Venezia del 2000, diretta da Fuksas e battezzata con il titolo, in verità un po’ mariuolo, di Less Aesthetics More Ethics. Biennale, detto per inciso, che in Italia ha avuto il merito di scalzare definitivamente una classe di cariatidi che avevano ingessato il dibattito e la produzione architettonica. Dovevate vederle quando si aggiravano per i giardini della biennale borbottando e bofonchiando le frasi che normalmente dicono tutti i piccoli despoti quando si sentono scalzati dagli avvenimenti: dove andremo a finire… ma questa non è architettura… vorrei vederli realizzati questi progetti… siamo succubi dell’influenza straniera… Insomma, uno o due anni fa c’era più euforia. C’erano più speranze. Poi, un po’ come succede in tutte le rivoluzioni, sia pur minime e soprastrutturali come questa, si scopre che non è tutto oro quello che luccica. E che, per esempio, certi caporioni, che nel momento propulsivo sono stati sulle barricate, ora corrono ad accordarsi con i vecchi avversari per dividersi il potere. Viceversa, si vede correre gli sconfitti verso i vincitori. Affermando che non erano così contrari al nuovo, che Koolhaas in fondo loro lo hanno sempre studiato e che Zaha Hadid gli è sempre piaciuta… E si ripete, in piccolo, l’eterna storia secondo la quale 50 milioni di fascisti dal giorno alla notte si trasformano in 50 milioni di antifascisti. 50 milioni di democristiani diventano 50 milioni di antidemocristiani. Pur restando fascisti, pur restando democristiani. Oggi qualche migliaio di accademici sono diventati antiaccademici. Ma ci si può credere? Direi di no. Basta guardarsi intorno per vedere che è cambiato poco e nulla: come al solito, si sono trovati due o tre capri espiatori –Gregotti? Portoghesi? Grassi?- e tutto procede come prima. Con piccoli aggiustamenti, a dire la verità. Adesso Casabella è più leggibile. Nelle università stanno attivando qualche corso di architettura contemporanea. Si dà più spazio alle ricerche dei giovani italiani. Si storce meno il muso quando un architetto straniero fa una conferenza o vince un incarico.  Nello stesso tempo, come sempre succede, stiamo registrando l’inevitabile fatto che alcune ricerche, sulle quali si era riposta eccessiva speranza, stanno producendo scarsi risultati, girando a vuoto. Penso per esempio alle ricerche sulle sfogliatelle elettroniche. Greg Lynn o i NOX, per capirci. Per un certo momento ci si era illusi che la ricerca di queste forme complesse, bloboidali, aprisse nuovi orizzonti all’abitare, sostituendo al concetto di muro quello più interessante di membrana o di pelle. Oggi possiamo dire che abbiamo molte meno speranze al riguardo. E cominciamo a vedere che il concetto di membrana non è necessariamente connesso a quello di forma complessa. È questo un motivo per dichiarare fallimento? Certamente no. Intanto perché, come cercherò di mostrare in seguito, viviamo in un periodo caratterizzato da una pluralità di programmi di ricerca, spesso antagonisti tra di loro, ma tutti interessanti e innovativi. E poi perché il fallimento di qualche sperimentazione è inevitabilmente connesso con la dinamica di qualsiasi processo evolutivo. Freeman Dyson, un epistemologo tra i più acuti del nostro tempo, ne ha spiegato la ragione. Dice che la storia ha mostrato l’alto tasso di fallibilità delle idee umane e l’altissima percentuale di mortalità dei progetti di ricerca scientifici dovuti alla discrepanza inevitabile tra modelli e realtà. E ne ha tratto la conseguenza che se si investe il proprio futuro in un’unica idea forte e complessa, si è quasi certi di aver speso male risorse e energie. Se invece si punta su molti e opposti programmi, si ha la certezza, se non altro statistica, di azzeccare qualcuno. E quindi la speranza di procedere, invece che la certezza di fermarsi o arretrare. Ma, dirà qualcuno, è proprio necessario progredire a tutti i costi? E il così detto progresso è realmente fattore di reale progresso? O non è meglio fermarsi, fare il punto e in certi casi arretrare? Walter Benjamin, parlando dell’Angelus Novus, un quadro di Klee dove si vede un angelo sospinto dal vento e con lo sguardo proteso all’indietro, ci avverte: “vi si trova un angelo che sembra in atto di allontanarsi da qualcosa su cui fissa lo sguardo. Ha gli occhi spalancati, la bocca aperta, le ali distese; l’angelo della storia deve avere questo aspetto: ha il viso rivolto al passato, dove ci appare una catena di eventi egli vede solo catastrofe che accumula senza tregua rovina su rovina e la rovescia ai suoi piedi. Egli vorrebbe ben trattenersi, destare i morti e ricomporre l’infranto; ma una tempesta spira dal Paradiso che si è impigliata nelle sue ali ed è così forte che egli non può più chiuderle. Questa tempesta lo spinge irresistibilmente nel futuro a cui volge le spalle. Mentre il cumulo delle rovine sale davanti a lui nel cielo. Ciò che chiamiamo progresso è questa tempesta”. Il brano che vi ho appena letto potrebbe essere stato scritto in questi giorni. E non tanto per gli episodi cruenti, quali la distruzione delle Twin Towers e la guerra in Afghanistan, che sono sotto gli occhi di tutti: di guerre in fondo ce ne sono state sempre, anche e soprattutto nei momenti che noi consideriamo di pace. Quanto per l’intreccio tra violenza e velocità. Cioè quella miscela esplosiva propria delle nostre civiltà elettroniche che fa correre tutto, moltiplica le immagini, fa vivere in tempo reale gli avvenimenti anche i più remoti. Sentiamo di abitare, grazie ai nuovi media, come all’interno di un unico sistema nervoso in cui basta toccare una diramazione periferica per avere ripercussioni, in tempo reale, su di noi. Mai come oggi ci facciamo carico, psicologicamente, di tutti i problemi del mondo. Siamo angosciati del disastro ecologico che avviene in Nepal, siamo toccati dal conflitto palestinese e dalle sue ripercussioni in Europa, sappiamo che se una crisi economica colpisce il Giappone o gli Stati Uniti in poco tempo si ripercuoterà su di noi. Un po’ come Cristo sul Golgota siamo costretti, giorno dopo giorno, a vivere sulla nostra pelle, in contemporanea i problemi del mondo. E quindi ci chiediamo angosciati se non sia bene tentare di tornare indietro. Al tranquillizzante Mulino Bianco, alla città dello strapaese dove l’interrelazione avviene con 7 mila persone e su basi concrete e non con 7 miliardi e su basi astratte. E, da architetti, ci chiediamo se tutto questo progresso, questa elettrificazione del nostro habitat, questo diluvio di immagini, fax, computer, questa ossessione per la velocità, la puntualità, l’efficienza, la precisione non debba trovare nella casa e nell’architettura un momento di opposizione, di resistenza. In fondo, se guardate bene, lo stesso movimento No Global può essere letto in questa luce. Come il tentativo di fermare il vento che trascina l’angelo della storia. Per tornare a un rapporto più sano con la velocità: diminuendola, con la natura: riscoprendola, con le tradizioni: rivalutandola. Sono esigenze che non possono essere trascurate e non lo faremo. Nello stesso tempo non possiamo però non vedere come si corra il rischio di cadere in un’altra illusione. E, cioè, pensare che il passato sia stato effettivamente così come vogliono farci credere i nostri ricordi. Non è vero. Il passato è anche insopportabile: fonte di ansie e di angosce. E se proprio non è una immensa catastrofe -così come lo vedeva Benjamin ebreo e costretto al suicidio dal nazismo- certo ha poco a che vedere con i sogni che nei momenti di nostalgia, a occhi aperti, ci costruiamo. Se proprio vogliamo sognare è meglio allora sognare al futuro. Il sogno nel futuro è il progetto. L’unico che ci permette di concepire l’architettura come -diceva Persico- sostanza di cose sperate. Prefigurazione di un mondo che non solo evochiamo ma costituiamo sia pure attraverso una piccola opera. La quale certo non cambierà il mondo, ma con la sua tensione, renderà il nostro messaggio, la nostra speranza concreta. Visibile, sperimentabile, comunicabile. Proviamo, allora, a trovare tre parole che ci facciano uscire dalle sabbie mobili della nostalgia o del cinismo, provando a dare sostanza alla speranza. Sono tre: una in negativo e due in positivo. |
|||
|
1. No Logo La prima parola è NO LOGO. Ho riflettuto a lungo prima di proporla. Anche per paura di essere identificato con il movimento NO GLOBAL. Dal quale sono distante sia per generazione sia per ideologia. Avevo pensato alla parola NO STYLE. Ma poi, per i motivi che vedrete avanti, ho preferito NO LOGO. NO LOGO vuol dire, infatti,contro la firma. Contro l’oggetto venduto e acquisito non tanto per un suo valore in sé ma per un fatto di moda. Il logo è stato la invenzione brillante degli stilisti per vendere a prezzi altissimi prodotti in cui l’aspetto comunicativo sopravanza di gran lunga quello oggettivo. Paghi salata una borsa di Cartier non perché la borsa lo valga realmente, ma perché così puoi far sapere ai tuoi interlocutori che hai potere di acquisto sufficiente per permetterti accessori raffinati. Premetto: io non ho niente né contro l’uso di un oggetto a fini comunicativi, per così dire, extradisciplinari, né contro lo snobismo di alcuni che amano ostentare il loro status. Gente fessa ne è esistita da che mondo è mondo. Non solo, troppe persone che fanno finta di non ostentare, in realtà ostentano in modo ancora più insopportabile. Il problema non è moralistico. È nel cortocircuito tautologico: il nome sull’oggetto o la sua immediata riconoscibilità servono a far vedere che l’oggetto è stato fatto da quel nome. Con conseguente azzeramento, o meglio dire ridimensionamento, della ricerca sulla forma e sulla comunicazione. L’evoluzione -o involuzione, se volete- del logo è il CONCEPT. Si compra un prodotto perché suggerisce un modo di vita irrealizzabile ma consolatorio. Così io acquisto le NIKE, non solo perché tutti sappiano che faccio parte di un certo gruppo sociale o culturale, ma anche perché mi lascio coinvolgere dal sistema illusorio che la NIKE mi suggerisce con il suo prodotto. Un certo modello di vita sportiva, una certa etica, un modo di porsi rispetto alla natura… E così mi sento di abbracciare una filosofia che non corrisponde al mio modo effettivo di vivere ma è solo una proiezione dell’immaginazione, un wishful thinking. Oggetto quindi come maschera.  In architettura, prodotti con loghi così platealmente sfacciati come nel caso della moda non ce ne sono. Anche se lo Star System tende a muoversi verso il logo -questo è un Eisenman! questo è un Gehry! questo un Hadid!- non riusciamo mai a stabilire con certezza sino a che punto certe caratteristiche comuni tra serie di edifici derivino da un inflaccidimento modaiolo dell’artefice o non facciano parte di una coerente ricerca personale che quasi per necessità fisiologica lavora sulla sperimentazione di forme simili e/o ricorrenti. In architettura, i pericoli della caduta nella banalità, invece, si presentano attraverso lo stile. Lo stile, premettiamolo, non è di per sé un fatto negativo. Edoardo Persico sosteneva giustamente che ogni epoca e ogni persona devono avere il proprio stile. L’immagine esteriore di un uomo del Novecento non può essere simile a quella di uno del Quattrocento. E similmente un edificio dell’età dell’elettronica non può assomigliare a uno dell’età della meccanica. Tutti abbiamo uno stile e ciò è un bene. Ma –ecco il punto- se lo stile non corrisponde a un comportamento interiore è solo una maschera, come è una maschera il CONCEPT. Posso vestirmi da persona moderna ma essere un cavernicolo. Posso vestirmi da fantino ma non saper cavalcare un brocco. Purtroppo in architettura la confusione tra stile e sostanza è sempre avvenuta e a tutti i livelli. Sono state involucrate da facciate in stile funzioni moderne e, viceversa, si è evitato di fare ricerca sul funzionamento dell’edificio, accontentandosi di produrre forme avveniristiche. Specialista di questo modo torbido di vedere l’architettura sono rispettivamente Leon Krier e Philip Johnson. Leon Krier, aiutato e sponsorizzato dal principe Carlo, produce edifici e cittadine che sembrano medioevali, ma solo per nascondere impianti tecnologici d’avanguardia e garage alla vista delle persone. È la logica puritana: lo faccio ma non lo dico. Philip Johnson concepisce l’architettura come un rapido alternarsi di stili: tutti nuovi ma in fondo tutti uguali. È l‘apoteosi della forma, indipendentemente dalla vita di chi abita le architetture. Tutto è lecito. L’imperativo è essere moderni passando con disinvoltura dall’International Style, al Post Modern, al Decostruttivismo, all’architettura bloboidale. È la logica dello snob: lo dico ma non lo faccio. Per quanto Krier appaia diverso da Johnson, entrambi vivono una preoccupante scissione: tra forme e contenuti. Nessuno dei due si pone il problema, se non superficialmente, di cosa sia la vita oggi, di come l’uomo viva nello spazio, del suo rapporto con le tecnologie. Entrambi, più che risolvere i problemi, li rappresentano. Ecco in che senso NO LOGO. No alla rappresentazione e alla pura teatralizzazione. No, in sintesi, all’immagine di un mondo che come in Matrix è puramente illusorio. Se questo no è deciso, non possiamo non guardare con preoccupazione a tre fatti. Innanzitutto alla ascesa problematica del nuovo stile contemporaneo, l’Electronic Style o il Supermodernism, come lo chiama il critico Ibelings. Trasformato in maschera formale, come è avvenuto per l’International Style con la mostra del 1932 al MoMA, corre il rischio di diventare una nuova vulgata, una pappa buona per tutto. Alla disciplina architettonica, che non lavora sulle semplici immagini ma sui problemi, sulle contraddizioni e sulle opportunità di vita, non rimane che battere in ritirata. Non è un caso che la mostra del 1932 lanciò sul mercato solo una parte delle ricerche condotte negli anni venti e trenta,e per di più, banalizzandole. A scapito dell’approfondimento dell’eredità di geni quali Chareau, Haring, Scharoun, Mendelsohn, Buckminster Fuller, Duiker, i quali poco entravano all’interno dello stereotipo stilistico confezionato dal MoMA. La seconda cosa che vedo con preoccupazione è l’impacchettamento di edifici vecchi e stantii con forme avveniristiche. Non c’è oggi grosso studio di progettazione che non abbracci il nuovo. Persino Bofill. Ma, poi, gratta gratta e il vecchio emerge. Avveniva durante il fascismo con gli edifici di Piacentini o dei vari Del Debbio: apparentemente nuovi, in realtà obsoleti. E non è un caso che una delle frasi ricorrenti oggi sia: viviamo in un’epoca plurale, non ci sono più stili, non ci sono più avanguardie. State attenti: questa frase non è detta per giustificare una doverosa pluralità di ricerche autentiche, serie, vere. Ma per avallare il cinismo formale. L’opera di praticoni furbetti. Per mettere sullo stesso piano il generoso Persico e il turpe Ojetti, per livellare l’ineguagliabile Terragni o i generosi Figini e Pollini con gli spregevoli Calza Bini o il tronfio Vaccaro, oggi non a caso di moda. No. Non basta una spennellata di moderno per essere moderni. Moderno, come diceva giustamente il Professor Zevi, è solo colui che sa trasformare le crisi della propria epoca in valore. E al di fuori di una modernità sofferta e disturbata, aggiungeva, non c’è valore. Un terzo motivo di paura, anche se relativo, mi viene dall’analisi dei lavori di molti studenti. I quali spesso prendono un libro con le foto dei progetti di qualche grande architetto e li copiano. Oppure si mettono al computer e giù a strecciare forme per produrre progetti mirabolanti. Dicevo che è una preoccupazione relativa perché, da che mondo è mondo, gli studenti sgraffignano immagini dai progettisti più maturi. Fa parte del processo stesso dell’apprendimento. I cuccioli di animali imitano gli esemplari più adulti. Fa parte anche del processo di apprendimento produrre, grazie agli ausili tecnici, forme senza senso, nate casualmente, che però soddisfano i nostri occhi. Ma, attenzione, in Italia c’è una forte tendenza al formalismo, all’eclettismo e all’architettura disegnata. Non vorrei che questa generazione sfuggisse alle frustrazioni di un mercato edilizio in crisi, rifugiandosi nel calligrafismo. Perdendo in capacità tecnica, diventando produttori di immagini che qualche altro tecnico dovrà concretizzare. Tanto, come si dice, poi, ci pensa la Arup. |
||||
|
2. Multiculturalismo La seconda parola per il prossimo futuro è multiculturalismo. Anche in questo caso non confondetemi con un NO GLOBAL. Io credo fermamente nei valori della cultura occidentale. Sono nato a Catania, ex città greca e vedo con orgoglio il filo conduttore che va da Eraclito a Platone, da Erasmo a Bacone, da Kant a Feyerabend. Ma, come tutti gli occidentali, so che la nostra cultura si è sviluppata e si sviluppa solo perché ha saputo sempre accogliere il punto di vista degli altri, mettendosi in crisi. È una delle poche, se non l’unica, ad aver fatto del principio della tolleranza e dello scambio dialettico il proprio punto fermo e irrinunciabile. Tanto che, pensateci bene, le nostre concezioni più ferree e strutturate, che sono quelle scientifiche, si basano proprio sul principio della falsificazione. Vere, cioè, sino a prova contraria. Con il paradosso che ricercatori e scienziati, a differenza di quanto avviene per le culture dei sistemi tradizionali o totalitari, sono pagati non per avvalorare le teorie esistenti ma per metterle in discussione. Non è azzardato affermare che la nostra è una cultura fondata sulla crisi, o meglio sulla gestione della crisi. E, grazie a questo atteggiamento ipercritico, abbiamo metabolizzato culture arabe, orientali, pagane, indiane, persiane, cristiane, ebraiche, esoteriche, essoteriche tra di loro diversissime. Un po’ come fece Wright che per produrre la stagione dei capolavori iniziata nel 1936 passò due decenni a metabolizzare prima la cultura europea con il viaggio del 1909, poi la cultura giapponese con l’Imperial Hotel, la meso-americana con le case angelene e infine quella dell’International Style con la mostra del 1932 in cui lui fu umiliato ed emarginato. Cosa avevano, però, di giapponese le case giapponesi di Wright? E di meso-americano la Hollyhock o la Storer? Tutto e niente. Perché erano passate attraverso il setaccio di una cultura che le aveva assorbite. Guardate adesso la Casa sulla Cascata: vi leggerete il viaggio in Europa, la riflessione sull’International Style, la cultura giapponese e anche la meso-americana. Ma, ricostruite in forma nuova. 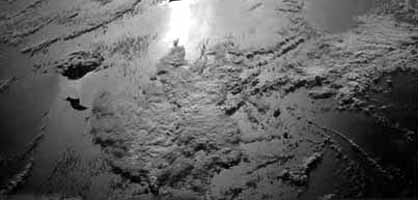 Vi ho fatto questo esempio perché è un po’ così che vedo la globalizzazione. Con la differenza che l’architettura di Wright è stata frutto della volontà ferrea di un genio che seppe ricrearsi a 69 anni. Mentre il processo di globalizzazione ha una sua inevitabilità epocale. Guardate ciò che sta avvenendo in Russia, in Cina, in India e capirete che è il destino dell’umanità. Ciò non vuol dire che si tratti di un processo semplice e senza costi: la globalizzazione spezzerà tradizioni, eliminerà modi di vita, farà scomparire dialetti e etimi locali. Ma anche l’invenzione della scrittura provocò un parapiglia simile, tanto che si narra che il faraone maledì colui che, inventando i geroglifici, aveva distrutto la cultura orale e la sua poesia. Né vuol dire che gli occidentali si comportino sempre nel migliore dei modi. Anche se io non credo che tutte le colpe che gli vengano attribuite siano loro -in buona parte sono dei governi corrotti dei Paesi che la globalizzazione la subiscono- basta leggere il bel libro della Naomi Klein “NO LOGO” per scoprire quanto avidi e malfattori siano i governi occidentali e le imprese multinazionali. Ma i problemi si risolvono. E basta vedere l’evoluzione storica da un punto di vista sufficientemente lontano per capire che il processo tende alla positività. Anche se con lentezze deprimenti e passi indietro angoscianti. Comunque, se, nonostante questi inevitabili problemi, la globalizzazione saprà assorbire la pluralità dei mondi locali, porterà a un arricchimento dei sistemi di vita. Io cerco di vederla come una medaglia a due facce. Da un lato della medaglia c’è la standardizzazione dei comportamenti. Gli aeroporti, gli ospedali, i sistemi di servizi che tendono a diventare l’uno uguale all’altro. Che differenza sostanziale c’è, oggi, tra Fiumicino e Heatrow? O tra l’aeroporto di Singapore e quello di Chicago? Questa omogeneizzazione, che è stata studiata da Marc Augé nel libro Non Luoghi, è in fondo positiva e tranquillizzante. Sappiamo che in qualunque parte del mondo possiamo accedere allo stesso livello di servizi e, probabilmente, al medesimo livello di sicurezza. Chi di noi atterrerebbe con fiducia in un aeroporto africano gestito con criteri LOCAL? La ricerca di livelli di servizio razionali e standardizzabili in tutto il pianeta richiede ricerca e capacità innovativa. Innanzi tutto, una riflessione sul ruolo delle tecnologie elettroniche. Pensate per esempio a come le funzioni bancarie si siano diffuse su scala planetaria grazie alle carte di credito e ai bancomat. Oppure, a come sia cambiato il sistema di distribuzione librario a seguito delle vendite per corrispondenza via posta elettronica. Non solo nel senso che queste hanno permesso l’acquisto di libri in rete , in ogni ora del giorno, da qualsiasi luogo della terra e con cataloghi giganteschi, ma anche nel senso che la concorrenza di giganti quali Amazon ha imposto alle librerie su strada di cambiare la loro vecchia fisionomia: facendole diventare da luoghi angusti e polverosi a spazi più appetibili e antivirtuali, dove il libro si può toccare e anche leggere sorseggiando un caffè. È errato quindi vedere l’omogeneizzazione solo come una perdita. Rappresenta una continua messa in discussione, e in positivo, dei modelli insediativi e abitativi consolidati. E se ancora non ci credete e pensate all’omogeneizzazione solo sub specie Mc Donald, per rendervi conto delle opportunità che ci si prospettano, leggetevi il magnifico libro E-TOPIA di William J. Mitchell. Anche senza voler far riferimento alle possibilità dell’elettronica, una certa omogeneizzazione del resto è già un dato di fatto. Mi ha colpito molto in proposito il lavoro di un reporter che è andato in giro per il mondo e, in ogni paese, ha convinto una coppia a mettere per strada l’arredamento della propria abitazione per poterlo fotografare tutto insieme. Ebbene: la stragrande maggioranza delle persone –russi e americani, polacchi o napoletani- aveva mobili simili. Cioè vivevano secondo uno stesso modello di vita. Perché vedere tutto questo in negativo? E non come la realizzazione, sia pur minima, di un principio di uguaglianza e di omogeneità, per la quale, solo per fare un nome, la cultura architettonica e urbanistica ha nel 1900 lottato? Io credo che bisogna affrontare il tema senza tabù. Senza certo cretinismo NO GLOBAL che è simile a certo cretinismo ecologista. Fatto cioè di persone che al posto di andare da Mc Donald’s vanno alle trattorie Little Italy dove ti danno la pasta precotta riscaldata al microonde e te la fanno passare per fatta da nonna Giulia. Così ti fanno anche pagare il doppio. Dicevamo prima che la globalizzazione ha due facce. Se la prima è l’uniformità, l’altra è la diversità. Produce ciò che gli americani chiamano un melting pot, un calderone che mette sotto lo stesso tetto uomini, tradizioni e costumi diversi i quali, per quanto si confrontino e si omogeneizzano, tendono sempre a conservare una propria individualità. E la diversità entra in gioco producendo valori positivi e straordinarie ibridazioni. Lo ha sempre fatto nella storia; con la civiltà ellenistica, con quella romana, con la cultura americana del dopoguerra. E continua a farlo. Oggi nella letteratura di lingua inglese i più bravi sono gli scrittori stranieri, indiani e pakistani in prima fila, per le loro invenzioni linguistiche e narrative. Tra questi il recente Nobel Naipaul. E la diversità ci sprovincializza, ci fa accettare l’altro. Ricordo la paura e la curiosità con la quale entrai in un ristorante cinese trent’anni fa. Oggi, gli italiani che prima mangiavano solo pasta asciutta non esitano a mangiare cibi diversi, anche esotici. Ecco perché, io credo che in architettura, il localismo, sia un’utopia regressiva. Perché non tiene conto del modo in cui effettivamente cambiano i comportamenti reali della popolazione, della ricchezza degli scambi e delle interrelazioni. Anche il Regionalismo critico proposto da Kenneth Frampton, e cioè un’architettura che risponda alle esigenze del luogo e del contesto per porsi polemicamente contro la globalizzazione, è spesso simile alla pasta precotta e riscaldata al micro-onde di cui parlavamo prima. È, invece, molto più interessante la posizione degli architetti olandesi, Koolhaas in testa, che con questi temi cercano di dialogare criticamente. Introducendo, all’interno delle architetture globali che producono, la multiculturalità e, a volte, anche la multietnicità, cioè i modi diversi di uso dello spazio che le nostre complesse società impongono. |
||||
|
Ecologia La terza parola è ecologia. Anche per questa ho bisogno di fare una premessa. Non sono ecologista. E detesto gli ambientalisti quasi quanto i Soprintendenti. Non riesco, infatti, a capire l’accanimento con il quale difendono alberi e giardinetti mentre dimenticano le condizioni di vita più generali del nostro habitat. Non amo il loro atteggiamento anti-industriale e il loro approccio cavernicolo e rinunciatario all’ambiente. Detesto le loro bugie, anche se dette a fin di bene, e sono stato felice quando un scienziato ex-ambientalista, di cui non ricordo il nome, credo di nazionalità svedese, le ha denunciate in un libro che sta avendo grande successo. Nonostante tutti i lamenti dei Verdi, la vita media aumenta, il benessere lo tocchiamo con mano, le risorse energetiche ci sono, il buco dell’ozono regredisce. Allora va tutto bene? Per niente. Problemi ce ne sono, eccome. Ma non possono essere risolti con la cultura del piagnisteo, così meravigliosamente stigmatizzata da Hughes in un suo magnifico libro. Ognuno di noi, e soprattutto chi vive nelle grandi città, sa quanto smog ci sorbiamo, quanto tempo perdiamo negli ingorghi stradali, quanto rumore dobbiamo patire. E sappiamo anche che nei paesi in via di sviluppo, ai quali esportiamo le nostre peggiori tecnologie, queste condizioni sono molto più critiche. In India, in Cina, in Medio Oriente, nei Paesi dell’Est il rumore è infernale, lo smog ha superato i livelli di guardia, il traffico così convulso che solo un guidatore locale ci si può raccapezzare. Ma l’inquinamento è anche di altra natura. E’ nel tempo che perdiamo negli uffici postali per fare una fila, nell’attesa a una fermata dell’autobus, nel girare per ore alla ricerca di un parcheggio, nello stare scomodi a sentire una lezione universitaria, nella corsia di un ospedale antiquato. Ecco cosa intendo per ecologia; è il rapporto tra l’uomo e l’ambiente, non solo quello naturale ma, anche e soprattutto, quello artificiale. Se così è, che senso ha impedire la costruzione di un parcheggio per non abbattere un albero quando il parcheggio produrrà benefici infinitamente superiori a quelli arrecati dall’albero? E che senso ha ricercare dentro la metropoli, che è un prodotto assolutamente artificiale, piccoli frammenti di natura, se poi questi compromettono realizzazioni più significative? Anche in questo campo, mi sembra che gli Olandesi siano per noi dei buoni punti di riferimento. Intanto perché hanno realizzato un eccellente paesaggio artificiale, strappandolo anche al mare. E poi perché da sempre lavorano su entrambi i termini -natura e architettura, artificiale e naturale- cercando sempre di metterli in relazione. Pensate al padiglione di MVRDV per Hannover. È una ingegnosa costruzione per moltiplicare lo spazio pubblico e anche la dotazione di verde. Oppure alla biblioteca di Delft di Meccanoo dove viene realizzato un piano inclinato artificiale che è contemporaneamente tetto della biblioteca e spazio verde all’aperto. Potremmo continuare con Koolhaas, Arets, West8. In tutti i casi emerge la volontà di non dividere nettamente costruzione e natura, edificio e paesaggio. Su questa linea mi sembra che, oggi, si stia muovendo e con successo buona parte della ricerca architettonica contemporanea. Eisenman,Wines, RoTo, Morphosis, Holl solo per citare alcuni. E Zaha Hadid che non solo progetta un padiglione a Weil am Rhein in cui il percorso si confonde con la costruzione ma anche che realizza per Roma il progetto di un museo dove non c’è più differenza , se non di intensità, tra edificio e spazio urbano. Tutti i progetti che vi ho sinora citati ricorrono però a tecniche costruttive per così dire tradizionali. Oggi, grazie all’elettronica, possiamo andare oltre. Concepire lo spazio non più come un contenitore delimitato da muri ma come teatro di interrelazioni tra l'uomo e l'ambiente: pensare a sensori che controllino l’afflusso di luce, gestiscano l’ottimizzazione energetica, ottimizzino le visuali. Possiamo anche pensare a un ambiente che muti in relazione ai mutevoli bisogni, anche psicologici, di chi lo abita. Insomma l’architettura da fredda e immutabile può diventare vibrante e mutevole. E gli edifici diventare entità sensibili con le quali interagire; oggetti che si adattano al nostro modo di vivere lo spazio, che si trasforma in una nostra seconda pelle. Quasi sicuramente, la conseguenza di questa rivoluzione sarà la smaterializzazione dei contenitori: i muri da stabili, immobili, sordi, perderanno peso, guadagneranno in leggerezza, acquisteranno, esattamente come un sistema nervoso, intelligenza. E si proietteranno verso la natura e il contesto circostante di cui, finalmente, riusciranno a captare creativamente le luci, i suoni, gli odori. Concretizzeremo così le intuizioni che negli anni Sessanta e Settanta avevano avuto alcuni architetti d'avanguardia: gli Archigram in Inghilterra, i Metabolisti in Giappone, i Situazionisti in Francia, Archizoom e Superstudio in Italia. E le potremo realizzare perché oggi siamo supportati da maggiori mezzi tecnici. Tuttavia, come vi accennavo in apertura, in questi anni ci stiamo accorgendo che una eccessiva elettrificazione del mondo produce anche problemi. Che vivere all’interno di un sistema nervoso globale, e dal quale non ci si può neanche a tratti staccare, produce insopportabile angoscia. Che la fulmineità imposta dall’elettronica può essere fonte di insopprimibile ansia. E che alla velocità dell’aereo, della quale non possiamo più fare a meno, dobbiamo affiancare la lentezza del bradipo. Una moderna visione ecologica dovrà tentare di trovare una conciliazione, realizzando spazi sia per lo sprint di chi vuole correre, sia per lo splash di chi vuole fermarsi. Ma dovrà farlo senza guardare all’indietro, senza la nostalgia di paesaggi incontaminati che oramai non ci appartengono, se non altro perché li abbiamo già tutti antropizzati. E, da architetti, dovremo fare i conti con un dato: negli edifici di produzione comune, privi di particolari qualità architettoniche, il costo della struttura è passato dall'80% al 20% mentre quello degli impianti è salito progressivamente sino al 35%. E tende a crescere. E crescerà sempre di più con l'avvento dei cosiddetti edifici intelligenti nei quali l'informatica permette nuove forme di controllo ambientale e della sicurezza. Come fare in modo che questa intelligenza sia non solo quella tecnica dell’ingegnere ma anche quella umana dell’architetto, sarà il compito con il quale dovrete misurarvi. Luigi Prestinenza Puglisi L.Prestinenza@agora.stm.it |
||||
|
> FORUM > LEZIONI > SEMINARIO > SCUOLE |
||||
per
qualsiasi comunicazione laboratorio |