| [in
english] |
|
La mostra AAproject review, svoltasi all'Architectural Association
School of Architecture di Londra, è il punto di partenza per intraprendere
un viaggio nel nuovo dibattito architettonico, alla conoscenza di
nuovi campi di ricerca, dove una nuova architettura potrà presto prender
forma. Nuovi territori dove arte, architettura, tecnologia, scienza
si fondono e insieme sperimentano nuove strade di ricerca.
Patrick Schumacher, partner di Zaha Hadid e professore al AADRL post-graduate
course, racconta questi nuovi domini dell'architettura che si propongono
come una difficile sfida per il mondo dell'architettura del domani,
spiegandoci il suo punto di vista e i diversi approcci dei suoi studenti.
ALESSANDRA BELIA: "AAProject Review" è il nome della mostra organizzata
dall'Architectural Association di Londra. Questa mostra rappresenta
un vero evento culturale e attrae visitatori da tutto il mondo. È
il momento in cui l'AA school apre le sue porte ad una comunità più
ampia, stimolando percezioni e ravvivando il dibattito sul ruolo dell'architetto
e sull'architettura, oggi e nel futuro, in campo nazionale e globale.
Qual è la sua opinione sulla mostra come manifestazione del pensiero
corrente e dell'attuale produzione?
PATRICK SCHUMACHER: Penso che la mostra "Project Review", organizzata
dall'AA, non sia rivolta ad un pubblico generico o a un turismo culturale.
È un evento interno alla disciplina o alla professione ed è, curiosamente,
un evento che ha particolare importanza per il dibattito interno alla
scuola. È quasi uno specchio, creato dalla scuola, affinché le differenti
units -che, durante l'anno lavorano autonomamente e senza avere
molti contatti- possano valutare le proprie produzioni.

Project Review exhibition. DRL exhibition room.
Ma, come è ovvio, il mondo architettonico e le diverse scuole di Londra
costituiscono la parte principale degli spettatori. E se si può parlare
di turismo culturale deve trattarsi di neo-studenti di architettura
e giovani architetti, che giungono a Londra dall'estero per vedere
la mostra. Soprattutto gli ex studenti vogliono osservare i lavori
di nuova generazione e desiderano rimanere in contatto ed esser aggiornati
sulle nuove ricerche che circolano nella scuola. Infatti, la ricerca
nella scuola evolve molto velocemente, ed è quindi necessario venire
ogni anno per esser sempre al passo con la rapidità dello sviluppo.
È importante comprendere che alcuni dibattiti interni alla disciplina
architettonica e alla professione non hanno molto significato per
un pubblico generico. Perché il pubblico generico dovrebbe confrontarsi
con processi di design, concetti astratti o esperimenti non finiti?
Questi problemi riguardano soltanto la comunità degli architetti.
L'Architectural Association di Londra è una scuola dove nascono
nuove idee e dove esse vengono esplorate in modo sperimentale. La
mostra "Project Review" sottolinea questa vitalità. Possiamo considerare
questa produzione come una "nuova architettura di avant-garde"? Come
potrebbe descrivere e definire l'attuale concetto di progresso in
architettura?
Fino a quando l'architettura non avrà specifici istituti di ricerca,
finanziati da appositi fondi per la ricerca, la funzione di ricerca
e innovazione continuerà ad esser svolta dalle istituzioni accademiche
e dai settori più all'avanguardia della professione. Il settore industriale
privato è composto da grandi società, che possono permettersi di istituire
dipartimenti per la ricerca e lo sviluppo. La medicina ha il supporto
di istituti di ricerca, che ricevono finanziamenti pubblici e svolgono
la loro attività all'interno del sistema universitario. Nel mondo
dell'architettura la ricerca non riceve, invece, né finanziamenti
pubblici né finanziamenti privati.
Le scuole come l'AA –e, in particolare, i corsi universitari e post-universitari–
giocano un ruolo fondamentale nel processo di ricerca e innovazione.
E sia il lavoro che la risorse umane si nutrono direttamente nel settore
di avanguardia della professione. Questo fenomeno riguarda poche scuole
di alto profilo nel mondo dell'architettura, e l'AA school è certamente
in prima fila nel dibattito internazionale che riguarda l'architettura
d'avanguardia. Tale ricerca è svolta sia dai professori che dagli
studenti.
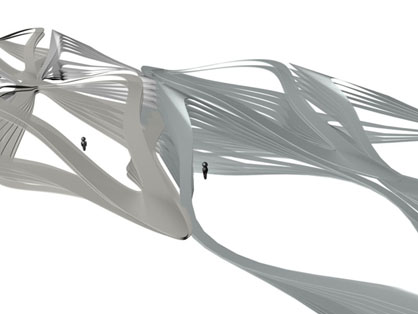
Project: Pneu_WAVE: mass mobilization and inflatable environments
by MassiveATTRACT. Cell structure of LHR_X airport.
I professori dell'AA, collaborando con gli studenti, guidano il loro
lavoro dentro questa ricerca. Il lavoro di design non è visto come
un esercizio, che consente di ottenere una specifica competenza. Il
lavoro, mediante la sperimentazione, ha proprio per oggetto il progresso
oltre lo stato dell'arte: vengono così aperte nuove strade, non offerti
prodotti finiti.
In che modo la varietà di metodi e di approcci che vengono proposti
dall'Architectural Association, consentono di immaginare e di creare
una nuova e migliore alternativa a ciò che già esiste?
In primo luogo, è opportuno ripetere che tutto gira intorno alla ricerca
di alternative a ciò che già esiste. Sarebbe però ingenuo credere
che tali alternative siano subito migliori delle soluzioni già esistenti
e testate. Le alternative in questo contesto sono passi nel buio verso
nuove direzioni, che non offrono soluzioni migliori, ma possibilità
e opportunità per ulteriori ricerche. Questo lavoro è rivolto in avanti
verso migliori soluzioni.
La sua domanda ha anche riguardo alla varietà di metodi e approcci,
che operano nella scuola. Alcune volte, la scuola si compiace di offrire
una vasta scala di approcci. Ciò può sembrare un vantaggio, ma penso
che possa anche diventare un problema se le diverse units non
focalizzano su una soluzione condivisa da tutti. Un obiettivo comune
rende possibile che una competizione produttiva si sostituisca al
conflitto ideologico. Fa sì che le units parlino fra loro ed
abbiano molto da imparare le une dalle altre. Penso inoltre che la
scuola si auto-organizzi, nel senso che essa sviluppa, al suo interno,
dei movimenti coerenti, che riducono temporaneamente le diversità
e creano gruppi di units che lavorano intorno allo stesso problema.
Ciò nasce come una dinamica di gruppo all'interno del corpo-studenti,
forse indipendentemente dalla molteplicità dei professori.
Penso che ciò sia molto importante. Facendo un paragone tra l'AA school
e la Columbia University, suo principale concorrente, direi che la
Columbia è stata più coerente. È vero che l'AA offre maggiore diversità,
ma attualmente vi sono movimenti tra le due scuole, che fanno nascere
strade di ricerca nelle quali professori e studenti sentono di partecipare
allo stesso processo di ricerca.
Che impressione dovrebbe percepire il visitatore vivendo questa
esperienza estetica della mostra? È più arte o architettura? Suggerisce
una visione utopica o radicale della società? Oppure un nuovo modo
di descrivere differenti concetti dello spazio architettonico... o
un modo futuristico di vivere?
Mi sembra che la domanda sia volta a conoscere se poniamo maggiore
attenzione alla forma spaziale o al contenuto sociale.
In definitiva, dobbiamo preoccuparci di entrambe le cose. L'innovazione
è innovazione della forma architettonica, della forma spaziale o organizzazione
spaziale, della logica di connessioni, etc., ma ciò ha un senso solo
se il processo di vita assume questa nuova forma e se tale forma è
per esso necessaria. La ricerca è sempre duplice: da un lato, essa
ha per oggetto lo sviluppo degli spatial vocabularies; e, dall'altro,
le social tendencies o institutional patterns. Pertanto,
normalmente si ha una scissione tra units che si concentrano
sulla ricerca sociale, e altri gruppi che lavorano su forme spaziali
complesse e, forse, quelli che si pongono domande sulla struttura
e sulla produzione. Può apparire un errore che si creino, in tal modo,
due culture di ricerca separate, ma, alla fine, questa temporanea
separazione e divisione di compiti si rivela necessaria. È comunque
altrettanto necessario che le due aree di ricerca finiscano per collaborare
e fondersi. Deve inoltre sottolinearsi che gli studenti non si limitano
ad esporre disegni o astratte rappresentazioni di idee, ma offrono
una sorta di simulazione sperimentale, una sorta di immersive space
che prende il luogo dell'edificio da progettare. Lo spazio espositivo
non mostra soltanto rappresentazioni architettoniche ma diventa esso
stesso un spazio progettato che esplora molteplici concetti spaziali.
I suoi studenti hanno investigato il concetto di "responsive environment",
cercando di dare un contributo originale a questo campo nuovo e complesso.
Ma quale è il reale significato del concetto di "responsive environment"
nel dibattito architettonico? E quale è il suo approccio a tale concetto?
"Responsive Environment" è il titolo della nostra attuale agenda di
ricerca. È una sfida affascinante, poiché è un campo del design totalmente
nuovo, e, forse, non è neppure necessario assumere che l'architettura
sarà in grado di far proprio questo nuovo settore come un territorio
suo proprio. Il "Responsive Environment" potrà forse diventare un
settore autonomo, e consentire la collaborazione tra industrial
design e interaction design, che in questo momento è soltanto
una disciplina che fa parte del campo del web-design, che talvolta
ancora collabora fuori dal campo del graphic design. Fuori
dalla sfera dell'interaction design potrebbe nascere un gruppo di
persone che lavorano sia nel mondo reale sia nel mondo virtuale.
In ogni caso, penso che l'architettura sia, forse, la disciplina del
design più adatta a portare avanti la ricerca in questo territorio
inesplorato. Possiamo prevedere che gran parte degli spazi architettonici
diventeranno responsive e saranno animati mediante capacità
cinetiche intelligenti. Ciascuno spazio avrà una serie di sensori,
grazie ai quali gli occupational patterns potranno esser registrati
nello spazio e restituiti alle strutture reattive intelligenti. Ciò
può funzionare in una moltitudine di gamme e livelli. Penso che stia
emergendo una nuova era nell'architettura –o tra l'architettura e
altre discipline– che nel futuro avrà sicuramente una gran mercato.
Questo sarà il prossimo grande passo nello sviluppo tecnologico.
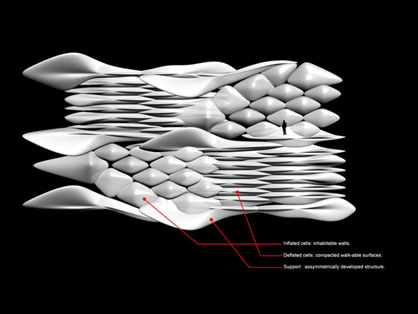
Project: Pneu_WAVE: mass mobilization and inflatable environments
by MassiveATTRACT. Cell structure of LHR_X airport.
L'AADRL è un gruppo di design isolato, che, già da qualche anno, lotta
da solo per portare avanti questa sfida. Fino ad ora, soltanto gli
artisti, o gli ingegneri, specializzati in robotica, vicini al mondo
dell'arte, hanno lavorato in questo particolare contesto. Così, nel
mondo dell'arte esistono lavori, installazioni, ambienti, che ricercano
l'interattività. Questo è solo un altro esempio, che dimostra come
il mondo dell'arte sia l'area più aperta e indeterminata della ricerca
sociale e tecnologica. È qui che vengono scoperti e sperimentati i
nuovi fenomeni. Ed è qui che è possibile investire senza alcun fine
pratico e criterio di performance. Il fatto che l'architettura
si cimenti in questo settore dello sviluppo indica che siamo già un
passo oltre la pura sperimentazione o la pura magia delle potenzialità
e degli effetti della tecnologia. Il coinvolgimento dell'architettura
dimostra che stiamo cercando di portare queste possibilità aperte
e infinite al livello successivo, prendendo in considerazione condizioni
che operano in ambienti istituzionali e scenari con significato sociale.
Assistiamo, per esempio, allo sviluppo di sistemi interattivi, sia
nei complessi residenziali che negli ambienti di lavoro, ponendo attenzione
alle tendenze innovative nell'attuale organizzazione di impresa. Al
momento, stiamo studiando gli aeroporti: un settore che accoglie molteplici
servizi, che potranno migliorare grazie a nuove capacità comportamentali
di ciò che li circonda.
La ricerca svolta dal AADRL prova ad indagare il modo in cui uno
spazio si evolve, piuttosto che progettare uno spazio, per creare
e studiare un nuovo tipo di ambiente e una immersive architecture.
Attraverso l'uso di moderni software, siamo in grado di creare, controllare
e modellare un nuovo concetto di spazio, dove la dinamica del flusso
delle persone e la loro stessa autonoma riorganizzazione sono riflesse
nelle risposte registrate di uno spazio che si adatta cineticamente.
Si ha questa nuova capacità di creare spazî strettamente legati a
chi usa gli spazî medesimi, generando così complessi sistemi comportamentali.
Che cosa ne pensa?
Penso che al Design Research Lab stiamo cercando di sviluppare queste
nuove capacità; capacità che sono già state esplorate nell'arte. Stiamo
anche cercando di importare idee dalla robotica e dalla bio-mimetica.
Stiamo scoprendo un nuovo paradigma tecnologico al fine di avere una
nuova opportunità di progettare lo spazio sociale come uno spazio
vivente e interattivo, su scala urbana, o su scala rapportata ad un
edificio,oppure progettando su piccola scala. Il compito è molto ambizioso.
La difficoltà è che questo compito richiede tutta una serie di discipline
avanzate e di notevoli capacità tecnologiche. Come scuola, la competenza
tecnica necessaria non può esser fornita da consulenti specializzati.
Dobbiamo, infatti, costruire la nostra base di ricerca grazie ai risultati
dei nostri team di studenti.
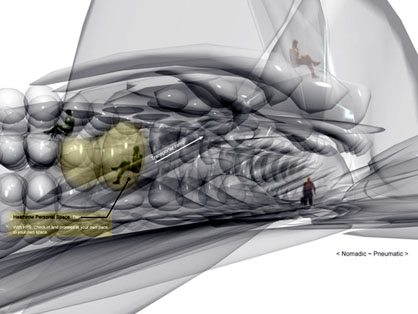
Project: Pneu_WAVE: mass mobilization and inflatable environments
by MassiveATTRACT. Interior view showing inflatable environment
of LHR_X airport.
Vengono organizzati gruppi di ricerca che portano avanti diversi tipi
di specializzazioni. C'è bisogno di form-maker e c'è bisogno
di sviluppare strutture, c'è bisogno di sviluppare meccanismi cinetici
e c'è inoltre bisogno di studenti che abbiano capacità analitiche
e che alla fine qualcuno acquisisca conoscenze di base sull'uso di
software. Inoltre, c'è bisogno anche alcuni gruppi di studenti che
abbiano una immaginazione rivolta al miglioramento sociale e che possano
osservare, analizzare e simulare il comportamento collettivo delle
persone. Tutto questo comporta una certa definizione del concetto
di behavioral patterns che conduce alla progettazione di agenti
che siano in grado di auto-organizzarzi nella vita come pattern.
Questi comportamenti simulati possono allora essere confrontati con
pattern conosciuti, che ritroviamo in spazi pubblici e che
sono, probabilmente, video registrati dagli studenti. I pattern
generati dal movimento in spazi pubblici devono essere analizzati,
e la loro logica sociale deve esser capita e ricostruita attraverso
agenti programmati.
Noi lo consideriamo come il dominio sui-generis del design. È proprio
questa la parte del paradigma dilatato dell'architettura che noi stiamo
promuovendo. Non stiamo soltanto progettando un involucro vuoto ma
stiamo anche immaginando un tipo di coreografia di use-pattern
che nascono con l'interazione delle nostre strutture. Questo è
certamente un nuovo e entusiasmante punto di partenza per l'architettura.
C'è sempre stato il desiderio di raggiungere questo traguardo. La
massima ambizione dell'architettura è sempre stata quella di progettare
il tessuto sociale attraverso la progettazione del suo contenitore.
Oggi c'è la possibilità di simulare il comportamento sociale all'interno
del suo ambiente progettato.
Ciò rappresenta un enorme progresso nelle nostre capacità progettuali;
ed è consentito da software sofisticati come 3ds Max e Maya - potenziati
da diversi plug-in. Questi programmi erano inizialmente rivolti
all'industria cinematografica. Adesso questi strumenti di animazione
ci permettono di progettare e generare scenari interattivi e che si
autorganizzano.
Nel contesto della mostra il DRL ha presentato il suo lavoro di
ricerca basato su diversi sensori che attivano tecnologie collegate
ai computer e che simultaneamente reagiscono all'organizzazione spaziale
dei visitatori. Allo stesso tempo, prototipi di robot mostrano forme
di intelligenza artificiale e di ambienti cinetici sempre più avanzati.
Inoltre, l'attuale ricerca è volta allo sviluppo di strumenti per
progettare e simulare sistemi, che rispondono ad interazioni dinamiche
coinvolgenti l'uso di tecniche come scripting, force-fields,
inverse kinematics... etc. A suo parere, quali sono i nuovi
domini che questa ricerca sta aprendo?
Il tipo di software di animazione che stiamo utilizzando non soltanto
sta aprendo nuove possibilità tecniche, ma propone anche un nuovo
modo di pensare. Stiamo modellando mondi artificiali con le loro peculiari
leggi di "quasi-natura". È proprio come creare un piccolo universo
nel quale qualunque oggetto o elemento può essere interattivamente
posto in relazione con qualsiasi altro oggetto o elemento. All'interno
di un mondo artificiale, proprietà e relazioni di elementi possono
essere tradotte in funzioni, in reazioni a catena e in complesse reti
di interazioni. È come scrivere le leggi di un universo artificiale.
Per cui si può creare un intero sistema di correlazioni lecite, e
lasciarle agire attraverso scenari sempre in evoluzione. Questa è
una nuova e affascinante partenza. Lo sviluppo delle funzioni dei
software fa sì che i programmi per progettare questi nuovi mondi siano
così facili da utilizzare, da rendere inutili i programmatori. Il
designer può creare questi affascinanti mondi interattivi. Ci sono
realtà che prima di tutto nascono nel computer, ma possono essere
realizzate nel mondo reale dal momento che sensori, attuatori e chips
diventano sempre più utilizzabili. E questa produzione di modelli
responsive rappresenta un altro importante passo a cui stiamo
lavorando – soprattutto nella forma di modelli in scala.
Stiamo progettando modelli che sono attivati da muscoli pneumatici
e che sono attivati da una serie di sensori al fine di creare il primo
tipo di prototipo di un responsive environment. Tre di questi
modelli sono stati recentemente esposti alla mostra Latent Utopias,
che ho curato personalmente per il festival delle arti tenutosi a
Graz lo scorso anno. Gli studenti del AADRL vi hanno partecipato insieme
a illustri architetti di avant-garde di fama internazionale.
Alla mostra "Project Review"organizzata all'AA abbiamo mostrato gli
stessi prototipi cinetici che hanno riscontrato un così largo successo.
Questi modelli non rappresentano solo affascinanti gadget ma sono
parte di un più vasto progetto che è analizzato con riguardo al suo
significato sociale e alle sue implicazioni estetiche.
Lei ha detto: "Qualsiasi parametro di qualsiasi oggetto potrebbe
essere dinamicamente relazionato con qualunque parametro di qualunque
altro oggetto dentro il modello". Ciò significa che il designer ha
la libertà e il potere di plasmare mondi artificiali, ognuno con la
sua particolare "legge di natura". Questa potrebbe essere la chiave
di lettura per capire questi nuovi "responsive environment"? Siamo
arrivati a ciò che potremmo chiamare "stadio di mutazione"?
Prima di tutto, penso che questo concetto sia molto importante. Gli
oggetti e gli elementi che progettiamo sono sempre nodi di una rete
dinamica costituita da elementi e relazioni; essi non si collocano
autonomamente. Non si possono progettare uno dopo l'altro in isolamento.
La progettazione di ogni oggetto impone di considerare l'impatto che
esso ha sull'oggetto progettato precedentemente. I primi oggetti cambiano
la loro identità in una catena di elementi interconnessi.
Per cui c'è una nuova complessità che deve essere compresa e approfondita
in questo particolare lavoro di design. Non si possono più prendere
in considerazione semplici nozioni ontologiche su come il mondo è
costituito. Il mondo è fatto più di relazioni che di oggetti con stabili
proprietà.
Si deve considerare il mondo come un sistema integrato e non come
una collezione di oggetti ordinati secondo una classificazione o composti
in una disposizione spaziale statica. All'interno di un network
l'identità di qualunque oggetto o nodo dipende dalla globalità
del tessuto di relazioni, che potrebbe entrare a far parte dentro
sia direttamente che indirettamente. E tutto questo implica un processo
continuo di trasformazione, che non può più esser racchiuso dentro
una stabile categoria. Ci stiamo spostando dal concetto di tipologia
a quello di topologia e di modelli parametrici. La cosa più importante
è che l'oggetto può soltanto esser identificato dalla sua posizione
all'interno del network di relazioni. E questa posizione non
è principalmente una posizione spaziale. Infatti, gli oggetti diventano
agenti nel network di collaborazione. Per cui la loro identità dipende
dal loro ruolo sociale all'interno della società del sistema di componenti.
Gli utenti potrebbero esser
concettualizzati come un particolare sottogruppo del sistema dei componenti
con un alto grado di autonomia. Gli agenti, inoltre, si sviluppano
nel tempo. Possiamo così introdurre il concetto di funzione della
memoria. Se tutto ciò sta diventando una sembianza generalizzata del
nostro mondo artificiale, non si può più descrivere un oggetto senza
riferirsi all'oggetto originario, alla propria posizione all'interno
del suo ciclo di vita o traiettoria di sviluppo. Il processo di vita
dell'oggetto potrebbe comportare un lasso di tempo fisso, oppure uno
dipendente dalla storia dell'interazione con altri oggetti. Le possibilità
sembrano infinite. Persino un'evoluzione artificiale potrebbe essere
studiata.
Quando si parla del concetto di mutazione ci stiamo forse spostando
verso una sfera ancor più complessa. Durante lo sviluppo di questo
particolare sistema, si può, forse, distinguere un sistema ciclico,
composto da una serie di eventi interconnessi oppure da reazioni a
catena che si ritrovano sempre alla condizione iniziale. Un oggetto
oscilla. Esso ha un semplice ciclo di vita. Ciò che stiamo iniziando
ad analizzare –basandoci, naturalmente, sulla ricerca del computer
all'interno degli algoritmi genetici e all'interno della programmazione
genetica– è la possibilità che il responsive interaction lasci
tracce. Vorremmo sviluppare un oggetto, mutare un oggetto, permettendo
all'oggetto di evolversi e di raccogliere esperienze. Per cui tutto
questo processo non è un ciclo di vita prefigurato, ma un tipo di
sviluppo di vita di ogni elemento. Questo è un nuovo e affascinante
modo di pensare, mediante il quale si cerca di progettare piccoli
mondi dove sia gli oggetti, sia il sistema come globalità, si evolvono.
Questo non è un universo di tipo Newtoniano con sistemi ciclici e
stabili, ma un universo di tipo Darwiniano, caratterizzato da processi
di mutazione, selezione, riproduzione, sviluppo ed evoluzione. È una
sfida affascinante da portare avanti, ma, oggi, c'è anche un modo
necessario e pertinente di pensare l'architettura, dato dal fatto
che il processo della vita sociale è in continuo cambiamento. E queste
trasformazioni sono irreversibili piuttosto che cicliche. Per cui
l'architettura potrebbe essere in grado di partecipare a questo meccanismo.
Pertanto, la capacità di evoluzione e sviluppo diventa, fin dall'inizio,
una design agenda consapevole.
Alessandra Belia
alessandrabelia@tiscali.it
|
|
[10feb2004] |