|
|
| home |
| L'architettura
parla? di Luigi Prestinenza Puglisi |
||||
| >
MAILTO PUGLISI > LEZIONI > FORUM > PRINTABLE VERSION |
Affrontiamo subito una questione preliminare. Sembrerebbe astrusa e irrilevante. Non è né l'una né l'altra. Può porsi così: "L'architettura è un linguaggio?". Abbiamo due risposte. Una affermativa e l'altra negativa. Se è affermativa e conveniamo che l'architettura ci parla, ne consegue che dobbiamo cercare di capire cosa vuole dirci. Se la risposta è negativa, saremo costretti a fare altre ipotesi. Per esempio, potremo considerarla come un fatto esclusivamente tecnico: l'architettura è ciò che ci protegge, ci copre e garantisce alcuni nostri bisogni abitativi e
basta. |
[06jan2001] | ||
 Passiamo, adesso, alla vostra finestra che si trova al centro di una parete. Perché proprio li? Per nessun motivo apparente. Ma se guardiamo l'edificio dall'esterno, vedremo che la stessa finestra, insieme ad altre disposte ad intervalli regolari, fa parte di un disegno generale della facciata. E che la semplicità e regolarità delle aperture è funzionale al sobrio disegno di un edificio che vuole inserirsi nel contesto urbano, senza emergere troppo rispetto agli altri (se, infatti, le bucature fossero state una diversa dall'altra e tutte di forma strana e irregolare, avremmo fatto la considerazione opposta e detto che la finestra era funzionale a realizzare un edificio che, per qualche motivo, voleva staccarsi dal contesto). Se siamo riusciti a trarre alcune informazioni, anche non banali, da due semplici finestre, vedendo nella prima una valenza paesaggistica e nell'altra una strategia di inserimento nella città, possiamo pensare che se avessimo esaminato non solo una parte ma l'intera costruzione, avremmo tratto molte più informazioni. Ma queste equivalgono a un linguaggio? In altri termini, hanno la stessa chiarezza ed efficacia comunicativa che attribuiamo alla nostra lingua scritta o parlata? O non si tratta, piuttosto di informazioni, che potremmo inferire da qualsiasi evento? Per capirci con un esempio: se io entro a casa e la vedo sottosopra inferisco che ci sono stati i ladri. Ma non per questo ne deduco che i ladri abbiano voluto comunicare con me. Affronteremo tra poco questa questione. Intanto osserviamo che il linguaggio dell'architettura non è mai immediato. Per comprenderlo ci costringe a cercare indizi, metterli insieme, fare ipotesi. Cioè a comportarci come un detective in un libro giallo che cerca di estorcere informazioni da fatti apparentemente insignificanti (dove stava la pistola, perché stava là, perché l'assassinio non la ha buttata, perché aveva ancora la sicura innestata…) e da questi ricostruire un quadro logico. Ritorniamo all'esempio della finestra. Osserverete che avevo attivato una ricostruzione indiziaria (la finestra non sta dove ci aspetteremmo, ha una forma insolita e inquadra un particolare paesaggio) dalla quale era scaturita una ipotesi (la finestra ha funzione panoramica) avvalorata da un altro indizio ( esclusione dall'inquadratura di un elemento che disturberebbe questa funzione). |
||||
 Ma, come accade a tutti i detective, potrei anche essere stato tratto in inganno da falsi indizi o da ipotesi avventate o logiche solo in apparenza. O comportarmi come un principiante che legge un libro giallo e crede che il colpevole sia proprio colui che alla fine si rivela innocente. Per fare il detective e cioè, fuor di metafora, per scoprire il senso di un'opera, ci vuole intuito, intelligenza ma anche mestiere. Le prime due qualità non possono essere insegnate, il mestiere può essere invece trasmesso e, in forma sia pur introduttiva, proveremo a farlo con questo corso. Ritorniamo all'interrogativo precedente. Il linguaggio dell'architettura ha qualcosa a che vedere con il linguaggio verbale o, per lo meno, ha una struttura simile? Su questo argomento, è bene che lo sappiate, si sono scervellati negli anni Sessanta e Settanta fior di intelligenze. Era il periodo in cui andava di moda la linguistica e l'allora giovane semiologo Umberto Eco insegnava nella facoltà di architettura di Firenze. Poi, come succede spesso nel campo dei fenomeni culturali, a un certo punto si è pensato che queste questioni non potevano essere risolte. E in poco tempo è caduto il silenzio sull'argomento. Nel senso che il campo è stato lasciato libero a pochi specialisti, talmente specialisti che faticano a capirsi anche tra loro. Ripercorrendo a distanza di tempo quelle interminabili discussioni, oggi possiamo dire che molte erano scarsamente rilevanti, altre poste in modo sbagliato. Tuttavia, dal dibattito sono emerse anche alcuni punti fermi, di grande rilevanza, con i quali è bene che chi si occupa di architettura si confronti. Il primo è che l'architettura è un linguaggio sui generis. Innanzitutto perché non si sono mai trovate regole che permettessero di affermare che la tale parola architettonica ha un significato univoco. Mentre, nel linguaggio scritto o verbale che usiamo tutti i giorni riusciamo subito a individuarlo. Per esempio: se noi adoperiamo la parola "cane" sappiamo che significa "animale con quattro zampe " nella frase "il cane viene scodinzolando ", oppure "stonato" nella frase "canta come un cane ". |
||||
 Umberto Eco ha fatto notare, però, che dal punto vista funzionale, la gran parte degli elementi architettonici ci indica con chiarezza qualcosa. La porta l'entrata, la sedia la possibilità di sederci, la finestra di affacciarci. E, come ha chiarito Donald A. Norman nell'interessante e divertente libro, La caffettiera del masochista (Giunti, Firenze 1997), noi siamo così abituati a questo linguaggio che ci troviamo in imbarazzo quando, come capita nei treni, per aprire una porta troviamo al posto di una maniglia un bottone. Tuttavia pensare che l'architettura si limiti a darci indicazioni su come usarla sarebbe un grave errore. L'architettura ci parla di tante cose - di forme, di armonie e di disarmonie, di concezioni del mondo- e voler ridurre tutto il suo linguaggio a un codice funzionale sarebbe come voler pensare che nell'uomo la bocca indicherebbe la possibilità di introdurre cibo, le mani la capacità di scrivere e di manovrare oggetti, e il cuore servirebbe a pompare sangue, dimenticando significati più alti e più complessi. E poi a cosa serve una lesena, un pattern decorativo, un timpano? Ritorneremo su questo argomento, aiutandoci anche con alcune osservazioni che lo stesso Umberto Eco ha avanzato. Per ora registriamo la difficoltà di considerare le parole del'architettura alla stessa stregua di quelle del linguaggio. Il secondo motivo di difficoltà è che non vi è nulla in architettura che rassomigli alla grammatica o alla sintassi del linguaggio comune. Cioè nulla che ci dica in che modo le singole parole debbano essere collegate tra di loro per formare frasi di senso compiuto. Per alcuni questo ruolo di sintassi lo hanno avuto gli ordini classici i quali stabilivano regole ferree per realizzare chiese, palazzi e monumenti pubblici. John Summerson ha addirittura scritto un libro dal titolo Il linguaggio classico dell'architettura (Einaudi, Torino 1973). Ricorda che gli architetti antichi, una volta scelto un determinato stile architettonico -dorico, ionico, corinzio o composito- erano costretti a muoversi all'interno di un sistema abbastanza preciso di principi, che regolavano proprio i rapporti tra i vari elementi costitutivi l'architettura. Per esempio dovevano fare in modo che l'altezza della colonna fosse multipla del suo diametro, che tra una colonna e l'altra dovesse esserci una certa distanza in funzione della loro altezza, che tra la lesena e la colonna c'era un preciso rapporto e così via. Insomma che esisteva quello che oggi chiameremmo una sintassi o, senza adoperare questo impegnativo termine, un codice. Il libro è illuminante, ben scritto e pieno di preziose informazioni sull'architettura classica, quindi vi consiglio di leggerlo. Ma con l'avvertenza di ricordarvi che ogni artista che nell'antichità si è ispirato ai principi dell'ordine architettonico ne ha -come riconosce lo stesso studioso inglese- modificato nel modo più soggettivo e arbitrario le regole. E poi, per noi moderni, l'idea di soggiacere a vincoli sintattici rigidi è poco e nulla convincente. Tanto è vero che qualche tempo dopo l'uscita del libro di Summerson, il critico Bruno Zevi pubblicò un altrettanto fortunato saggio, dal titolo Il linguaggio moderno dell'architettura (Einaudi, Torino 1973), nel quale sosteneva che l'architettura contemporanea dovesse rifuggire da regole e dogmi. E se proprio a qualche principio avesse dovuto rifarsi era proprio che per il futuro non potevano esserci che antiregole. Zevi ne enuncia sette che chiama invarianti. Sono: l'elenco, la asimmetria, la scomposizione quadridimensionale, le strutture in aggetto, la temporalità dello spazio, la reintegrazione edificio-città-territorio. L'elenco esprime l'atteggiamento aperto dello sperimentatore che non accetta gli schemi mentali imposti da altri e ogni volta riesamina, enumerandoli -appunto in un elenco- i termini del problema. L'asimmetria rende desuete le concezioni semplici e consolatorie dell'ordine, quali la simmetria bilaterale e rende superata ogni estetica che si basa su un ideale precostituito di composizione o di sintassi. La scomposizione quadridimensionale implica la volontà di rompere la scatola muraria, di acquisire nuove dimensioni spaziali e così facendo sposta l'attenzione dai pieni ai vuoti, per i quali è molto più difficile pensare a una organizzazione di tipo grammaticale. Le strutture in aggetto esprimono il bisogno di utilizzare le tecniche più sofisticate che, proprio per il loro carattere di novità, mettono in crisi ogni consuetudine edilizia. La temporalità dello spazio è l'accettazione della finitezza umana e delle sua dimensione storica, quindi il rifiuto di principi eterni. La reintegrazione edificio-città-territorio esprime il carattere insieme pubblico e ecologico dell'atto progettuale, con buona pace di tutti i grammatici che vorrebbero pensare all'edificio come un oggetto in sé e per sé compiuto. L'arte, ecco quello che in sintesi dice Zevi, rifiuta ogni costrizione, anche quella debole imposta dalle regole di un linguaggio. Se l'architettura parla, lo fa a prescindere da tutto ciò. Fine quindi di ogni ricerca di una sintassi architettonica? Non proprio. Dopo Zevi alcuni autori hanno tentato di reintrodurre il problema. Tra questi segnaliamo il critico inglese Kenneth Frampton il quale ha ripreso un antico concetto, quello di Tettonica, introdotto nella prima metà dell'ottocento dal teorico tedesco Gottfried Semper. Tettonica è, in sintesi quella disciplina che studia la relazione tra i singoli elementi e l'idea strutturale sottostante l'intera costruzione. Cioè quei meccanismi secondo i quali, come diceva il filosofo Schopenauer, "le forme dell'architettura vengono determinate anzitutto dalla funzione costruttiva immediata di ogni parte". Il tempio greco, per esempio, sarebbe un ottimo esempio di costruzione tettonica perché ogni particolare, anche quello apparentemente più decorativo, esprime il suo specifico apporto all'interno della logica trilitica (cioè di una struttura formata da piedritti e architravi) di cui il tempio è la massima espressione. Pensate, per esempio ai triglifi: apparentemente puri elementi di decorazione, contribuiscono invece anch'essi a chiarire la struttura dell'intero tempio perché evidenziano l'attacco delle travi del tetto sull'architrave di bordo. Oppure al capitello che, con il suo allargarsi verso l'alto, funge da mensola facilitando il sostegno dell'architrave sovrastante (affermava Schopenauer: ha la funzione di mostrare che "le colonne sostengono la trabeazione e non vi sono infilate come tappi"). Se la tettonica è quindi un modo di tradurre figurativamente il sistema di forze, pesi e tensioni che si distribuiscono all'interno dell'architettura o anche, più banalmente, di esprimere i meccanismi costruttivi che legano tra di loro le singole parti, essa equivale dunque a una regola generale - una sintassi appunto- all'interno della quale ciascuna frase trova il suo posto. Però variabile da caso a caso, perché ovviamente diversa è la sintassi che lega tra di loro le parti di un tempio greco, di una basilica romana, di una chiesa gotica o di una casa di Frank L. Wright. |
||||
 Frampton, in un libro molto interessante Studies in Tectonic Culture (MIT Press, Cambridge 1996, recentemente tradotto in italiano da Electa, Milano), mostra che numerosi architetti contemporanei hanno applicato logiche che si rifanno ai principi della tettonica e che è estremamente proficuo, a volte, tentare di capire il senso di un loro edificio a partire da uno studio dei rapporti tra le parti e il tutto. Tuttavia, a mio parere, se molte di queste analisi possono essere illuminanti, tuttavia pochissime volte ci restituiscono il senso della ricerca architettonica. Un po' come uno studio anatomico, che studia il sistema digerente, muscolare o nervoso, non ci restituisce, alla fine, il valore della persona ma solo un insieme di rapporti astratti che legano tra di loro le parti. Inoltre, in molte tra le più interessanti architetture contemporanee -pensiamo per esempio al Guggenheim di Bilbao di Frank O. Gehry o ai recenti edifici di Daniel Libeskind o Peter Eisenman- non vi è alcun rapporto tra forma dell'edificio e la struttura. Con la conseguenza che in tutti questi casi lo strumento dell'analisi tettonica, come del resto ammette con franchezza lo stesso Frampton, è praticamente inservibile. Denotazione e connotazione Ritorniamo alla nostra domanda: "l'architettura è un linguaggio?" La risposta potrebbe essere: no, se intendiamo per linguaggio un sistema strutturato, ben definito e articolato quale quello della lingua parlata; si, se intendiamo l'architettura come un sistema attraverso il quale alcuni messaggi vengono trasmessi a fruitori i quali attraverso un processo di decodifica, di tipo indiziario, li interpretano. Per fare un passo avanti e capire come ciò avvenga concretamente è opportuno a questo punto introdurre due parole che, in seguito sentiremo spesso, la denotazione e la connotazione. È stato Umberto Eco che, tra i primi, le ha proposte al pubblico degli architetti italiani, attraverso il fortunato libro La struttura assente (Bompiani, Milano 1968) che vi consiglio, per chiarezza, puntualità e precisione, di leggere. La denotazione è ciò che una parola vuole dire, il suo significato diretto. La connotazione è un messaggio secondo che traspare. La parola cuore, per esempio, denota un organo del nostro corpo caratterizzato dalla particolare funzione di pompare il sangue. Così se un medico mi dice "hai un cuore forte", quasi sicuramente intende denotare che questo organo lavora bene e non dà adito a preoccupazioni di sorta. Ma la parola cuore può connotare coraggio, lealtà. Quindi se un amico ci dice " hai un cuore forte", sappiamo quasi con certezza che non allude al cuore organo ma al nostro carattere. Insomma, ci sta facendo un complimento.  Denotazione e connotazione coesistono, tanto da essere quasi inestricabili, nel linguaggio di tutti i giorni. Quasi sempre, infatti, quando si parla si denota qualcosa ma, nello stesso tempo, se ne connotano molte altre. Un modo di connotare è per esempio attraverso il tono della voce. Se io dico "ma quanto sei bravo!" a seconda del tono capisco se sono su un livello denotativo (e in questo caso sto facendo l'elogio di una persona) o su un livello connotativo (e in questo caso è probabile che lo stia sfottendo). Un altro modo è attraverso l'allusione. Se io e un'altra persona condividiamo un segreto è evidente che appena io ne faccio cenno, qualunque cosa dica, spingo l'interlocutore a mettersi sulla stessa sintonia d'onda. Ve ne accorgete quando vedete due amici che parlano, chiusi in un loro mondo, e ridono di cose che a voi, anche quando capite il significato letterale delle loro parole, sfuggono. Denotazione e connotazione spesso sono inestricabili, tanto che non è facile capire cosa una parola denoti e cosa connoti. E provare a depurare il linguaggio di tutti i significati secondi è una impresa ai limiti dell'impossibile. Ci prova continuamente la scienza per la quale è importante che quando si dica qualcosa si sia certi del suo univoco significato. Ma tutte le arti giocano con una positiva ambiguità semantica. Immaginatevi, per esempio, a cosa sarebbe ridotta la poesia se fosse inchiodata solo al suo livello denotativo. Una poesia come "ognuno sta solo sul cuore della terra trafitto da un raggio di sole" significherebbe che tutti stiamo sdraiati a prendere il sole, mentre invece è attingendo al livello del connotato che questi versi assumono il loro incantevole fascino esistenziale. Anche in architettura esistono i due livelli, denotativo e connotativo. Umberto Eco, nel libro di cui vi ho appena accennato, presenta numerosi esempi: un trono denota la funzione di sedia ma connota regalità, indipendentemente dalla comodità della seduta; una porta invita a passare ma l'ingresso principale di un palazzo rinascimentale connota valori connessi con l'importanza della famiglia. Insomma: in ogni struttura architettonica dietro al significato semplice di una parola, si nascondono concetti complessi; e ogni oggetto, dietro all'indicazione del proprio uso nasconde un universo di senso. La connotazione, come abbiamo visto, è, però, di per sé ambigua. Uno stesso ente architettonico può dire cose molto diverse: una colonna, in un contesto classico, per esempio, potrebbe connotare solidità e armonia; in uno manierista ricordare un ordine messo in crisi; o, infine, in un contesto postmodern alludere ironicamente a un passato che non può più tornare. Esattamente nello stesso modo come la frase "hai un gran cuore" potrebbe significa una cosa se detta da un medico in un ambulatorio e un'altra da un amico che ti ha chiesto un prestito. E in quest'ultimo caso avere un valore positivo se detta a prestito avvenuto e negativo se detta a prestito negato. Ecco emergere una prima regola: a nessuna frase, presa da sola, può essere attribuito un significato connotativo preciso. Che emergerà solo dalla comprensione del ruolo che gioca l'elemento all'interno del contesto. Nel caso dell'architettura: che emergerà dal raffronto con gli altri elementi dell'edificio, con il luogo in cui si colloca e le circostanze che lo determinano. Un altro motivo di ambiguità della connotazione risiede nel fatto che le regole che la codificano non sono valide una volta per tutte ma variano in relazione ai vari gruppi che le usano. Dicevamo prima che due amici, per esempio, a volte si capiscono al volo alludendo a cose che per altri non hanno alcun significato. Un po' lo stesso avviene nel campo dell'arte e dell'architettura dove vi capiterà di vedere, davanti alla stessa opera, persone che le comprendono e le apprezzano e altre che, in assenza o carenza di un codice di lettura, le snobbano. E di ammirare in futuro ciò di cui adesso non capite il senso. Segno quindi che non sempre i meccanismi che permettono di decodificare un'opera sono rinvenibili al suo interno. Avrete bisogno di trovarle o in altri lavori dell'architetto oppure nei libri di critica e di teoria. Per rimanere all'esempio precedente è un po' come se per interpretare a cosa alludono due amici che voi non comprendete, andiate a cercare altrove -per esempio da conoscenti comuni, da scritti segreti, dai familiari- le chiavi di lettura. Inoltre in arte, e quindi anche in architettura, esiste una regola che potremmo chiamare dell'accumulazione temporale, secondo la quale il valore di un segno è sempre strettamente connesso al significato dei segni che lo hanno preceduto. E nessuna opera, neanche la più radicale e originale, può prescindere da questa dimensione storica del linguaggio. Mi spiego con quattro esempi. Il primo preso dall'arte. Nel 1917 Marcel Duchamp cerca di esporre in pubblico un orinatoio per dimostrare che il valore di un'opera risiede nel messaggio dell'artista il quale può dare senso a qualsiasi oggetto anche il più banale e prosaico. Una mossa spiazzante dalla quale hanno tratto beneficio molte correnti artistiche contemporanee che, riflettendo sulle implicazioni di questo gesto, hanno costruito percorsi artistici di assoluto rilievo: dal concettuale alla pop art. In che modo Duchamp ha prodotto significato? Riferendosi alla storia della disciplina artistica con un atteggiamento ambivalente. Di negazione perché si è rifiutato di produrre un artefatto tradizionale, utilizzandone uno di produzione industriale e per di più tale da urtare le abitudini del pubblico. Di accettazione perché, esponendolo al'interno di una galleria, Duchamp accetta uno dei postulati principali dell'arte che consiste proprio nell'esibire l'opera in un ambiente particolare dove perde la sua caratteristica funzionale di oggetto per acquistare un'aura artistica o, come direbbe Mukarovski, per essere osservato in quanto oggetto estetico. Esaminiamo adesso il processo di significazione. Notiamo l'importanza del contesto. Se l'orinatoio non fosse stato esposto all'interno di una galleria, l'intera operazione non avrebbe avuto valore comunicativo. E anche, osserviamo, che la comunicazione avviene proprio perché l'opera si riferisce alla storia e ai suoi significati accumulati e consolidati, sia pur per negarli e proporne di nuovi. |
||||
 Il secondo esempio concerne l'architettura. Nel 1949, Philip Johnson costruisce a New Canaan una casa in vetro e acciaio ispirata a Mies van Der Rohe, conosciuta come Glass House in virtù della sua trasparenza. Johnson è a quell'epoca uno dei più accaniti seguaci del maestro tedesco. Ne aveva apprezzato l'opera durante gli anni trenta, la aveva diffusa negli Stati Uniti, si era dato da fare per aiutare Mies a fuggire dalla Germania a seguito delle persecuzioni naziste, lo aveva aiutato a diventare direttore della facoltà d'architettura del' IIT di Chicago. Mies, però, nonostante il debito di gratitudine verso Philip, non apprezzerà mai la Glass House. Intanto per una ragione formale: i pilastri sono collocati negli angoli, accentuando il carattere scatolare dell'abitazione, cosa che mai avrebbe fatto Mies. Ma soprattutto per il motivo che le parole di Johnson, proprio in virtù del fatto che rassomigliano troppo alle sue, ne fuorviano il senso. In Mies infatti le forme sono il risultato di un intenso lavoro di semplificazione maturato attraverso la riflessione sui problemi dell'abitare, a partire dall'alto magistero di Berlage; in Johnson il risultato di un disinvolta operazione di marketing tesa a lanciare la moda dell'International Style, cioè di un fenomeno che, come dimostra la mostra del Museum of Modern Art del 1932 - curata appunto da Johnson- tenderà a trasformare le ricerche del Movimento Moderno in un facile ricettario stilistico. Insomma: l'architettura -come, del resto, tutti i sistemi connotativi- è un linguaggio che non ammette errori di grammatica, quali i pilastri collocati in una posizione infelice, ma, soprattutto, non tollera copie. Attenzione però. Non sempre le conseguenze di un processo di imitazione sono negative come nel caso appena illustrato; a volte il rifarsi a parole del passato, intelligentemente citate e non banalmente copiate, può portare a risultati interessanti. Michelangelo, per esempio, riprende, anche in maniera sfacciata, l'architettura di Brunelleschi, che lo affascina per la sua chiarezza spaziale. Nello stesso tempo, però, complica il gioco, con sovrapposizioni, intrecci, innesti sino a portarlo a un punto di crisi. Ne viene fuori un'architettura nuova che trae il suo carattere proprio dal continuo autoriferirsi alla lezione del maestro. Le Corbusier, con i pilotis compie un'operazione analoga, indirizzata però a un dialogo con i valori di solidità plastica delle colonne dei templi greci. Certo sarebbe un errore pensare di assimilare i pilotis interamente alle colonne di Ictinio e Callicrate, gli architetti autori del Partenone. E dimenticarsi che hanno un ruolo funzionale ben diverso: servono, infatti, a staccare la costruzione dal terreno e non ad ancorarla al suolo. Ma sarebbe ugualmente grave che la volontà di armonia, veicolata attraverso l'esplicito riferimento, sfuggisse a chi analizza un'opera di Le Corbusier. Anche perché, in questo caso, non riuscirebbe ad afferrare i numerosi richiami del maestro alla cultura classica, e in particolare greca: dal significato della famosa osservazione secondo la quale l'architettura è il gioco sapiente dei volumi sotto la luce, alla polemica con Hugo Haring sul valore della forma al di sopra di ogni funzionalità e, infine, al senso del Modulor, cioè di un sistema di proporzioni, basate sulla figura umana e sulla sezione aurea, che il maturo Le Corbusier utilizza nei propri progetti. L'architettura quindi non tollera le copie ma accoglie le citazioni. Del resto, se ammettiamo che sia un linguaggio, sia pure sui generis, è naturale pensare che non inventi ogni volta dal nulla parole e frasi ma le adatti in un processo di continua evoluzione storica, che, come hanno tentato alcuni studiosi, si può pensare di ricostruire. Per esempio comparando tra di loro le architetture di uno stesso momento storico e queste con quelle del periodo successivo. I testi però che ne sono venuti fuori, tra questi ricordiamo la Storia dell'architettura secondo il metodo comparativo del Fletcher, francamente sono noiosi e spesso tendono alla pedanteria con interminabili tassonomie (cioè catalogazioni) di tipi edilizi e strutturali. Progenitrice degli studi comparativi e ben più interessante, anche grazie alle magnifiche analisi di Erwin Panofsky e della scuola del Warburg Institute, è l'analisi iconologica. Che però ha avuto importanti esiti soprattutto nel campo dell'arte figurativa. Consiste nel cercare le immagini ( o icone, da cui il termine: iconologia) ricorrenti nella storia dell'arte e compararle tra di loro al fine di capirne il senso. Il presupposto è che se un artista rappresenta un santo con una spada e un altro lo rappresenta senza, ciò è dovuto probabilmente a una differenza di contenuto delle due opere. E la mancanza di quell'attributo è l'indizio che i due artisti abbiano voluto dire qualcosa di diverso, che lo storico deve ricostruire.  Come accennavamo, l'analisi iconologica presuppone ambiti dove la figuratività sia predominante. E non è un caso che ci siano studi interessantissimi sui significati delle diverse madonne del cinquecento, mentre non mi risulta che ce ne siano di particolarmente validi sull'arte e sull'architettura contemporanea. Tuttavia brevi analisi, se non proprio iconologiche, quanto meno di tipo comparativo, di fatto si possono tentare anche con il nostro metodo indiziario. Osserviamo per esempio in che modo tre architetti contemporanei utilizzano il pilastro: per Le Corbusier a villa Savoie (1929) è di forma circolare, per Mies nel padiglione di Barcellona (1929) è cruciforme, per Wright nella Johnson Wax (1936) è dendriforme (cioè a forma di albero). Non è difficile, chiedendoci il perché delle differenze, risalire alle diverse poetiche. Classica per il primo che, come abbiamo visto, allude al tempio greco. Minimalista per il secondo che cerca di esaltare la leggerezza della struttura riducendo il supporto a due sottili lame che si intersecano tra di loro. Organica per Wright che trasforma il pilastro in un'aperta allusione al mondo della natura. Concludiamo: una buona conoscenza storica e un'attenta comparazione tra le architetture sono gli strumenti privilegiati che ci permettono di interpretarne il messaggio. Ma a questo punto nasce un'altra domanda. Come facciamo a essere sicuri che la nostra interpretazione rifletta fedelmente il pensiero dell'architetto? Interpretazione e sovrainterpretazione Ritorniamo a un esempio precedente. Abbiamo detto che se troviamo la casa in disordine e ne deduciamo che c'è stato un furto, non per questo possiamo pensare che i ladri abbiano voluto comunicare con noi. Nel caso del linguaggio artistico vi è, però, di regola, una volontà di comunicazione da parte dell'architetto. Che come Pollicino -l'immagine credo sia di Umberto Eco- lascia alcune tracce per farsi trovare. Fuor di metafora: leggere un'architettura è di regola, interpretare un messaggio coscientemente emesso da una fonte, che ci richiede di compiere quello che in gergo filosofico si chiama un processo ermeneutico. Sarebbe troppo lungo riassumere in queste pagine tutte le problematiche che una teoria dell'interpretazione pone. Ma ve ne è una preliminare che non possiamo eludere. Ci chiede se esistono regole o perlomeno metodi per arrivare a una corretta interpretazione del testo, e alla certezza che il senso dell'opera che stiamo aggredendo corrisponde esattamente a ciò che l'autore aveva in mente e non a una nostra arbitraria, per quanto brillante, costruzione mentale. Cioè a una sovrainterpretazione. Insomma: quando con Bruno Zevi diciamo che l'architettura di Michelangelo presagiva la crisi dei concetti classici e introduceva l'estetica dell'informale, stiamo facendo una operazione interpretativa corretta o stiamo sovrapponendo all'autore categorie di pensiero che sono nostre e alle quali Michelangelo non si sognava di pensare? Uno storico dell'architettura di solida cultura, Manfredo Tafuri, ha a lungo stigmatizzato questo atteggiamento. E se proprio non se l'è presa con Bruno Zevi, di cui riconosceva l'enorme statura intellettuale, ha ironizzato sul vezzo di molti storici che, con la scusa di far parlare l'autore, hanno detto insulse e antistoriche sciocchezze, anticipando o posticipando di decenni se non di secoli concetti e problematiche maturati altrove: per esempio attribuendo agli architetti manieristi del millecinquecento una concezione romantica della storia che si sviluppa a partire dalla fine del millesettecento o, peggio, una visione frammentata del cosmo che è propria della cultura contemporanea.  Per provare a dare una risposta a questo interrogativo, ritorniamo all'immagine del detective. Suo compito è mettere sul tappeto tutti i fatti, cercando di separarli il più possibile da idee preconcette e sulla loro base avanzare teorie che riescano a collegarli nel modo più razionale. Un po' come fanno gli scienziati che, a partire da un insieme di dati sperimentali, arrivano a proporre una teoria dotata di senso. Possiamo quindi supporre che saremo tanto più certi di non incorrere nel pericolo di sovrainterpretazione quanto più il nostro quadro risulta avvalorato da una pluralità di dati storici che, non contraddicendosi tra di loro, tendono a restituirci una prospettiva completa e convincete. Viceversa un quadro avallato da pochi fatti e contraddetto da altri ha molte probabilità di essere scarsamente dotato di senso scientifico. Per fare un'indagine seria, insomma, non basta una semplice ricognizione: occorrono analisi precise dell'opera, confermate dalla lettura filologica dei documenti di cui siamo in possesso, oltre a un confronto con il quadro storico di riferimento. La risposta sembrerebbe convincente. Ma, in realtà alcuni tra i più importanti epistemologi contemporanei, cioè i teorici che si occupano dei fondamenti della conoscenza, sia di formazione scientifica (Popper, Kuhn, Lakatos, Feyerabend) che filosofica (Lyotard, Derrida, Deleuze) che storica (Focault, Ginzburg) pensano che le cose non siano così semplici; per almeno quattro motivi. Primo: dato un insieme di fatti, possono proporsi numerose interpretazioni ognuna delle quali al suo interno è perfettamente coerente. Così di una stessa opera d'arte potrei dare due o anche più ricostruzioni convincenti. Ma allora quale sarà quella giusta? Secondo: non conosciamo, né potremo mai conoscere tutti i dati storici che ci permettono di ricostruire un evento. Dobbiamo quindi ammettere che ogni nostra interpretazione è provvisoria e falsificabile.  Terzo: molte osservazioni che oggi crediamo abbiano un valore fattuale incontrovertibile, nel tempo si sono rivelate semplici e opinabili interpretazioni. In realtà, se proprio non vogliamo credere all'asserzione di Nietzsche che non esistono fatti ma solo interpretazioni, dobbiamo convenire che fatti puri non esistono. Se non altro perché dietro a ogni osservazione fattuale (per esempio se dico che un muro è rosso) si nascondono concetti (il concetto di muro e di colore rosso) che possono essere, nel corso del tempo ridefiniti (per esempio i romani avevano rispetto a noi una diversa concezione di ciò che è un muro e una diversa scala cromatica). Quarto: è difficile, se non impossibile, rendere in forma intellegibile le idee e i sentimenti contraddittori che riversiamo nei nostri manufatti. Che senso ha, allora, imporre, attraverso una ricostruzione razionale, un quadro logico a ciò che spesso, di sua natura, non lo è? Spero di non avervi portato a un cupo pessimismo, ma solo di avervi fatto intuire quanto problematici siano i concetti che adoperiamo. Se, tuttavia, da quanto vi ho appena detto se ne deduce che i principi che applichiamo non sono certi e assoluti e se dobbiamo ammettere che interpretazione e sovrainterpretazione sono sempre intrecciate, ciò non vi autorizza a cadere nella pura arbitrarietà, esimendovi dal tentare di dipanare le contraddizioni che a mano a mano vi si presentano e dall'applicare le migliori regole di cui disponete. In fondo, alla fine, il nostro detective alcune interpretazioni dovrà pur sempre dare e di queste alcune saranno più convincenti, altre meno. Alcune incontreranno nel corso del tempo la conferma di fatti oggi sconosciuti, altre saranno da questi clamorosamente falsificate. Torneremo su questo problema che presenta non pochi interrogativi di prospettiva filosofica. A questo punto, però, si pone un'altra questione. Abbiamo detto che se vogliamo ricostruire quanto ha effettivamente voluto dirci un architetto o un artista, dobbiamo cercare il più possibile di inibire la nostra attività di sovrainterpretazione. In realtà ciò è vero sino a un certo punto. L'inventore della psicanalisi, Sigmund Freud, ci ha mostrato che a volte una persona dice delle cose ma ne pensa delle altre. I lapsus e i sogni testimoniano che noi abbiamo una psiche complessa per indagare la quale bisogna, prescindere da ciò che esplicitamente vogliamo dire. Il filosofo e sociologo della politica Carlo Marx ha mostrato, inoltre, che dietro comportamenti apparentemente semplici si nascondono motivazioni economiche profonde, attribuibili a rapporti di produzione interni al sistema sociale. E che l'ideologia, cioè la nostra concezione del mondo, nasconde spesso una realtà dei fatti molto più prosaica. Sulla critica dell'ideologia non insiste solo Marx. La gran parte delle scienze sociali si basa sul concetto che le azioni dei singoli individui, e quindi anche degli artisti, al di la' della loro intenzionalità, sono spesso dominate da motivazioni, non necessariamente esplicite o razionali. E che, nonostante ciò che crediamo e enunciamo, i comportamenti sono provocati da istinti a volte irrazionali e primordiali che non controlliamo ovvero da idee recondite anche astratte e interessanti che però subiamo per il fatto stesso di vivere in un determinato periodo storico, e in uno specifico ambiente sociale e culturale. Inoltre, per tornare all'architettura, sarebbe un errore pensare che tutti i progettisti siano persone dotate di straordinaria cultura che coscientemente si prefiggono di lasciare complessi messaggi all'umanità. E non mi riferisco solamente ai prodigiosi autori delle architetture primitive o ai capimastri delle città medioevali, che hanno prodotto opere sublimi, ma anche a tanti protagonisti della ricerca contemporanea che non necessariamente hanno una raffinata cultura linguistica o filosofica. E se -tanto per fare un esempio- le architetture di Peter Eisenman o di Rem Koolhaas sono sempre ultracostruite, e frutto di innumerevoli riflessioni sia sul linguaggio architettonico che su fatti extradisciplinari, i capolavori di Frank Gehry, quali il Guggenheim Museum di Bilbao, evitano gli intellettualismi e vanno subito al cuore della forma. Ma non per questo sono meno interessanti o privi di significato. Vi è poi un ulteriore aspetto che Erwin Panofsky ha messo in evidenza con un saggio di grande importanza: La prospettiva come forma simbolica apparso nel 1927 (pubblicato in italiano da Feltrinelli Milano 1961). Afferma Panofsky: tutti gli uomini, e di conseguenza tutti gli artisti, organizzano la realtà secondo certi punti di vista, che variano da epoca a epoca. Vediamo, infatti, le cose diversamente dai primitivi, dagli uomini del medioevo o del rinascimento. E se per gli antichi lo spazio era fatto in un modo, per noi lo è in un altro. Prova ne sia che i modi di rappresentarlo sono cambiati. La prospettiva, per esempio, è un metodo, inventato nel 1400, e utilizzato sia nelle arti figurative che in architettura, che ci mostra che da un certo punto in poi lo spazio è stato concepito matematicamente, tanto da poterlo rappresentare attraverso una serie di semplificazioni geometriche. Queste forme di rappresentazione, proprio perché indipendenti dai singoli individui e da qualunque contenuto specifico (con la stessa regola prospettica si possono, infatti, rappresentare infiniti tipi di cose), mettono in evidenza le nostre strutture intellettuali e hanno in se e per se un valore simbolico. Ricostruirne genesi, dinamiche e significato è quindi un modo formidabile per capire, anche indipendentemente dalla coscienza che ne hanno coloro che le usano, l'essenza del modo di vedere e ragionare dell'uomo nei vari periodi storici. Concludiamo: la psicanalisi, la sociologia, la teoria delle forme simboliche ci mostrano che l'artista parla, dando senso alla sua opera anche indipendentemente dalla sua intenzione. E come ha notato Johnatan Culler, in un interessante intervento (pubblicato in Umberto Eco, Interpretazione e sovrinterpretazione, Bompiani, Milano 1995) è proprio questo fluire involontario di informazioni che spesso ci consentono di capire meglio l'opera d'arte o un determinato periodo artistico. Una critica operativa? Se vi siete accorti, siamo giunti a un'empasse. Abbiamo detto che è problematico ricostruire il significato attribuito dal progettista alla propria opera e, ammesso di riuscirci, dobbiamo convenire che l'operazione di decodifica ci offre solo una parziale risposta perché all'interpretazione si affiancano e sovrappongono numerose sovrinterpretazioni -di natura psicanalitica, politica, ideologica, sociologica- che possono avere per noi un interesse addirittura maggiore del messaggio intenzionalmente trasmesso nell'opera.  Ma anche ampliando il campo di esame -dalla interpretazione alla sovrainterpretazione- non abbiamo risolto la questione di attendibilità che ci eravamo posti in precedenza e cioè sino a che punto le nostre astratte interpretazioni corrispondano con la realtà effettiva dell'opera. Eppure gran parte del lavoro critico si basa proprio sulla formulazione di tali astrazioni che conducono ad affermazioni difficilmente verificabili del tipo -cito quasi testualmente da testi conosciuti e apprezzati- che "le avanguardie del primo novecento sono una risposta alla crescente ansia della borghesia nei confronti della società metropolitana", oppure che "l'opera di Borromini è la risposta di un autentico spirito religioso alle contraddizioni della chiesa postriformista". Oppure di affermazioni spiazzanti quale quella contenuta in una saggio famoso di Sigmund Freud in cui analizza la produzione di Leonardo e in particolare il sorriso ambiguo della Gioconda attribuendolo al complesso di Edipo nei confronti del padre e a quello di castrazione nei confronti del padre. Ebbene, se affermazioni di questo genere le sentiamo condivisibili e le intuiamo come vere, ciononostante ci imbarazzano. Sino a farci porre la domanda sulla loro verificabilità. E ammettere che tutte obiezioni cui avevamo accennato in precedenza a proposito della difficoltà di interpretare il pensiero di un autore, ci si ripropongono. Con per di più l'incertezza che mentre, in quel caso, poteva capitarci la fortuna di trovare un testo in cui fosse l'autore stesso a spiegarci il suo pensiero, nel caso della sovrainterpretazione storica, psicanalitica, sociologica siamo certi che non lo troveremo mai. Alcuni storici del'architettura si sono accaniti su questo problema. Manfredo Tafuri ha scritto un interessantissimo, quanto complesso, saggio apparso sulla rivista Casabella (si trova riveduto e ampliato come introduzione al libro La sfera e il labirinto, Einaudi, Torino 1980), nel quale sosteneva -semplifico non poco- che è destino dello storico lavorare sulle proprie incertezze, costruendo teorie sempre più accurate che lo avvicinano progressivamente al senso degli eventi. Quindi da un lato analisi filologiche severissime, dall'altro una cultura sterminata, sia dal punto di vista filosofico che metodologico, per affinare una ricerca, la quale per definizione, è infinita. Per rendere con una metafora la sua tesi Tafuri, riprende una immagine del Marchese De Sade, e paragona il lavoro dello storico agli sforzi di una persona che caduta dentro un pozzo e senza appigli può cercare, per uscirne fuori, di saltare solo aggrappandosi ai propri capelli. L'immagine è felice. Ma testimonia anche la debolezza insormontabile del metodo proposto. Come si può saltare il fosso aggrappandosi ai propri capelli? E, inoltre, come ci si può avvicinare alla verità storica, se non abbiamo idea di dove questa si trovi? Sembreremmo finiti in un vicolo cieco. A uscire ci aiutano le osservazioni di due filosofi: uno greco vissuto nel quarto secolo avanti Cristo, Aristotele, e l'altro italiano operante tra fine ottocento e la prima metà del novecento, Benedetto Croce. Aristotile capì l'ideale ricostruttivo dello storico è pura utopia e che tra la storia e arte non c'è sostanziale differenza. Ambedue si occupano del verosimile: realtà e invenzione, sia pur con diversi dosaggi, sono in entrambe abilmente miscelati. Croce, che fece della storia il nodo centrale della sua concezione filosofica, osservò che la storia, per quanto si occupi del passato, è sempre fatta con un occhio rivolto al presente e al futuro. Per due motivi: innanzi tutto perché noi la interpretiamo con le nostre categorie di giudizio, che sono quelle di cui disponiamo al momento, e poi perché le domande che poniamo sono sempre legate ai nostri problemi e quindi alla nostra prospettiva esistenziale. 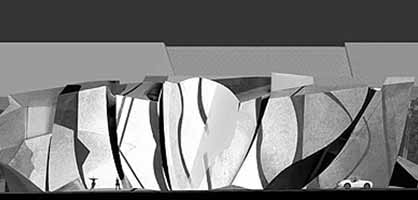 Proviamo adesso a integrare le due teorie e avremo un nuovo strumento storiografico: la critica operativa. Riassumendo possiamo dire che il suo obiettivo è di interpretare la storia, costruendola in forma di racconto, senza l'ossessione di sapere come le cose si sono effettivamente svolte in passato ma con il desiderio di trovare strumenti per costruire il nostro futuro. La definizione, sebbene attraente suona però pericolosa. E possiamo subito chiederci se dietro al desiderio di leggere la storia in forma di racconto non si celi la voglia di sfuggire a un metodo filologico rigoroso. Del resto la critica operativa, che in Italia ha avuto come suo più alto esponente Bruno Zevi, non è stata esente da gravi colpe. Vi accennavo che, in nome della sua operatività, storici dilettanti hanno fatto dire ad architetti quali Brunelleschi ( soprattutto il povero Brunelleschi ridotto al livello di un grillo parlante) Michelangelo, Borromini cose che contrastano non solo con ricostruzioni storiografiche ben fatte, ma anche con il buon senso. Guardare la storia con gli occhi del presente o, meglio, del futuro, non vuol dire, infatti, avere risposte belle e pronte da avvalorare cercando nel passato fatti che le rendano credibili. Chi opera in questo modo può essere certo di produrre quelle che, in termine scientifico, si chiamano costruzioni ad hoc, cioè ipotesi il cui valore, in termini di conoscenza, è praticamente nullo. L'esperienza ci dimostra, infatti, che, se opportunamente scelti, esistono sempre un certo numero di fatti che possono confermare qualsiasi teoria. Per produrre buone costruzioni e buoni ragionamenti,e quindi racconti storici che si rispettino, il metodo deve essere diverso: consiste nel partire senza posizioni preconcette e nell' accettare di mettere sempre a repentaglio le assunzioni fatte. Del resto, senza troppi ragionamenti, un atteggiamento del genere lo mettiamo in pratica nella vita di tutti i giorni: siamo proiettati al futuro ma per decidere cosa fare, indaghiamo sempre il passato (o ciò che crediamo tale) perché è solo dall'esperienza che troviamo le chiavi per decifrare il futuro e per cercare di indirizzarlo verso le direzioni da noi auspicate (avendo anche la capacità di mettere in crisi il nostro tragitto nel momento in cui ci accorgiamo di aver scelto una strada sbagliata). Tornando a considerazioni più pratiche, vi accorgerete che ciascun trattato di storia dell'architettura in commercio ha un proprio taglio e un proprio modo di guardare al futuro. Una lettura politica dell'architettura, per esempio, è stata tentata da Tafuri, un approccio semiologico è presente nel testo di De Seta, una analisi sociologica si trova nel libro di Diane Ghirardo, Architecture After Modernism, e nella storia di Leonardo Benevolo. Esistono buoni testi che affrontano anche più prospettive, in parte linguistiche in parte politiche, quali la storia dell'architettura di Kenneth Frampton. E vi è infine la storia dell'architettura di Zevi, un libro scritto nel 1950 e poi successivamente aggiornato, così appassionato e intransigente, oltre che limpidamente scritto, che vi consiglio per cominciare. Concluderei questa prima lezione con una citazione di Edoardo Persico, uno dei più importanti critici italiani, operante nella prima metà del novecento. Persico diceva: l'architettura è sostanza di cose sperate. Perché è la concretizzazione in pietre e mattoni del sogno del nostro futuro. E a questa prospettiva, e solo a questa, è lecito finalizzare l'interpretazione, cioè la lettura critica, del nostro passato. Luigi Prestinenza Puglisi L.Prestinenza@agora.stm.it |
||||
|
> FORUM
> LEZIONI > SEMINARIO > SCUOLE |
||||
per
qualsiasi comunicazione laboratorio |