|
|
| home > parole chiave |
| Grande |
||||||||
| Perché salire l'Everest? Perché affrontarne le fatiche e i pericoli? "Perché è là", rispondevano i primi conquistatori del tetto del mondo. Rem Koolhaas apre con questa citazione il suo testo sulla grandezza (Bigness, or The Problem of Large, in "Domus", n. 764, 1994) a sottolineare il potere cumulativo, autoevidente della quantità, della pura quantità spinta all'estremo. Un potere le cui implicazioni influenzano ogni aspetto dell'interazione tra uomo e natura, a partire dalla stessa comprensione di quanto ci circonda (vedi Roger Penrose, The Large, the Small and the Human Mind, Cambridge University Press, 1997), e che si manifesta con particolare evidenza in architettura, dove la dimensione è da sempre, al di là di ogni valutazione qualitativa, strumento per rappresentare e costituire l'eccezionale: dalla mitica torre di Babele, con il suo carico simbolico, alle "sette meraviglie del mondo", legate fra loro dalla sola dismisura (tra i diciotto libri trovati su Amazon.com al titolo The Seven Wonders of the Ancient World, il più recente è di Shirley Jordan, Perfection Learning, 2004), dall'eccesso barocco alle sue forme contemporanee (vedi Omar Calabrese, L'età neobarocca, Laterza, 1987), da Boullée ai grattacieli... |
[28jan2005] |
|||||||
 |
||||||||
| "Domus",
764, 1994 |
Roger
Penrose, The Large, the Small and the Human Mind, 1997 |
Shirley
Jordan, The Seven Wonders of the Ancient World, 2004 |
||||||
 |
||||||||
| Omar
Calabrese, L'età neobarocca, 1987 |
| Dunque
"Size does matter", la dimensione conta, come afferma didascalicamente
il manifesto di Godzilla
("colossal" diretto da Roland Emmerich nel 1998). Contava
ai tempi degli egizi e conta tanto più oggi, quando la disponibilità
di energia e tecnologie estende le possibilità di realizzazione.
Il ventesimo secolo assiste a una drammatica proliferazione in questo
senso, soprattutto negli Stati Uniti, paese trainante dello sviluppo
economico mondiale e laboratorio del "grande" a tutti i livelli.
Il precoce esempio di Chicago, dove la nuova dimensione edilizia genera
la famosa "scuola" (vedi il classico di Carl Condit, The
Chicago School. The Rise of The Skyscraper, University of Chicago
Press, 1964 e, per una visione extra architettonica, Marco d'Eramo,
Il
maiale e il grattacielo. Chicago: una storia del nostro futuro,
Feltrinelli, 1995), trova la sua estrema radicalizzazione a New York.
È ancora Koolhaas (in Delirious
New York, Thames & Hudson, 1978) a percorrere retroattivamente
ragioni ed effetti della impressionante crescita dimensionale degli
edifici di Manhattan. Vi evidenzia soprattutto il ruolo fondamentale
della tecnica e del combinarsi di diverse soluzioni innovative sia in
campo costruttivo che impiantistico (per una analisi di alcuni esempi
recenti di grande dimensione vedi Richard Tomasetti, Virginia Fairweather,
Charles Thornton, Expressing
Structure. The Technology of Large-Scale Buildings, Birkhaüser,
2004; sulle scelte costruttive in grandi edifici dall'antichità
ai giorni nostri cfr. David Macaulay, Building
Big, Walter Lorraine Books, 2000). Struttura in acciaio, ascensore,
aria condizionata e luce al neon costituiscono i presupposti per la
realizzazione e il funzionamento dei grattacieli e per il loro status
di edifici "mutanti", non più controllabili attraverso
i paradigmi e gli strumenti della tradizione disciplinare. Il raggiungimento di una certa "massa critica" comporta infatti una serie di trasformazioni (o di destituzioni di senso) nel rapporto tra edificio e architettura che Koolhaas riassume all'inizio di Bigness: l'impossibilità di controllo compositivo della dismisura attraverso il gesto o più gesti architettonici; l'annullamento dei "caratteri distributivi" da parte della mobilità meccanica garantita dagli ascensori (la collocazione delle parti risulta, di fatto, indifferente); la "lobotomia" che interrompe il contatto tra interno ed esterno (la sezione dell'edificio raggiunge dimensioni tali da impedire sia il rapporto funzionale tra involucro e contenuto, risolto attraverso mezzi artificiali, che quello rappresentativo: troppe attività in rapporto alla superficie esterna disponibile); la non necessità della qualità estetica (la sola massa è sufficiente a garantirne l'impatto); l'autoreferenzialità ("fuck the context!"). Non solo, con l'aumentare della complessità di funzionamento, altri saperi tecnici, dotati di solidi statuti scientifici, si trovano a gestire porzioni maggioritarie del budget e a prendere decisioni dalle quali l'architetto dipende in misura sempre maggiore (vedi, sempre di Koolhaas, Last Apples in Id., S,M,L,XL, 010 Publishers, 1995). |
||||||||
| William Tsutsui, Godzilla on My Mind: Fifty Years of the King of Monsters, 2004 |
Carl
Condit, The Chicago School. The Rise of The Skyscraper, 1964 |
Marco d'Eramo, Il maiale e il grattacielo. Chicago: una storia del nostro futuro, 1995 |
||||||
| Rem
Koolhaas, Delirious New York, 2000 (1978) |
Richard
Tomasetti, Virginia Fairweather, Charles Thornton, Expressing
Structure. The Technology of Large-Scale Buildings, 2004 |
David
Macaulay, Building Big, 2000 |
||||||
| Rem
Koolhaas, Bruce Mau, S,M,L,XL, 1995 |
||||||||
| Di tutti questi aspetti, la produzione architettonica contemporanea sembra abbracciare solo l'intenzionale distacco dalle preesistenze. Alessandro Rocca (X-files. Oggetti non identificati sul pianeta architettura, in "Lotus", n. 100, 1999) rileva la pacificata monofunzionalità, la semplicità e l'ordine di recenti impianti sportivi, centri commerciali, infrastrutture ecc.: veri Gesamtkunstwerk che respingono ogni indeterminazione congestiva. Oggetti tuttavia che, per quanto voluminosi, probabilmente non sono abbastanza grandi per innescare quei processi evidenziati da Koolhaas e che oggi ritroviamo pienamente operanti nella ricostruzione delle torri gemelle. Qui, al gesto retorico e celebrativo di Libeskind, è stata infatti affiancata la garanzia "commerciale" di David Childs (vedi Matteo Agnoletto, Groundzero.exe. Costruire il vuoto, Kappa, 2004). | ||||||||

|
||||||||
| "Lotus", 100, 1999 |
Matteo
Agnoletto, Groundzero.exe. Costruire il vuoto, 2004 [Corbellini] |
|
||||||
| Il concetto di massa critica, che Koolhaas ha ripreso dalla fisica, emerge peraltro nei più vari fenomeni di crescita. D'Arcy Wentworth Thompson (On Growth and Form, Cambridge University Press, 1917) ne ha indagato modi e conseguenze riguardo alla biologia, rilevando il ruolo determinante della forza di gravità e di quello che Galileo aveva definito "principio di similitudine". La constatazione che una qualsiasi configurazione tridimensionale vede crescere superficie e volume rispettivamente con il quadrato e il cubo delle dimensioni lineari ha immediate conseguenze sulle forme costruite: per fare un ponte molto grande non si possono semplicemente ingrandire soluzioni materiali e geometrico-strutturali valide per luci minori. Una ovvietà tettonica rispetto alla quale il mondo disciplinare tende a opporre una certa resistenza, da un lato per l'aspirazione a far dimenticare, se non superare, ogni vincolo, dall'altro per l'assoluta ascalarità della composizione architettonica. La ferrea corrispondenza proporzionale tra gli elementi negli ordini classici (vedi voce "Échelle", in Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné de l'architecture française du 11. au 16. siècle, 1854-68) si perpetua nella costanza di contenuto compositivo riscontrabile in interventi dalle dimensioni anche estremamente diverse, tale che, ad esempio, l'articolazione della maison Savoye risulta, da questo punto di vista, equivalente se non superiore a quella del progetto per una città da tre milioni di abitanti (per analisi comparate nel campo dell'housing vedi il mio Uniformità e variazione. Lo spazio urbano nei quartieri contemporanei, Cluva, 1990). Questa attitudine "decorativa" (o di autosimilarità frattale) interviene anche nel fallimento dell'utopia megastrutturale (vedi, tra gli altri, Reyner Banham, Megastructure. Urban Futures of the Recent Past, Thames and Hudson, 1976). Il salto di scala operato nel tentativo di mantenere il controllo formale anche nella nuova dimensione si è infatti scontrato con la discontinuità del reale, con le soglie significative introdotte dall'accumulazione delle quantità in termini fisici, politici, economici, sociali ecc. Soglie determinanti nella produzione del pieno, come si è visto, ma anche nel funzionamento del vuoto, dove all'influenza della gravità si sostituisce quella della percezione (sugli spazi aperti vedi il mio Grande e veloce, Officina, 2000). | ||||||||
 |
||||||||
| D'Arcy Wentworth Thompson, On Growth and Form, 1917 |
Viollet-le-Duc,
Dictionnaire raisonné de l'architecture française
du 11. au 16. siècle, 1854-68 |
Giovanni
Corbellini, Uniformità e variazione. Lo spazio urbano nei
quartieri contemporanei, 1990 |
||||||
| Giovanni Corbellini, Grande e veloce, 2000 |
||||||||
| La ritirata, a partire dagli anni Ottanta, della larga maggioranza degli architetti nel frammentario o nel virtuale (cfr. ancora Bigness) si confronta paradossalmente con l'intensificarsi dei fenomeni di incremento dimensionale nei campi più diversi, testimoniato ad esempio dall'ingrandirsi delle opere d'arte ("If the average painting was 6 square feet in 1940, by the '80s has expanded to 40", Rem Koolhaas, Delirious No More, in "Wired", giugno 2003). Non si tratta tanto e solo di espressione di volontà di potenza, di possibilità tecniche e di appetiti speculativi, quanto di pressanti necessità di competizione globale, di processi di fusione, acquisizione e concentrazione economica (vedi Rem Koolhaas, Bigness & Velocity, in OMA@work, numero speciale di "A+U", maggio 2000), le cui immediate conseguenze sono visibili nel trasferimento in Asia della nuova frontiera della dismisura (sull'incredibile sviluppo edilizio cinese vedi Jeffrey Inaba, Rem Koolhaas, Sze Tsung Leong, Great Leap Forward. The Harvard Design School Project on the City, a cura di Chuihua Judy Chung, Taschen 2002). Anche qui alla crescita nel business corrisponde un parallelo incremento degli edifici grandi (ormai più alti e numerosi che in Nord America) e il comparire di alcune esperienze sperimentali e innovative, come quelle relative al grattacielo "ecologico" portate avanti da Ken Yeang (The Skyscraper, Bioclimatically Considered, Wiley-Academy, 1998; The Green Skyscraper. The Basis for Designing Sustainable Intensive Buildings, Prestel, 2000; Reinventing the Skyscraper. A Vertical Theory of Urban Design, 2002. Sul legame tra grande e verde vedi David Gissen, Big and Green. Toward Sustainable Architecture in the 21st Century, Princeton Architectural Press, 2002, e la mia "parola chiave" densità, 18.10.2003). | ||||||||
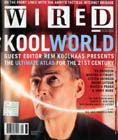
|
 |
|||||||
| "Wired", giugno 2003 |
"A+U",
maggio 2000 |
Jeffrey
Inaba, Rem Koolhaas, Sze Tsung Leong, Great Leap Forward. The
Harvard Design School Project on the City, a cura di Chuihua
Judy Chung, 2002 |
||||||
| Ken Yeang, The Skyscraper, Bioclimatically Considered, 1998 |
Ken
Yeang, The Green Skyscraper. The Basis for Designing Sustainable
Intensive Buildings, 2000 |
Ken
Yeang, Reinventing the Skyscraper. A Vertical Theory of Urban
Design, 2002 |
||||||
 |
||||||||
| David Gissen, Big and Green. Toward Sustainable Architecture in the 21st Century, 2002 |
"ANY",
9, 2004 [Davidson] |
Brendan
McGetrick, &&& art directors (editors), OMA/AMO, Content, 2004 [Aureli, Mastrigli] |
||||||
|
La complessità dinamica connessa a questi processi di concentrazione
richiede quindi, più che l'applicazione di strumenti propriamente
architettonici, una attitudine "urbanistica", capace di pensare
in termini di flussi, eventi, mutamenti e strategie. Ma è lo
stesso Koolhaas, iniziatore di questa visione della bigness (vedi -oltre
al monumentale S,M,L,XL- Urbanism vs Architecture. The
Bigness of Rem Koolhaas, "Any", n. 9, 1994), a evidenziarne
il difficile confronto con l'intrinseca rigidità dell'edificio
grande e a proporne oggi una interpretazione più problematica
(vedi il suo Content,
Taschen, 2004). Vicende professionali, come il progetto per la sede
della Universal, rimasto sulla carta anche per la velocità dei
mutamenti societari, e tragedie collettive (l'inevitabile 11 settembre)
ne modificano il qualche modo l'approccio, soprattutto nei confronti
del grattacielo, riavvolto su se stesso nella torre ad anello per la
tv di stato cinese (Cctv) o addirittura negato dal piano per un nuovo
centro di affari a Pechino, significativamente intitolato Kill the
Skyscraper... Giovanni Corbellini gcorbellini@units.it |
||||||||
| edizioni
italiane Roger Penrose, Il grande, il piccolo e la mente umana; con Abner Shimony, Nancy Cartwright, Stephen Hawking, a cura di Malcom Longair, R. Cortina, Milano 1998. Carl Condit, La scuola di Chicago. Nascita e sviluppo del grattacielo, Libreria Editrice Fiorentina, 1979. Rem Koolhaas, Delirious New York, Electa, Milano 2001. D'Arcy Wentworth Thompson, Crescita e forma, Bollati Boringhieri, Torino 1969. Eugène-Emmanuel Viollet-Le-Duc, L'architettura ragionata, Jaca Book, Milano 1981. Reyner Banham, Le tentazioni dell'architettura. Megastrutture, Laterza, Roma-Bari 1980. |
||||||||
| post
scriptum un interessante commento di Federico Bilò e diversi fra i pezzi di Rem Koolhaas sopra citati, tradotti in italiano, sono in: Antologia di testi su Bigness. Progetto e complessità artificiale, a cura di Federico Bilò, Kappa, 2004. sempre su Koolhaas e la bigness vedi l'ampia riflessione di: Gabriele Mastrigli, Il problema della grande dimensione, in "Parametro", n. 252-253, 2004. sulle conseguenze dell'attentato alle torri gemelle: Alessandro Rocca, La Bigness dopo l'undici settembre, in "Lotus", n. 112, 2002. sulle difficoltà e i fallimenti nel gestire la grande dimensione: Kenneth Kolson, Big Plans. The Allure and Folly of Urban Design, Johns Hopkins University Press, 2003. protagonisti della dilatazione in campo artistico: Coosje van Bruggen e Claes Oldenburg, Large-scale projects, 1977-1980, Rizzoli International, 1980. per una dimostrazione dei poteri della quantità: Critical Mass. Bicycling's defiant celebration, a cura di Chris Carlsson, AK Press, 2002 (ed. it. Feltrinelli, 2003) sulle architetture di grande luce: Chris Wilkinson, Supersheds. The Architecture of Long-Span, Large-Volume Buildings, Butterworth-Heinemann, 19952. sugli edifici a forte spessore prodotti da Giuseppe Samonà e dalla sua scuola vedi: Francesco Tentori, Imparare da Venezia, Officina, 1994. nella sterminata bibliografia sui grattacieli segnalo alcuni saggi "laterali" rispetto all'architettura: Daniel M. Abramson, Skyscraper Rivals, Princeton Architectural Press, 2000. George H. Douglas, Skyscrapers. A Social History of the Very Tall Building in America, McFarland & Company, 1996. Carol Willis, Form Follows Finance. Skyscrapers and Skylines in New York and Chicago, Princeton Architectural Press, 1995. Tom Shachtman, Skyscraper Dreams. The Great Real Estate Dynasties of New York, Little, Brown, 1991. una visione apocalittica e tribale della vita nel grattacielo è nel romanzo di: J.G. Ballard, High Rise, Jonathan Cape, 1975 (ed. it., Il condominio, Feltrinelli, 2003). |
||||||||
|
ARCH'IT
parole chiave laboratorio
|